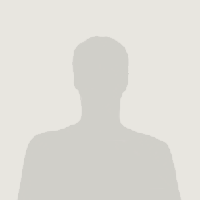È la Biennale del cartongesso: dall’entrata dell’Arsenale alla prima sala dell’edificio centrale dei giardini, dal padiglione del Marocco a quello della Spagna. E se quella iberica è la soluzione più elegante ed evocativa dell’arte contemporanea, il reimpiego di questo materiale da costruzione negli accessi ai due siti principali della mostra fornisce la chiave di lettura dell’intera esposizione. Nell’atrio delle Corderie, in particolare, i pannelli di gesso e i telai in alluminio della precedente Biennale d’Arte sono stati riusati dal curatore, il cileno Alejandro Aravena, per illustrare l’intero processo di produzione dell’esposizione: dall’incarico all’ideazione del tema, della scelta dei partecipanti al tour di presentazione, dalla progettazione dell’allestimento alla demolizione/ricostruzione delle sale.
Ri-uso, genialità, disvelamento, spiegazione, tutto in una stanza, una stanza che rivela quanto l’architettura sia trovare la soluzione giusta cercando di reinventare, letteralmente, l’esistente. Un incipit efficace, ci fa dire quel “Ah, ok!” con il quale si chiudono tutte le puntate della prima serie di Mi Vida Con Alejandro: la FacebookFiction di Luana Labriola che, con la sua iconografica ironia, ci ha preparato meglio di qualunque altra cosa a questa 15. Mostra Internazionale di Architettura, intitolata Reporting from the Front.
Sì, perché in quella prima stanza così riuscita, “tra immaginazione, storia e memoria” il corpo del curatore, come in un sacrario, dice “Presente!”. Non solo, ma per mezzo di una serie di efficaci quanto coscienti piccoli video, riformula la figura dell’architetto come comunicatore: la digitazione della notizia dell’incarico della curatela al resto dello studio, la meditativa valutazione dei dossier dei partecipanti in un vuoto ufficio sullo sfondo brumoso dell’orizzonte di una grande città latinoamericana; le discussioni con i collaboratori e il tracciamento delle conseguenze sui muri coperti di disegni; i viaggi in barca, le conferenze di presentazione; l’ascolto, in cantiere, dei consigli di Carlo Pallieri, quel imprescindibile maestro delle luci, senza il quale le Biennali non sarebbero mai la magia che appaiono.
“Devi essere presente nei media così che il politico, notoriamente spaventato da questi mezzi di comunicazione, nel prendere una decisione sceglierà colui che ha già una fama e un seguito”, spiegava Aravena qualche mese fa – in un giornale orchestrato da un celebre professionista italiano che di guai con la politica ne ha avuti un bel po’ – “Inizialmente questo non era affatto il mio atteggiamento. Fino al 2000 non ci sono mie foto ritratto, anzi avevo una specie di mantra: non avere foto. Poi ha fondato Elemental con un ingegnere, Andrés Iacobelli, il quale aveva immediatamente percepito che ciò che volevamo fare non era altro che un’operazione politica. Non è partecipando ai congressi che gli architetti faranno diventare la qualità una necessità, l’unico modo per influire sull’opinione pubblica, su coloro che votano, è utilizzare i media. Quindi si è trattato soltanto di una necessità, e ciò che rimane al di là dell’immagine è la capacità di comunicare in modo chiaro ciò a cui stai lavorando e credo che sarà importante anche in questa avventura della Biennale: riuscire a comunicare in modo ancora semplice senza perdere profondità”.
Necessità o strategia che sia, varcata la soglia la figura fisica del corpo dell’architetto scompare e non ritorna più quasi in nessuna declinazione lasciando lo spazio a una presentazione dell’arte del costruire esplicitata solo per esempi. È infatti questa una Biennale di progetti, ovvero un’esibizione nella quale domina la presentazione di interventi realizzati, sotto forma di saggi costruttivi, di volte (davvero numerose), di plastici, di modelli, di fotografie. Pochi i testi, scarse le piante…
L’atmosfera sembra quella dell’edizione di Chipperfield. Una mostra ordinata per nomi, distribuita nell’unità d’autore (studi e professionisti singoli), dove si scorge poco quell’articolazione in una decina di temi annunciata nelle presentazioni (inegualità, sostenibilità, traffico, waste, crimine inquinamento, comunità, migrazione, segregazione, disastri naturali, periferie, informale, qualità di vita). Dominano microambienti, rivestiti di materiali poveri e riciclati, ma anche sostenuti da costosi telai di acciaio. Casi eterogenei, dove alla presenza predominante di edifici e di residenze sociali, si associano anche costruzioni di prestigio e musei, come, ad esempio, la punta della Dogana di Tadao Ando.
Aravena aveva dichiarato in più di un’occasione che non intendeva essere un curatore, ma piuttosto un efficace “cane da tartufo dell’architettura”, capace di rintracciare la linea più avanzata della pratica professionale corrente: quei professionisti che “hanno preso il rischio di fare una proposta e non solo la diagnosi”. Tra i circa novanta invitati domina la presenza europea, che supera di poco il sessanta per cento, di cui un decimo italiani. Meno del venti per cento é riservato all’Asia, altrettanto all’America Latina. Una cifra che forse appare contenuta, ma che rivela lo spostamento d’asse difronte alla contenuta partecipazione del Nord-America, contenuto quasi del 5%. Africa e Oceania restano poco molto presenti, pur se per la prima compaiono numerosi edifici. Sorprende l’assenza totale del Medio Oriente, con l’eccezione forse di uno studio iraniano.
Ne esce una Biennale non lineare, comunque sempre interessantissima da visitare. Tante le ricerche interessanti come quella sulla città informale diretta da Rahul Mehrotra e quella sulla conservazione del patrimonio antico nell’epoca digiale, curata Brendan Cormier per il padiglione del Victoria &Albert Museum, nelle nuove sale delle Sale d’Armi. Tra le partecipazioni straniere, indipendenti dal curatore, Belgio e Spagna appaiono le più impegnate a raccoglierne però gli spunti, grazie alla riflessione sul tema del riuso degli elementi edilizi nel padiglione della prima e l’indagine sull’immenso patrimonio di progetti incompleti lasciati dalla crisi, in quello della seconda.
Caldo è anche il triangolo Canada – Germania – Corea, dove l’immagine green del paese nordamericano è messa in discussione dall’indagine sulle attività estrattive e la struttura ancora coloniale della loro gestione e il grande tema della riflessione sulla “città dei rifugiati”, che produce un cataclisma sul padiglione che non si vedeva dall’epoca nella quale Hans Haacke riempì di macerie l’edificio di matrice nazista.
La chiave di lettura di chi sia il nemico al quale si oppone il fronte, tutt’altro che compatto, dell’intera esposizione ce la da però proprio l’interessantissimo padiglione coreano, dedicato a mostrare l’impegno degli architetti di Seul nel “play the FAR game”, ovvero gli sforzi di ottenere il miglior uso possibile del “coefficiente d’occupazione del suolo,” o “indice della fabbricabilità”, tra vincoli normativi, costi, richieste del piccolo e medio committente, nel processo di progettazione quotidiana della realtà.
Il nemico non sono dunque le archistar o le costruzioni iconiche, e nemmeno la struttura corrotta e contraddittoria della società, ma il generico lassismo della produzione corrente; più che l’avidità, l’impazienza del capitale; l’ottusità e il conservatorismo della burocrazia e la loro tendenza a produrre ambienti banali, mediocri e monotoni.
Evergetismo e risoluzione disciplinare dei problemi sociali sembrano dunque essere in ultima istanza le soluzioni proposte da Aravena, non un cambiamento nella struttura della committenza, la costruzione di una diversa linea di commando, il cambiamento nel sistema produttivo della costruzione e di organizzazione dell’architettura, una visione non retorica dell’ecologia e la rinuncia a costruire per il riuso. Se gli americani, che con il loro sistema di premi basati sulla logica delle fondazioni glorificano la sua posizione, considerandolo l’ennesima reincarnazione di Howard Roark – l’eroe di The Fountained – e lo celebrano come ricostruttore di un intero paese, in Europa c’è chi – come Olivier Namias sul sito francese d’Architecture – elabora una precisissima disamina della struttura economica privatistica del suo studio, della sua ascesa al Pritzker e delle sue realizzazioni sociali, che ne mette pesantemente in discussione l’assunzione a modello.
Il dibattito resta aperto anche perché, se l’edizione precedente della Biennale correva parallela ma indifferente all’Expo, quest’anno essa si confronta invece con una collezione di manifestazioni dedicate all’architettura mai così ricca: dalle appena concluse Biennale di Chicago e Rotterdam, alla riaperta Triennale di Milano, alle imminenti triennali di Oslo e Lisbona, alla biennale del design di Istanbul, oltre al cruciale incontro di HABITAT III a Quito, la conferenza delle Nazioni Unite sull’abitazione e lo sviluppo sostenibile alla preparazione del quale la Biennale dedica un apposito padiglione, seguito da Richard Burdett.
È a questo livello, di confronto con altre esposizioni, che emerge la rilevanza di questa Biennale. Una manifestazione rispetto alla quale il curatore può perfino apparire irrilevante, perché episodico rispetto alla continuità dei valori dell’istituzione, ma il cui successo, al di là di quello che saranno i numeri, è già acclamato nella capacità di aver stabilito l’altezza a cui va posta l’asticella dell’emerging discourse in architettura. Perché se “non è partecipando ai congressi che gli architetti faranno diventare la qualità una necessità”, ma utilizzando i “media”, ciò che diventa cruciale è la credibilità delle istituzioni che presentano e organizzano il piano della discussione.
La Biennale mai si è fatta e mai si farà sponsorizzare da parte di una compagnia petrolifera, come accade per la nuova e Biennale di Chicago con la British Petroleum (quella stessa compagnia la cui presenza tra gli sponsor della National Gallery di Londra ha fatto scendere in campo gli attivisti anche la scorsa settimana ed è intellettualmente e politicamente combattuta da anni per l’influenza che gioca nell’istituzione della Tate). O ancora, non si riformulerebbe mai in senso regionale il tema dell’esposizione, come sta accadendo per la manifestazione norvegese, perché le risorse economiche dedicate alla cultura cominciano a ridursi per le mutazioni del mercato petrolifero. Tantomeno non si troverebbe mai nella pesante contraddizione politica dei curatori della Triennale di Istanbul, che non appena escono da Venezia (dove avevano ricevuto nell’ultima edizione una menzione speciale, che ora, grazie ai video di Aravena, sappiamo essere stata suggerita dal precedente curatore) propongono, con sconcertante incoscienza di fronte alle attuali condizioni politiche di quel paese, un’immorale riflessione intitolata Are We human?
In un mondo dove anche le accademie sono sempre più fatue, il fatto che la Biennale di Architettura determini comunque la svolta anti-immaginifica dell’architettura e trovi un curatore che per quanto professionalmente contraddittorio, consegni il gesto di demolire i muri in cartongesso dell’architettura di questi anni cominciando a re-impiegarli per far qualcosa di diverso, l’istituzione italiana dimostra un primato non tanto artistico, ma soprattutto etico a livello internazionale. Qualcosa di straordinariamente sorprendente in questo momento politico del nostro paese.
Di fronte a questo primo passo, forse ancora superficiale, non chiedetevi però cosa la Biennale di Architettura può fare per voi (voi che vorreste comparirvi, voi che vorreste esponesse la selezione dei vostri brani preferiti, o voi visitatori, che venite per trovarvi ricette facili e soluzioni pronto effetto da copiare), ma chiedetevi cosa voi potrete fare, stimolati dalla sua corporale seduzione…
(Fotografia di Andrea Pertoldeo)
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.