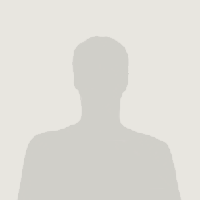Sentinella, a che punto è la notte?

“Deve passare la nottata” dice Eduardo, alias Gennaro Iovine, in Napoli Milionaria. Devono passare le buie ore della notte, per sapere se Rituccia, la più piccola dei suoi figli, riuscirà a superare la malattia. Una bambina da salvare e un’etica da ricostruire, nel disorientamento morale nel quale gli Iovine, e tutta Italia con loro, piombarono sotto i colpi della guerra e del fascismo.
Con lo stesso smarrimento di Gennaro Iovine, tutti noi aspettiamo da giorni che la nottata passi. Supereremo questa malattia? Sapremo farlo insieme, nel nome della solidarietà e della fratellanza, ricordando con Eduardo che “chi prima, chi dopo, ognuno deve bussare alla porta dell’altro”? O saremo sospinti nel vortice della paura individuale, nella tentazione di poterci salvare da soli? Come Donna Amalia, che seguendo la logica del “si salvi chi può”, dai piccoli traffici della borsa nera discende via via i gradini dell’abiezione, fino ad arrivare a mettere sul lastrico il proprio vicino di casa.
Dopo le prime settimane di chiusura delle scuole e i tentativi falliti di “spinte gentili”, siamo arrivati alla chiusura totale delle attività e agli attuali divieti di spostamento. Del resto abbiamo ancora negli occhi le immagini dell’irresponsabilità: la diffusa sottovalutazione che continuava a riempire le piste da sci, come i quartieri della movida; la miopia che spinge le aziende (l’imperfetto qui è fuori luogo) a resistere fino all’ultimo alla delocalizzazione casalinga dei lavoratori non essenziali; l’improvvidenza dei treni che dal Nord riversavano il contagio nelle regioni del Centro-Sud, ancora in buona misura non toccate.
Ma in fondo è così facile, così umano, illudersi, non voler guardare in faccia la materia bruta della realtà, soprattutto quando la minaccia, per un errore di prospettiva, sembra ancora lontana e letteralmente invisibile. Come notava Primo Levi, pensando ad altre minacce (umane troppo umane), se c’è un sentimento che è intrinseco nell’uomo che è in pericolo quello è la stupidità.
Se poi dalle piccole vite di ognuno, guardiamo al comportamento degli Stati e alla capacità di reazione delle nazioni, per non parlare di quel progetto senz’ali che è oggi l’Unione Europea, beh, troviamo ampia conferma all’osservazione di Levi. Manca una risposta coordinata, un agire composto di fronte al pericolo comune, ma anche, più modestamente, la semplice capacità di apprendere dall’esperienza di coloro che sono stati colpiti per primi.
Ma non è solo questione di stupidità. La nostra, si sa, è un’epoca improntata alla mobilità e alla continua accelerazione (tecnologica, sociale, dei ritmi di vita). Fermarsi, fermarsi tutti (o quasi) è uno scenario non concepibile, perché significa negare il principio dromologico della velocità e del movimento, su cui si basa l’intero edificio economico e sociale. Qualcosa di inimmaginabile, finché, appunto, non avviene. E così senza soluzione di continuità dall’alta febbre del fare – come la chiamava Pietro Ingrao – ci scopriamo radicati al nostro quartiere, in un tempo improvvisamente espanso e sospeso.
Aspettare, isolarsi, trincerarsi nelle proprie abitazioni per mistificare il nemico, confonderci con il paesaggio per lasciarlo solo e incapace di nuocere. Il distanziamento sociale come forma estrema di coesione sociale. Sembra un paradosso, e invece è un’attitudine che abbiamo imparato in fretta ad abbracciare (parola oggi intrisa di nostalgia).
E quindi #restiamoacasa, ma ricordiamoci che casa è una parola ambigua. In inglese possiamo tradurla sia come house che come home: la prima è l’abitazione, l’alloggio, il substrato concreto che ci ospita quotidianamente, mentre la seconda indica l’appartenenza, il luogo reale e mentale che sentiamo di abitare perché ci fa sentire bene. Ora, non sempre queste due accezioni convergono nella vita di ognuno. Per cominciare, non tutti hanno case spaziose, salubri, riscaldate e sufficientemente confortevoli dove vivere per settimane chiusi dentro. E poi, tralasciando questo aspetto materiale, non tutti abitano in nuclei familiari o di convivenza che sono in grado di assorbire le molte tensioni che produce questa situazione. Anche famiglia è una parola ambigua, altrimenti la storia della letteratura sarebbe molto breve (e quella del teatro brevissima). E poi a quale famiglia ci riferiamo, se una parte significativa degli italiani vive in nuclei unipersonali, ovvero da sola?
Quale idea di società ci consegna questa emergenza? Non è facile rispondere. La lotta al virus ci schiaccia su una concezione organicistica della società – l’immunità di gregge, il distanziamento sociale… – nella quale da cittadini liberi finiamo per essere considerati alla stregua di cellule da segregare. Ci troviamo costretti ad ubbidire o al contrario a infrangere consapevolmente divieti che rischiano di essere sempre più stringenti – con il retrogusto di una sinistra voglia di delazione – ma nel contempo, come ha sottolineato David Bidussa, riscopriamo la virtù che si produce dall’adesione consapevole alle norme (anche se limitano le nostre libertà), per perseguire l’obiettivo condivisibile di minimizzare le perdite e massimizzare le cure per tutti.

Le poison di René Magritte
Prima ho usato, quasi senza accorgermene, la parola nemico per connotare – e alla fine umanizzare – l’impercettibile virus che ci minaccia. Non è solo una metafora poco originale, dal momento che la retorica bellica in questi giorni è moneta corrente, a tutti i livelli. Dal presidente Macron – “siamo in guerra, una guerra sanitaria certamente: non lottiamo contro un esercito o contro un altro paese. Ma il nemico è qui, invisibile, inafferrabile, che avanza” – agli epidemiologi, dai sindaci ai medici impegnati negli ospedali. Non parliamo di catastrofe, come di fronte ad un terremoto, ma di uno scontro bellico nel quale siamo tutti mobilitati.
Consapevoli che la guerra ha ben altri connotati distruttivi e disgreganti (come sanno bene i siriani, che la stanno vivendo anche in questo preciso momento), dobbiamo ammettere che il parallelo con l’esperienza bellica esiste e sembra valido. Non tanto per le strade vuote, come prima di un bombardamento, o le file ai pochi negozi alimentari aperti. È la strutturazione segregata delle esperienze quotidiane e mentali che ricorda da vicino ciò che gli storici hanno ricostruito della prima guerra mondiale.
L’evocazione continua di una prima linea dove combattono allo stremo medici e personale sanitario – come i soldati di trincea incapaci di rendere fino in fondo a chi è rimasto a casa l’esperienza terribile e indicibile che stanno vivendo. Allo stesso modo di soldati caduti al fronte, subito sublimati nella categoria di eroi, i medici muoiono per mancanza di adeguate protezioni, mentre i generali decidono le strategie militari lontani dal campo di battaglia, come in ‘Orizzonti di gloria’ di Kubrick.
L’esistenza di una seconda linea più invisibile, dove operano a rischio i lavoratori dei settori essenziali (operai, commesse, addetti alla logistica e ai servizi inderogabili), che continuano a muoversi in un territorio mutato e inaccessibile ai più. E infine il fronte interno, nel senso proprio del termine, dove si colloca la grande maggioranza di noi che resta a casa. Ma il parallelo non finisce qui: siamo ancora dentro un paesaggio bellico quando tutti i giorni alle 18 ascoltiamo con ansia i quotidiani aggiornamenti dei morti e dei nuovi contagi, alla pari dei bollettini di guerra dello Stato Maggiore, numeri e cifre che – come in guerra – nascondono storie e volti, nuda individualità che ci perturba.
Siamo in guerra, ma il nemico non è solo invisibile. Il virus, l’essere-non essere della famiglia dei Coronaviridae che abbiamo imparato a chiamare SARS-CoV-2, probabilmente non si riconoscerebbe in questa definizione. Ci fa piacere vederla in questi termini guerreschi, ma la natura segue altre vie. I biologi ci spiegano che un frammento di RNA avvolto da una capsula proteica ha bisogno di un organismo ospite per riprodursi e restare attivo. L’organismo ospite adesso siamo noi, dopo che SARS-CoV-2, o meglio un suo progenitore, ha abbandonato l’animale precedente (probabilmente il pipistrello ferro di cavallo cinese, Rhinolophus sinicus) con il quale aveva una lunga frequentazione. Ed è proprio la mancanza di conoscenza reciproca a rendere così pericoloso il nostro incontro con SARS-CoV-2: lui ha bisogno di noi, noi con ogni evidenza non abbiamo bisogno di lui, ma i biologi pensano che col tempo impareremo a conoscerci meglio, adattandoci l’uno all’altro.
Se c’è un nemico, quello siamo noi. Nemici di noi stessi abbiamo stravolto e distrutto interi ecosistemi in vastissime zone del pianeta, espondendoci al contatto inconsapevole o addirittura cercato (come sembra sia avvenuto in questo caso) con animali selvatici sradicati dal loro ambiente. Ma anche l’agricoltura e l’allevamento industriali possono costituire situazioni che permettono e facilitano la diffusione dei virus, come riconosce David Quammen – il citatissimo autore di Spillover – in un’intervista al Tascabile.
Siamo sempre noi, non il virus, che abbiamo seguito politiche scellerate di tagli alla sanità e ai servizi pubblici, che abbiamo accettato modelli economici che hanno permesso l’esplosione delle disuguaglianze e delle precarietà, fino a ritrovarci ora ancora più fragili di fronte all’emergenza.
E così, nel tempo sospeso di questa attesa espansa, risuona una domanda, vecchia come il mondo: “Sentinella, a che punto è la notte?”. Non abbiamo ancora una risposta, come non l’aveva la sentinella del paese di Seir. Sappiamo che il giorno verrà, che il contagio si stabilizzerà per poi finalmente discendere e ridursi a poche unità – come è successo già in Cina e in Corea – ma non sappiamo quando, gli esperti e i modelli matematici non sono ancora in grado di dircelo. «Il mattino viene, ma è ancora notte! Se volete domandate, chiedete, tornate e domandate ancora».
E allora torniamo ad Eduardo. Il grande commediografo napoletano non ci dice se la piccola Rituccia si salverà, il sipario si chiude prima che il mattino sbocci. Eppure qualcosa in quel tempo sospeso d’attesa fremente succede. La famiglia Iovine, spazzata dalla guerra, sfibrata e dispersa moralmente – il figlio che ruba, la madre che strozzina, la figlia grande rimasta incinta di un soldato americano ormai partito – si ritrova unita nel tinello di casa (di fronte all’immancabile tazza di caffè). Ha da passa’ ‘a nuttata. Ma intanto una nuova vita sta già prendendo forma.
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.