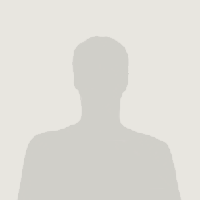Di quale politica si parla in Italia quando si parla di politica?
Qualsiasi organizzazione democratica – e per democratica si intende l’eguaglianza assoluta degli aderenti secondo il principio “uno vale uno” – è fatalmente destinata a diventare oligarchica. È destinata cioè a dividersi tra rappresentanti e rappresentati, comandanti e comandati, condottieri e condotti, dominatori e dominati. Sono molte le cause che determinano questo fenomeno che il suo scopritore, il sociologo dei partiti politici Robert Michels, definisce una “evoluzione retrograda” meglio dire un’involuzione. Elenchiamole: a) cause meccaniche, ossia impossibilità dell’autogoverno delle masse; b) cause psicologiche, ossia sete di potere e di dominio dei capi: per quanto gli individui nutrano forti idealità o facciano parte di una comunità rivolta al bene, immessi in una organizzazione si trasformano fatalmente in competitori, spesso spietati; c) cause organizzative: in una organizzazione complessa si pone la necessità di una divisone del lavoro, “chi fa che cosa”; e già in questa semplice divisione di compiti si nasconde un principio gerarchico indefettibile, perché un conto è parlare nelle assemblee, circondati da aura mediatica, un altro, come avveniva nel movimento studentesco organizzato, ciclostilare i volantini, seppur da “angeli del ciclostile”. Tutto ciò sarà un’evoluzione retrograda, ma mette al centro la questione centrale di ogni regime politico: chi decide? ovvero: chi comanda?
Dall’orizzontalità alla verticalità
Il passaggio da una comunità di perfetti liberi e uguali a una gerarchica avviene nel momento stesso in cui gli uguali (spesso provenienti dal movimento fondativo, dove si viveva in “fusione”, come dice lo studioso dei movimenti collettivi Francesco Alberoni) si organizzano. È nel passaggio dal movimento all’istituzione – e dunque all’organizzazione – che si passa dall’orizzontalità alla verticalità. L’organizzazione è verticistica; non esistono organizzazioni orizzontali. Neanche in natura, vedi i favi, i formicai, i branchi della savana. Solo nella comunità giovanile dei pari non c’è gerarchia, ma è anche vero che non c’è in essa condivisone di intenti o di scopo tranne quelli di stare assieme; eppure anche in essa spesso si forma una leadership, anche solo per scegliere la pizzeria. Pur se sottoposta a turnazione, la leadership, ossia il comando, esiste e decide in qualsiasi organizzazione a carattere strumentale, e, in quel preciso momento, fatalmente, “uno diventa più eguale di uno”. È il momento in cui una democrazia si trasforma in una aristocrazia: la formazione di una élite coincide con la formazione della leadership infatti. Da ora in poi nell’ex organismo democratico c’è chi decide (comanda) e chi obbedisce. Il Movimento studentesco, la più forte organizzazione democratica nata negli anni ’60, fondata sul mito della democrazia assembleare diretta, pullulava di leaderini.
I partiti italiani prima del ‘92
Esemplare ai fini del discorso “oligarchico” il caso dei partiti politici italiani. Ho cercato di comprendere come funzionano e come si forma in essi la funzione di comando (leadership). Prima del ’92 quasi tutti i partiti erano strutturati in una forma-partito: militanti-iscritti, tessere, congressi, finanziamento pubblico, stampa di partito, intellettuali organici. La democrazia italiana era sostanziata dai partiti e dalla forma-partito, come in tutto il mondo, e con qualche particolarità peninsulare che ci chiederebbe troppo tempo a divisare. Com’erano questi partiti dal punto di vista democratico? Né più né meno che delle consorterie o delle oligarchie più o meno organizzate, ma cementate da ideologie forti, delle vere e proprie fedi popolari: principalmente quella internazionalista socialcomunista, quella cattolico-atlantica e quella nostalgico- fascista. Assente o del tutto ininfluente la componente liberale o liberaldemocratica. (Ancora di là da venire il partito liberale di massa solo promesso da Berlusconi). Tutti i partiti agivano secondo un metodo difforme da quello “democratico” invocato sibillinamente dalla Costituzione (art. 49 mai declinato in leggi specifiche). Le elezioni interne nei congressi, che si tenevano sia a livello locale che centrale, erano quasi sempre una farsa; il tesseramento gonfiato alterava il reale numero degli iscritti, e la leadership dei capicorrente decideva la sorte della leadership dell’intero partito (indimenticabili i conciliaboli segreti nel convento delle Dorotee dove nacque la corrente dorotea della DC o il congresso del Midas del PSI). Si trattasse di “centralismo democratico” (un bell’ossimoro, uno tra i tanti) o di “correnti” più o meno strutturate, erano alcuni capi a decidere e una massa di militanti-iscritti obbediente a eseguire, dopo “ampia discussione”. Il metodo privilegiato era perciò non l’elezione ma la cooptazione. C’erano dei politici di professione che sceglievano in cordate o in correnti altri politici di professione (classica la figura del “delfino” di un leader politico), senza il consenso dei militanti iscritti o con il loro consenso manovrato. Nei partiti vigeva cioè quella che Michels chiamava la “ferrea legge dell’oligarchia”: delle minoranze coscienti, non un re, ma tanti piccoli re. Un’aristocrazia più o meno legittima.
Le due crisi in cui ancora siamo immersi
Nel 1992, con Tengentopoli, la democrazia italiana conobbe contestualmente due crisi. Il partito tradizionale fu scosso dalle fondamenta e l’antipolitica, ossia la cieca azione politica che lo contestò e lo sconfisse, mise in crisi anche la leadership permanente, ossia l’idea stessa di “classe politica”. Gli italiani, caduti nel gorgo di una crisi morale oltre che economica drammatica, contestarono cioè sia la forma-partito sia la classe politica, radicalmente: il partito in quanto ritenuto responsabile della degenerazione partitocratica, la classe politica in quanto non degna di mantenersi o perpetuarsi perché ritenuta prevalentemente corrotta.
Vivere di politica o per la politica?
Prima di trattare la questione della crisi della forma-partito vorrei spendere due parole sulla negazione-delegittimazione della classe politica che mi sembra fenomeno involutivo e particolarmente foriero di complicazioni future. Al fine di sconfiggere il cancro della corruzione – di certo un fatto reale ma non più grave però di quello di certi settori della stessa società civile – si diffuse presso la stragrande maggioranza dei cittadini la convinzione che i mandati dei politici dovessero essere a termine: cinque o massimo dieci-quindici anni di permanenza nel ruolo, poi “a casa”, si diceva. Ci fu un’antipolitica sia di destra che di sinistra che confluì in questo sentimento collettivo, che pescava più che nelle delusioni cocenti suscitate dalla classe politica, nel fondo anarchico dei connazionali, nel desiderio torbido e impossibile di un autogoverno, ove come diceva Leopardi “ognuno fa tuono a sé” (leggi: si fa i fatti propri) che negava la stessa funzione della politica e faceva sparire nel nulla gli odiati politici. I quali invece sino a quel momento non avevano fatto altro che riverberare i costumi dei connazionali stessi in una concezione malata quanto si vuole ma di reale rispecchiamento tra governanti e governati che confermava paradossalmente i principi democratici – tali gli elettori tali gli eletti – ma travolgeva il concetto stesso di democrazia rappresentativa, ossia delega politica a rappresentanti politici negli interessi generali del popolo. I politici, a partire dagli anni ’70, cominciarono a non puntare più ad avere il consenso – con i buoni programmi e la buona politica – per avere il potere, ma a puntare direttamente al potere per ottenere poi, attraverso la spesa pubblica, il consenso. Si dimostrò in ogni caso vera l’asserzione di Gaetano Salvemini secondo il quale il rapporto tra Paese legale (politici) e Paese reale (cittadini) è questo: per il dieci per cento il Paese legale è migliore del Paese reale, per il dieci per cento peggiore, per il resto è il Paese.
Ma forte fu l’impulso di ridurre i politici a pane e acqua eliminando il finanziamento pubblico (che oggi mentre scrivo è stato ripristinato col tacito e furbesco consenso del leader Renzi che aveva fatto fuori i precedenti leader del partito brandendo proprio la causa dell’abolizione del finanziamento pubblico: evidentemente si sarà accorto che con le cene non si pagano le segretarie) o di sottoporli a una rotazione continua e forsennata negando un sensato accumulo di esperienze e un tranquillo ritorno alla vita civile, non certo agevole per chi aveva dedicato lustri centrali della vita giovanile o adulta alla politica, mentre i coetanei si avviavano a profittevoli professioni.
Venne negata dai connazionali l’idea secolare che la politica è una professione specialistica, richiedente, al pari di altre professioni, un noviziato, un duro tirocinio e una dedizione totale che talvolta racchiude un’intera esistenza. Si diffuse invece presso l’opinione che i politici dovessero essere e vivere come dei missionari, loro e soltanto loro, non come dei professionisti della politica. Per gli italiani la vecchia distinzione weberiana: vivere per la politica e vivere di politica, significò essere solo la prima opzione un atto signorile, mentre la seconda una scelta ignobile. Dimenticarono che una figura a loro molto vicina, il prete, vive anche di fede (battesimi, comunioni, funerali) oltre che per la fede. Sfuggì nella concezione della politica esercitata als Beruf (come professione), secondo l’impostazione di Max Weber e dell’etica protestante introdotta da Lutero, che Beruf in tedesco significa vocazione professionale e che il termine implica pertanto due “possibili” narrativi, due paradigmi di vita racchiudibili in un’unica esistenza: una vocazione che è una professione e viceversa. Sottigliezze inattingibili per un popolo in collera che indicava nei partiti politici e nella politica l’origine di tutti i propri guai.
Dai leader di partito al partito del leader
Dopo il 1992 solo il Partito democratico fu l’unico a mantenere (orgogliosamente o temerariamente) la dicitura di partito. Nato nel 2007 dalle ceneri di due partiti, il Pd aspira tuttora a organizzare la propria azione politica espressamente come partito. Tutti gli altri partiti – ché tali sono nei fatti essendo delle “parti” della politica nazionale – hanno rinunciato alla parola ma non alla cosa, e aborrono dal presentarsi come tali. Da SEL ai radicali al movimento dei grillini, alla Lega, al partito ieri Pdl, ieri ancora Cdl, oggi Forza Italia, a “Scelta civica”, la parola partito è semplicemente sparita. E con essa il “metodo democratico”, parrebbe.
Sono dei partiti personali si cominciò a dire, o dei partiti carismatici, scomodando Max Weber. In realtà, tali partiti personali nascondono la forma-corte, essendo la corte il modello con il quale si organizzava il consenso e il potere prima che con la rivoluzione inglese e quella francese nascessero i partiti nell’accezione moderna. Tali partiti sono delle monarchie di fatto, con dei re e con altri notabili di contorno, delle Versailles dove c’è un Re-Sole che comanda graziosamente attorniato da stelle (l’immagine è classica) che acquistano visibilità o vengono in auge a seconda del grado di vicinanza al monarca, il quale per altro verso esercita particolari diritti speciali di prelievo di risorse sessuali presso la pletora delle/degli eligendi. Non solo Berlusconi per cui l’immagine del monarca è assolutamente icastica avendo (avuto) una corte vera e propria ad Arcore con non pochi nani e ballerine, ma anche Pannella, Grillo-Casaleggio, Salvini oggi ieri Maroni o Bossi, una volta Di Pietro, Casini ecc. si comportano allo stesso modo: rex-lex. Tutti gli organi statutari (per chi ha lo statuto: c’è infatti chi esibisce orgogliosamente un non-statuto come nella Alice di Carroll c’è un non-compleanno) in questi partiti-non-partiti gli organi statutari, si diceva, sono in ombra o non funzionanti, salvo riemergere nei momenti di crisi della leadership del monarca di turno: quando dovette espellere Fini, Berlusconi rispolverò a termini di statuto Collegi di Probiviri mai visti prima. Neanche i Radicali italiani, ossia coloro i quali si sono battuti più di ogni altro contro la degenerazione partitocratica, sfuggono alla “ferrea legge dell’oligarchia”: organizzano periodici congressi, eleggono un segretario o portavoce (perlopiù maschio e piacente) che spesso altro non è che un re merovingio ossia un re fantasma che viene manovrato dal vero comes palatii (conte di palazzo), il fondatore Pannella, che può decidere di non farlo contare, come è già successo, con un semplice ringhio o di umiliare pubblicamente la vecchia sodale Bonino sol perché lo contestava per “intrighi” di Palazzo su cui è meglio sorvolare, in quanto non interessano l’ambito delle analisi di teoria politica ma rimandano a epoche lontane, alla vita di Socrate forse.
Il rompicapo delle primarie
Ben presto, tuttavia, anche in seno al partito democratico sono sorti problemi scottanti. La difficoltà in cui si dibatte il Pd nell’organizzare la sua nuova forma-partito (qualcosa che reca in sé la logomachia correntizia della vecchia Dc, ma aspira al centralismo democratico del vecchio Pci) è insita nella formula sfuggente del cosiddetto “metodo democratico” cui si dovrebbero aspirare i partiti al loro interno secondo la Costituzione (art.49). Cosa vorrà mai dire “metodo democratico”? Metodo elettivo? Abbiamo visto che fatalmente una organizzazione democratica si trasforma in una oligarchia. Spesso il metodo democratico applicato a un partito ci dice, grazie anche a statuti fumosi o contraddittori, come si conquista un potere (anche Mussolini e Hitler furono eletti) non come lo si mantiene o come lo si perde. Inoltre: come consentire al partito di esprimere il leader e come impedire al leader di trasformare il partito che lo ha eletto in un “partito del leader”? Queste sono oggi le maggiori preoccupazioni sul tappeto di questa formazione politica.
È stato il fantasioso professore e uomo politico Arturo Parisi dell’entourage di Romani Prodi a introdurre nella prassi politica del centro-sinistra (prima dell’Unione poi del Pd), a partire dal 2005, l’elezione, attraverso delle consultazioni interne dette primarie, dei candidati ai più disparati ruoli politici: dai sindaci dei comuni ai presidenti delle regioni, ai deputati nazionali, al segretario del partito tout court.
Forse l’intenzione del Professor Parisi era quella di sperimentare un metodo alternativo ai vecchi congressi e delle vecchie oligarchie riguardo l’elezione del Segretario del partito; un metodo elettivo contrapposto alle cooptazioni di cordata tradizionali. Fatto sta che il nuovo “metodo democratico” delle primarie ha destato una scia di perplessità quasi tutte fondate. La prima, il fatto che siano state aperte non solo al partito ma alla coalizione in lizza (col risultato che spesso è stato un esponente di un partito più piccolo a vincere: felice esito a Milano con Pisapia, non altrove); che fossero aperte non ai soli iscritti ma a tutti i cittadini, con il bel risultato che fossero esponenti di centro-destra ad “aiutare” in maniere occulta o esplicita, e comunque paradossale, i candidati del centro-sinistra; che infine fossero aperte anche ai cittadini extra-comunitari, con il risultato, esperito in diretta, che nel mio comune della cintura milanese vincesse un esponente di SEL ma con i voti decisivi di 50 simpatici filippini che pur non avendo il diritto di voto hanno nei fatti scelto il sindaco per il quale non potevano votare. Non ultimo le primarie sono esposte al rischio “Barabba”, che in sé è un rischio della democrazia tout court, di eleggere ossia esponenti della società civile sì ma totalmente incapaci e non i Gesù Cristo di cui abbiamo bisogno. Gli apparati dei partiti saranno corrotti o destinati a corrompersi ma sono stati fino alla prima repubblica i bacini di formazione di intere classi dirigenti politiche non sempre malvagie, tranne l’ultimo scorcio della Repubblica.
Conclusione
In conclusione abbiamo oggi almeno tre sistemi all’interno della vita politica dei partiti italiani che fatalmente sboccano tutti e tre, in diverso modo, ossia con tassi più o meno marcati di “democraticità”, nella fatale “oligarchia”. Il sistema “corte” (Berlusconi o Pannella); il sistema delle primarie, il meno oligarchico tra tutti, prescelto dal Partito Democratico che si dibatte tuttora tra metodi elettivi palesi e apparati oligarchici vecchi e nuovi occulti e in lotta tra di loro; e il sistema dell’uno vale uno del M5s, in cui deciderebbe “democraticamente “ la rete. Su quest’ultima variante oligarchica ci sarebbe da aggiungere che il meccanismo della selezione della leadership (come ho notato qui) è altrettanto opaco che altrove, se non di più, addirittura misterioso: fintantoché non sarà possibile a terzi di accedere ai server in cui si designano gli eligendi e si votano i rappresentanti, c’è da supporre che la diarchia (ancor più rarefatta di una oligarchia!) Grillo-Casaleggio, faccia e disfaccia, ponga e disponga a proprio piacimento; e se non ex ante, sicuramente ex post, avendo un potere di cassazione piuttosto evidente rispetto a leadership sgradite o arrogandosi “graziosamente” il diritto di indicare quella che più piace a loro come stava per succedere nel recente passato con il fedelissimo Di Maio.
Ma occorre anche essere sinceri. Se il principio oligarchico appare fatale («ferrea legge dell’oligarchia», ricordiamo, la definiva Michels questa tendenza) va da sé che ciò accade perché la democrazia diretta è per adesso impossibile. Per altro verso tale democrazia diretta, per l’obiezione “Barabba” di cui sopra, non ci garantirà mai che al potere giunga la “classe politica” che tutti si aspettano specie in periodi di crisi come quello che viviamo, competente e illuminata, in ogni caso in grado a governare realtà complesse come quelle di paesi occidentali con economie altrettanto complesse.
Quanto alle oligarchie, adottando esse il metodo della cooptazione più che quello dell’elezione (o dell’elezione dentro la cooptazione, come sono state le ultime primarie del Pd per l’elezione dei deputati al Parlamento nazionale del 2013), non sono in se stesse malvagie, se, disgraziatamente invece dei più bravi non scegliessero, come sempre accade, i più fedeli e i più acquiescenti e spesso ancor più mediocri di una selezione in ipotesi affidata al caso. Il tema della qualità nella quantità non è di facile soluzione. Gobetti era molto fiducioso quando scriveva, in “Rivoluzione liberale”, della democrazia rappresentativa in questi termini: «Il processo di genesi dell’élite è nettamente democratico: il popolo, anzi le varie classi sociali, offrono nelle aristocrazie che le rappresentano la misura della loro forza e della loro originalità». Io sarei più cauto.
Non c’è un “metodo democratico” funzionante bell’e pronto che riesca cioè a rappresentare e a “eligere“, selezionare cioè, la qualità nella quantità: bisogna ancora inventarlo o forse rinunciarvi saggiamente per sempre. In altre parole è ancora tutto da escogitare un metodo che garantisca la qualità delle élite (magari attraverso la cooptazione) in armonia con la democrazia delle masse, che eviti il modello-corte e che schivi il caos permanente. Per agire in questa direzione occorrerebbe davvero portare la fantasia al potere, fare uno sforzo particolare di immaginazione politica, immaginazione che neanche il Sessantotto con le sue utopie e partendo da assemblee ossessivamente democratiche ma finendo per esprimere vari capetti e leaderini, è riuscita a insediare sul trono della democrazia decidente.
Qui ancora siamo.
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.