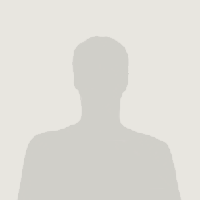Il premio Nobel della letteratura 2016 è stato assegnato a Bob Dylan: «Per aver creato una nuova espressione poetica nell’ambito della tradizione della grande canzone americana», è la motivazione data dal Comitato dei Nobel dell’Accademia Svedese. Lo celebriamo riproponendo questo ritratto pubblicato in occasione del suo 75esimo compleanno, nel maggio del 2016
————-
“Inside the museum, infinity goes upon trade” (“All’interno del museo, l’infinito viene sottoposto a giudizio”, Visions of Johanna, 1966)
“L’uomo non è del tutto se stesso quando parla di sé. Dategli una maschera e vi dirà la verità”. (Oscar Wilde)
Bob Dylan compie oggi settantacinque anni e celebrare questa ricorrenza scrivendone è uno dei compiti più ingrati che possano venire in mente. Non tanto – non solo – perché si parla di uno dei Grandi Antichi della popular music novecentesca, di un padre fondatore come i Beatles e pochi altri, di uno che ha traghettato l’America delle Battaglie Civili nel Pop, passaggio epocale che qualche sparuto soldato giapponese nella giungla ancora considera un tradimento e che è invece è la chiave di volta degli Anni Sessanta; di uno su cui si è scritto tutto il contrario di tutto, e che tutti hanno sempre cercato di tradurre forzatamente in un’icona, in un simbolo, in una ideologia. Sempre delusi, al massimo protagonisti di momentanee vittorie, spesso inservibili a distanza di mesi.
No, il rischio non è tanto quello di dire ovvietà. La difficoltà risiede soprattutto nel fatto che Dylan è stato, ed è tuttora, uno dei personaggi più sfuggenti della cultura moderna. Uno che, secondo alcuni, ha sempre cercato di fuggire in primo luogo da sé stesso, e poi da tutti quelli che gli sono corsi dietro per strappare anche solo un lembo di leggenda. Un susseguirsi di maschere dietro cui si è sempre nascosto, omericamente parlando, un moderno Nessuno. Non esiste nessun Bob Dylan, forse fino ad un certo punto è esistito Robert Zimmermann (ma anche l’anagrafe, alla fine, ha dovuto cedere), però esistono molti Dylan. Todd Heynes, autore dell’unico film possibile su di lui, I’m Not There (“non ci sono, non sono qui”, come nella canzone omonima), ha capito la lezione: ogni volta che si riesce a togliergli la maschera si resta con un pugno di mosche, e allora l’unico modo di raccontarlo è fare ricorso a molteplici Dylan, ciascuno interpretato da un attore diverso.
Se tutto questo alone mitologico può talvolta sembrare eccessivo, non bisogna dimenticare che è stato lo stesso Dylan, fin da giovanissimo, a costruire la propria mitologia, a inventare se stesso. Il myth making, reinvenzione leggendaria del proprio passato, era pratica comune nella tradizione blues, tanto che quando il giovanissimo Dylan si inventava colossali panzane, di aver suonato con questo o quel bluesman nel corso di una improbabile adolescenza girovaga alla ricerca dei maestri della musica afroamericana, costoro stavano al gioco e nessuno lo smentiva.
Ma ad un certo punto il myth making non bastò più, e qual è il modo migliore per alimentare il mito, quando si diventa una star, se non scomparire, sottrarsi all’attenzione? Era il 1966, l’era di Masters of War sembrava lontana millenni, il Nostro aveva via via sostituito i brani “a tema” dei giorni pacifisti del Greenwich Village (secondo alcuni comprendendo con largo anticipo che al massimo si sarebbe potuta portata a casa una nobile ma inevitabile sconfitta da parte della Storia) con un linguaggio poetico sempre più fiammeggiante e visionario, introducendo elettricità e amplificatori in una musica che era diventata ben presto puro e semplice rock’n’roll, ma un rock’n’roll molto più potente e molto meno ingenuo di quello delle origini, che cavalcava il costante mutamento, in una stagione in cui gli anni valevano decenni. Superando a sinistra i Byrds che pure erano stati, nell’inventare il folk rock attraverso le sue canzoni, fondamentali nell’alimentarne l’ascesa.
Blonde on Blonde, che proprio in questi giorni festeggia il suo cinquantesimo anniversario, fu l’apice di quel percorso, registrato al termine di un tour epocale caratterizzato dal continuo braccio di ferro con un pubblico che con molta riluttanza, e spesso protestando rumorosamente, assisteva alla trasformazione del Profeta del Mondo Nuovo in Rockstar. Senza inizialmente ammettere di essere stato conquistato da tanto ardire. Un incidente di moto, che ovviamente fornì lo spunto a infinite speculazioni, gli consentì di riparare nel buen retiro rurale di Woodstock, profondo entroterra dello stato di New York, risucchiato in un apparente e bucolico oblio. Curandosi le ferite provocate da una corsa troppo veloce, in ogni senso, Dylan diventò una presenza occulta ma ancora più persistente nell’immaginario. Nel suo passare dal pubblico al privato si immerse con i fedelissimi della Band negli archetipi della popular music americana, precursore di tutte le retromanie a venire, e le canzoni registrate in quelle session informali, affidate poi a interpreti di ogni tipo, invasero le classifiche.
Nei cinquant’anni trascorsi nel frattempo, Dylan ha, con alterne fasi di popolarità, continuato a cambiare maschera. Sempre. Lasciando il dubbio che risiedesse proprio in questo continuo turbinio la sua vera anima, e che non si trattasse solamente di un gioco tra gatto e topo con le aspettative dei fan. Nei Settanta, dopo una vituperata svolta country, osteggiata non tanto per la sua imperfezione artistica quanto per l’aver ribadito, ancora una volta, che la stagione dell’impegno era finita (facendosi pure beffe, nell’ostentatamente pacchiano Self Portrait, “autoritratto” scientemente fuorviante, di chi ancora una volta avrebbe voluto incasellarlo), Dylan tornò sui palchi, e ad un certo punto si inventò la Thunder Review, recupero itinerante dello spirito libero dei Sessanta dove l’unico a non sembrare il residuo di un’epoca lontana era proprio lui. Ritornò beniamino della critica con il capolavoro Blood on the Tracks, doloroso, amaro e poetico diario pubblico del divorzio da Sara Lownds (la “sad eyed lady of the lowlands” dell’omonima canzone di Blonde on Blonde), si convertì per un breve periodo, lui ebreo poco praticante, ad un cristianesimo che abbracciò con lo zelo del neoconvertito. Vissuti gli anni Ottanta tra alti e bassi, e chiusi in gloria con il celebrato Oh Mercy, nei Novanta fu ospite di un concerto celebrativo ricco di star del passato e del presente, con una voce berciante e fragile – la recupererà più avanti – che non prometteva nulla di buono e pareva quasi volersi prendere gioco della messa laica in suo onore.
Verso la fine del decennio e con l’approssimarsi di un nuovo millennio Dylan, che potrebbe tranquillamente limitarsi al ruolo di curatore della propria vicenda artistica, come del resto fanno quasi tutti i suoi coetanei, parallelamente ad un never ending tour che ancora prosegue, sembra voler invece assumere il ruolo di memoria storica. Rovistando nell’anteguerra della sua memoria e negli albori del suo interesse per la musica, quasi in una continuazione con altri mezzi della ricerca delle radici delle basement tapes con la Band. Curando trasmissioni radiofoniche in cui viene fuori l’appassionato filologo. Registrando nel 2012 un disco intero di pezzi del repertorio di Frank Sinatra, andando a pescare in quell’immaginario anche per Fallen Angels, album di imminente uscita.
D’accordo, parliamo di un settantacinquenne che non deve più dimostrare niente a nessuno (anche se questo discorso si potrebbe estendere almeno agli ultimi quattro decenni), che non ha bisogno di pubblicare dischi autografi e che può divertirsi come meglio crede. Ma non c’è solo questo. Dylan non è mai stato messo in un museo né ci è voluto entrare, ma ha voluto diventare lui stesso il curatore della tradizione che lo ha espresso. Alle proprie condizioni, ovviamente, è diventato una specie di Smithsonian Institute umano. Probabilmente si tratta della maschera definitiva, il Custode della Memoria. O forse no.
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.