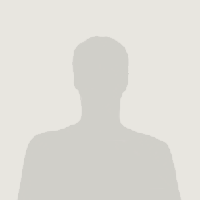Sfortunati e di fatto ignoti alla gran parte dei loro contemporanei, e allo stesso tempo influenza decisiva per gruppi che nei decenni successivi avrebbero venduto milioni di copie (i R.E.M.). Formatisi troppo tardi per riuscire a cavalcare l’onda lunga dei Beatles e il sogno californiano di Byrds e Beach Boys, e troppo presto per mettersi alla guida dell’ondata power pop di fine anni Settanta che avevano indubbiamente ispirato. Una faccenda di tempistiche sballate, la vicenda dei Big Star. Ma anche e soprattutto di luoghi e persone, di concomitanze sfortunate e sliding doors. La band di Memphis, Tennessee, tra i tanti artisti sepolti ai lati delle strade lastricate di buone intenzioni che affollano la storia della musica pop, rappresenta con buona probabilità il nome di culto definitivo.
A differenza di altri grandi destinati all’oblio, come l’inglese Nick Drake, schiacciato tra il desiderio di comunicare la propria visione ai contemporanei e un carattere involuto, impossibilitato a mettere in pratica qualsiasi strategia promozionale, i Big Star di Alex Chilton hanno sempre cercato di ottenere la visibilità che erano convinti di meritare, fin dalla scelta di una così impegnativa ragione sociale (ironica ma fino ad un certo punto: lo spunto lo forniva l’insegna al neon di una catena di supermercati), e di intitolare il loro primo album #1 Record, da intendere come prima posizione in classifica e non, più banalmente, come primo capitolo di un percorso discografico.
Un documentario del 2013 su di loro, Nothing Can Hurt Me, diretto da Drew De Nicola e Olivia Mori, esce in queste settimane – su Universal – in una edizione DVD deluxe il cui sottotitolo è eloquente: “la storia definitiva della più grande band che non è riuscita a farcela”. L’uscita comprende anche i primi due dischi gruppo, pubblicati tra il 1972 e il 1974, note di copertina a cura di Mike Mills dei R.E.M. e fornisce lo spunto per raccontare ancora una volta la peculiare vicenda del complesso. Tanto più che negli ultimi cinque anni, dopo la prematura scomparsa di Chilton nel 2010, le iniziative legate alla band, tra tributi, concerti e uscite d’archivio, si sono moltiplicate: il nome dei Big Star circola oggi come non mai, e non – più – solo tra i convertiti di stretta osservanza.
I luoghi in cui si svolge la vicenda, come dicevamo, sono decisivi tanto quanto le tempistiche. Nello specifico Memphis, Tennessee, capitale musicale del profondo Sud degli States, la città di Elvis Presley e della Stax, fertilissimo crocevia di musiche e culture agli antipodi della vicina Nashville, quest’ultima patria bianca e conservatrice del country. L’intreccio di tradizioni bianche e afroamericane è alla base del suono dei Box Tops, di cui Chilton è l’adolescente frontman: una boy band ante litteram che nel mescolare rock, pop e rhythm’n’blues produce hit planetarie come The Letter. Il successo si traduce in scarsi guadagni e stress causato dagli impossibili ritmi promozionali e concertistici. Troppo giovane per godersi la fama, Chilton si convince tuttavia di poter giocare la carta della carriera solista, ma nessun discografico sembra interessato al suo esordio, che riemergerà da qualche scaffale solamente negli anni 90.
Intanto però il cantante e chitarrista ha incominciato a bazzicare gli Ardent Studios, fondati da John Fry, personaggio chiave di questa storia: si tratta di studi di registrazione all’avanguardia, tanto che al principio dei Settanta la Stax, etichetta soul e r’n’b in pieno boom, affiderà a Fry e ai suoi ingegneri del suono la registrazione di una parte del proprio catalogo. Qui Chilton incontra Chris Bell, talentuoso coetaneo con la fissa per i Beatles; con l’arrivo del bassista Andy Hummel e del batterista Jody Stephens nascono i Big Star, che registrano nel 1972 #1 Record. La piccola ma agguerrita macchina promozionale della Ardent si scontra tuttavia con la già citata Stax, con la quale è stato siglato un contratto di distribuzione: quattro giovani bianchi sulle orme dei Beatles che l’etichetta, specializzata in black music, non sa bene come promuovere e gestire. Risultato: recensioni entusiastiche, ma estrema difficoltà nel trovare il disco nei negozi e poche, pochissime copie vendute.
Il buco nell’acqua ha pesanti strascichi, e il primo a cedere è Bell, coautore di quasi tutti i brani, che oltretutto si sente spodestato da Chilton. Figura di culto all’interno del culto stesso, Bell soffre di depressione, si rifugia nelle droghe, lavora nel ristorante del padre, e cerca infine, con il sostegno del fratello, di far decollare una carriera solista trasferendosi momentaneamente a Londra. Nessuno però è interessato ai nastri che incide laggiù con Geoff Emerick, uno degli ingegneri del suono di fiducia dei Beatles. Da quelle registrazioni viene tratto un unico singolo, pubblicato nel 1978 da una minuscola etichetta newyorchese, nel disinteresse pressoché generale. Poco dopo, nel dicembre dello stesso anno, Bell muore in un incidente d’auto. I Am The Cosmos, album postumo pubblicato nel 1990 e pochi mesi fa ristampato in una versione espansa, è l’ennesimo disco di culto di questa storia.
I Big Star, dopo un periodo di sbando, procedono senza di lui. A convincere Chilton e gli altri che non è finita, e che è il caso di tornare a calcare i palchi e gli studi, un avvenimento dalle valenze fortemente simboliche. Il management della Ardent ha invitato a Memphis tutte le firme del giornalismo musicale statunitense, organizzando una convention di “rock writers”: mossa non del tutto disinteressata, rivolta a professionisti in quel momento poco tutelati, certamente, con lo scopo di dare loro una mano ad organizzarsi, ma soprattutto con l’obbiettivo di far conoscere le specialità della casa. E il piatto forte è il concerto dei redivivi Big Star. In uno dei momenti più illuminanti del documentario viene rievocata la serata: di fronte ad un pubblico di addetti ai lavori che li sostiene da sempre, e che al gruppo riconosce una purezza e una attitudine da “ritorno alle origini” che non riesce più a trovare altrove in quel 1973 (arriverà il punk, pochi anni dopo, a incarnare il bisogno di dare aria alle stanze di un rock ormai troppo involuto e malato di gigantismo), i Big Star diventano finalmente delle stelle.
Forti dell’investitura della crema del giornalismo rock, i nostri pubblicano nel 1974 Radio City. L’ennesimo successo di critica, e l’ennesima doccia gelata, cui concorrono i guai finanziari in cui è incappata la Stax: la maggior parte delle copie del disco non lascerà mai il magazzino. Da lì in poi si apre un periodo che definire caotico è un eufemismo: droghe, alcool, esperimenti in studio spericolati e disperati che tuttavia portano ad una struggente, a tratti autolesionista, intensità. Il miracoloso equilibrio tra il senso di illimitata possibilità proprio dell’adolescenza e la sua controparte più cupa e riflessiva, che fino ad allora ha alimentato le canzoni, incomincia ad essere sbilanciato verso la seconda. Third/Sister Lovers esce quasi nell’anonimato nel 1978, ed è un disco doloroso da ascoltare, ma sarà proprio la sua imperfetta vulnerabilità, la sua fragile spigolosità, a creare un legame emotivo fortissimo con le propaggini più scure e intimiste della new wave degli anni Ottanta, con l’indie rock che prende orgogliosamente coscienza di sé in quello stesso decennio e con un certo angst generazionale proprio degli anni Novanta.
A cavallo tra anni Settanta e Ottanta i dischi della band incominciano a germogliare nel sottobosco dell’underground, da entrambe le sponde dell’Atlantico. Inimmaginabili i R.E.M., il gruppo che porterà l’esperienza del rock indipendente anni Ottanta al successo mainstream, senza di loro, per stessa ammissione dei georgiani. Interpellato nel documentario, l’inglese Robyn Hitchcock offre una definizione perfetta di quello che ha rappresentato il gruppo di Chilton in quel decennio: “un lettera spedita nel 1971 e consegnata nel 1985”. Lo scostante e spigoloso Chilton, dopo un periodo buio caratterizzato da droghe e alcool, durante il quale ha inciso dischi solisti a volte cupi e ostici, a volte all’insegna di un rock piuttosto tradizionale, e ha prodotto gruppi (i Cramps, tra i tanti), decide ad un certo punto, sorprendendo tutti, di riesumare l’antica ragione sociale, nei confronti della quale non aveva mai espresso troppa nostalgia. È il ’93 e a convincerlo a riportare i Big Star in vita sono due fan sfegatati, Jon Auer e Ken Stringfellow, il secondo dei quali vanta una lunga collaborazione proprio con i R.E.M. La band che i due hanno formato qualche anno prima, i Posies, appartiene anch’essa alla schiera dei discepoli.
La nuova vita del gruppo culmina con un onesto quarto album intitolato In Space, nel 2005. Chilton ormai sembra a suo agio nel ruolo di scorbutico padrino del rock indipendente, e i suoi demoni sembrano essersi un po’ tranquillizzati. Il finale di Nothing Can Hurt Me è triste, perché questa storia non prevede lieto fine, ma emotivamente fortissimo: è il 2010, e al South By Southwest, festival texano che è un appuntamento ineludibile per gli appassionati di musica indipendente di tutto il pianeta, è prevista una data dei Big Star. Che non ci sarà: Chilton muore improvvisamente qualche giorno prima per un infarto. Il concerto si trasforma in tributo, e le telecamere che si soffermano sui preparativi della estemporanea iniziativa catturano la commozione degli adepti, tutti uniti da una musica che è stata faccenda per pochi, ma questi pochi – seguaci, star affermate, meteore – ne sono rimasti segnati per sempre.
Non solo musicisti. Il breve discorso tenuto al congresso dal deputato democratico Steve Cohen, ripreso nelle ultime battute del documentario, il 10 marzo del 2010, pur condito dall’inevitabile spruzzata di retorica, arriva dritto al punto ed è la perfetta sintesi di una parabola unica e per certi versi paradigmatica: “Oggi sono qui di fronte a voi con un peso sul cuore perché un mio amico, un grande amico della musica e in particolare della musica proveniente dalla mia città di origine, Memphis, nel Tennessee, Alex Chilton, è mancato la notte scorsa. Alex Chilton all’età di 16 anni è finito in cima alle classifiche con un gruppo chiamato The Box Tops, e con una canzone intitolata The Letter, poi ha formato un gruppo chiamato Big Star. I Big Star non erano molto conosciuti. Hanno fatto tre album, ma ‘Rolling Stone’ li ha inseriti tutti e tre nella top 500 degli album prodotti in America. È stato una incarnazione della musica di Memphis: dura, diversa, indipendente, brillante, bella. Siamo stati fortunati che abbia incrociato la nostra strada”.
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.