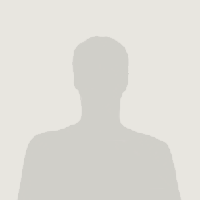Il passaggio segreto del cambiamento

Caro cigno nero,
Da un po’ di tempo avverto quasi uno scollamento tra ciò che penso e ciò che faccio, tra pensieri e comportamenti. La situazione è insostenibile, per i continui ripensamenti, per la sfiducia, lo sconforto, la rabbia. Non si tratta di depressione, dal momento che ho ancora progettualità, ma direi che sono prossimo alla stagnazione. È vero che qualsiasi momento è buono per migliorarsi, per sentirsi curiosi del nuovo e attivi ad ogni età. Ma mi riesce difficile avviare un vero e proprio cambiamento, soprattutto per il rischio che ogni sperimentazione comporta. Per non parlare poi dei condizionamenti in cui si viene imprigionati dalla propria storia. Cambiare radicalmente il modo di pensare e di vedere le cose o vivere certe emozioni prestando più attenzione alle relazioni con gli altri? Trasformarsi interiormente o modificare i comportamenti? È importante scegliere consapevolmente il cambiamento o basta rispettare una pura necessità?
Giano
Caro Giano,
se ti sei soffermato a interrogarti sulla possibilità di un cambiamento molto probabilmente hai avvertito, in questa fase della tua vita, il bisogno di andare oltre il “sono fatto così”. Ed è proprio con questa definizione, a cui restiamo caparbiamente ancorati e in cui crediamo di riassumere la nostra intera storia, che ci precludiamo la possibilità di conoscerci davvero. Una definizione che Montaigne non avrebbe mai usato per sé né per l’intero genere umano, e il motivo ce lo spiega nei Saggi, più di mille pagine in cui dipinge sé stesso non come essere ma come passaggio, di giorno in giorno, di minuto in minuto; un racconto che si costruisce su una doppia oscillazione: la nostra di soggetti mutevoli, istantanei, e quella del mondo intorno a noi, una perpetua altalena dove tutto cambia, tutto si muove incessantemente. Che ne è allora di quel “sono fatto così” se niente resta uguale a com’era, se voltandoci indietro con lo sguardo del ricordo non possiamo non scorgere parti di noi che non ci appartengono più, se il nostro stesso io muta, pur non rinnegando la sua forma precedente? Potremmo forse dire “sono diventato così”, consapevoli però del fatto che anche questo modo di definirci ha una sua data di scadenza. E se è impossibile sottrarsi al cambiamento, perché quella data di scadenza non vogliamo vederla? Perché in fondo in quel “sono fatto così” cerchiamo di custodirci per sottrarci alla precarietà del tutto, per poterci ancora riconoscere nonostante lo scorrere del tempo.
Che le cose cambino intorno a noi può spaventare, ma quello che spaventa di più è sentire che qualcosa è cambiato in noi, perché questo ci obbliga a dare ospitalità a ciò che non ci è familiare, che non lo è ancora quantomeno, a differenza di quanto di noi sapevamo prima.
A dispetto di quello che crediamo, l’identità non sta nell’immobilità, di pensieri e convinzioni. Infatti, nonostante quella data di scadenza, e anche se – come dice Montaigne – siamo collocati sempre “al di là di noi stessi”, esiste un nucleo che mantiene traccia di noi, che continua a raccontarci nel trascorrere dei giorni, e lo fa proprio a partire dai cambiamenti, quasi per contrasto potremmo dire.
Proprio perché esprimono un dilemma, le tue domande disegnano l’immagine di un passaggio, quello tra un dentro e un fuori, che però è obbligato, continuo e a doppio senso, non certo un aut aut. I cambiamenti interiori sono sempre il risultato di eventi ed esperienze che avvengono fuori di noi, sono incontro, e spesso anche scontro, con altro e altri da noi; così come ciò che avviene fuori non può non influenzare il modo di viverci e percepirci. Senza quel passaggio, insomma, la nostra identità non esisterebbe affatto.
Cambiare il modo di agire senza cambiare le idee che lo alimentano o i nostri pensieri significherebbe perciò limitarsi a recitare una parte, che, per quanto bravi possiamo essere come attori, finirebbe col farci sentire estranei a noi stessi. È questa, credo, la sensazione di cui parli quando dici di avvertire uno scollamento tra ciò che pensi e ciò che fai. Quando accade di non trovare più corrispondenza tra quello che pensiamo o sentiamo e il modo in cui ci comportiamo, quel nucleo che ci permette di riconoscerci, anche nelle trasformazioni, sembra sgretolarsi. Ed è qui che diventa necessario ripensarsi. Così quello scollamento, pur con il corredo di sofferenza che ha portato, è la prova che dei cambiamenti possiamo anche essere artefici, o addirittura artigiani, per via della cura che richiedono. E la cura, lo sappiamo, vuole un tempo lento. La stagnazione in cui temi di trovarti allora potrebbe essere paradossalmente una sosta necessaria per una trasformazione consapevole, non della tua identità, ma di quel frammento in cui non senti di riconoscerti più.
Se ci pensiamo, il cambiamento ha qualcosa in comune con l’inquietudine: il movimento. Solo che nell’inquietudine non c’è una vera e propria direzione, poiché il suo unico obiettivo è quello di toglierci da dove siamo, da dove non riusciamo a stare o restare. La direzione dei cambiamenti invece la scopriamo grazie alle domande, alla capacità di interrogarci e di interrogare il mondo intorno a noi. E, a proposito di domande: che rapporto abbiamo con i cambiamenti? Passiamo dal volere che le cose restino come sono quando tutto va bene, all’essere assaliti dalla smania di cambiarle se non rispondono all’idea che ce ne siamo fatti.
Per quel che ci riguarda cambiamo solo se non abbiamo altra scelta, per adattarci all’imprevisto, o magari perché siamo stati feriti troppo a lungo o troppo profondamente. Il più delle volte, infatti, resistere al cambiamento ci fa sentire meglio ancorati a noi stessi, perché in noi possiamo riporre fiducia se “ci conosciamo”. Poi però andiamo alla ricerca del nuovo per sfuggire alla routine, alla noia dell’abitudine: cerchiamo la novità fuori di noi, negli incontri occasionali, nella collezione di esperienze a cui mettiamo una data di scadenza. Perché lo facciamo? Ancora una volta, perché niente deve intaccare il modo in cui siamo fatti, il nostro porto sicuro. Possiamo distrarci ma non ricostruirci. Eppure lo abbiamo fatto quella volta in cui un dolore ci ha costretti a rimettere insieme i pezzi, e nel ricomporci abbiamo visto i nostri punti deboli nelle ferite ancora aperte, ma anche la nostra forza nella volontà di ricominciare o cambiare direzione; o ancora quella volta che abbiamo trovato in noi un diverso modo di amare. Tutti momenti in cui eravamo noi stessi ma abbiamo scoperto di essere anche altro.
Quando non ci diamo la possibilità di conoscerci davvero, anche grazie agli altri, succede che ci identifichiamo nella ripetizione di comportamenti o nel modo sempre uguale di gestire emozioni e relazioni, nonostante tutto ciò possa rivelarsi svantaggioso o addirittura dannoso. Sforzandoci di resistere al cambiamento mettiamo in scena una coazione a ripetere che è innanzitutto difesa, dal giudizio degli altri, dalla delusione che sta nella fiducia mal riposta, da quel diverso per cui ci sentiamo impreparati.
Il “sono fatto così” ci dà l’illusione di conoscerci, e sicuramente la conosciamo bene quella precisa parte di noi, perché è lì che ci siamo definiti, scontornati con una precisione chirurgica, tanto da rendere impossibile quel passaggio che è scoperta dell’altro di noi negli incontri con l’altro da noi. Arroccarsi nel “sono fatto così”, infatti, non aggiunge niente alla relazione, perché presuppone che tutte le relazioni vissute si equivalgono, e si equivalgono a partire da una sola prospettiva.
Allora potremmo far diventare quel “sono fatto così” non un monito ma una premessa da cui partire. E non per farci influenzare o condizionare, ma per permetterci di leggerci in altro modo, senza restare troppo imbrigliati in ciò che già sappiamo di noi.
E qui sta la grande differenza tra cambiare per gli altri e cambiare grazie agli altri: nel secondo caso lo si fa insieme.
Ognuno di noi ha il suo io che resiste al divenire incessante di tutto, ma ha anche in sé la possibilità di essere molto altro. Nel bene e nel male. Sta a noi scegliere in che direzione andare.
Il nome con cui ti firmi ha nel suo significato il movimento, derivando dal verbo latino “ire”, cioè andare. Nello specifico, il volto bifronte di Giano rappresenta simbolicamente il momento del transito tra ciò che è stato e ciò che sarà. Questo nome significa però anche porta (in latino “ianua“), e senza porta non esisterebbe nessun passaggio. Ma chi può decidere che fare di quella porta – tenerla chiusa, socchiusa o aperta – se non noi stessi, che ne custodiamo la chiave?
Maria Luisa Petruccelli
Per scrivere al Cigno Nero: lapostadelcignonero@gmail.com
Ogni secondo e quarto venerdì del mese pubblicheremo le vostre mail.
Chi scrive accetta di vedere pubblicato quanto invia.
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.