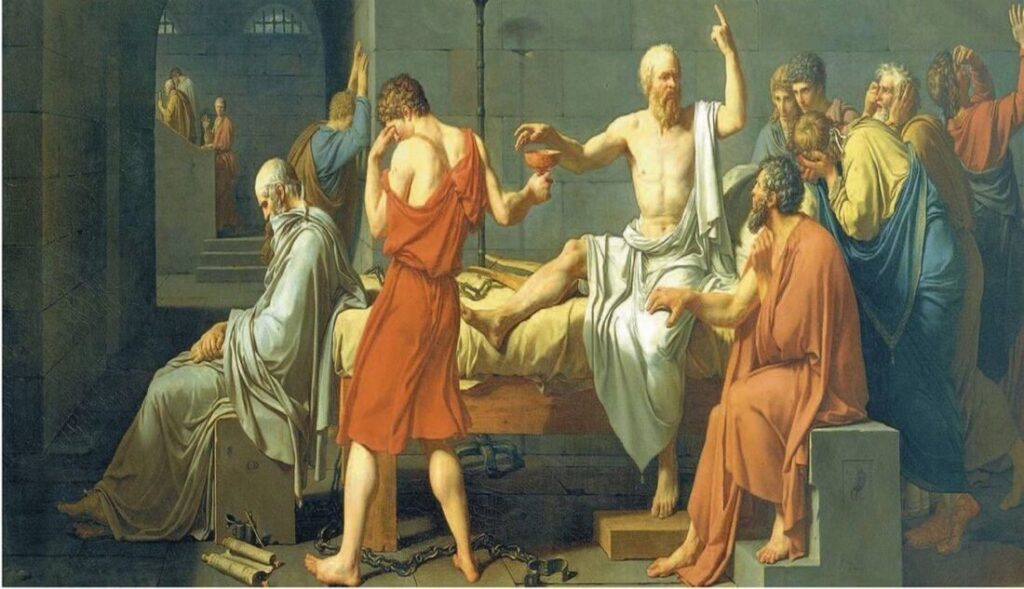
Italia
Inagibilità politica e comunicazione tossica
Inutile girarci intorno: sono anni che la politica si è conformata come una disciplina dove il ragionamento lineare non è più indispensabile per prendere posizioni e assumersi responsabilità, decretando una sorta di cretinismo istituzionale.
La comunicazione, a ogni livello e da qualsiasi parte politica provenga, rende tossico ogni argomento. Che si tratti del genocidio del popolo palestinese, dell’omicidio di un odiatore americano, o il suicidio di un adolescente del basso Lazio, l’accento e i contenuti sono sempre gli stessi: una ripetitiva maniera di allestire congetture infeste viene propagandata a valanga sui giornali, sui social, nei talk televisivi e finanche nei tg, dove ogni notizia, anche la più ermetica, dovrebbe essere scevra da ogni perniciosa interpretazione. Si predica amore, in spregio dell’odio, usando parole e atteggiamenti contrari a ogni forma di rispetto per il prossimo, in una forma che offende il principio stesso di riguardo e attenzione per l’interlocutore. E la parte politica che sta al governo della nazione, ossia gli amici e i complici del criminale Netanyahu, i fautori della violenza più inaudita e spregevole, i venditori delle armi che hanno abbattuto migliaia di bambini gazawi, invita la parte antagonista ad abbassare i toni, ritenendola responsabile di ripristinare un clima di tensione sociale riconducibile ai tempi delle Brigate Rosse. Inutile girarci intorno: sono anni che la politica si è conformata come una disciplina dove il ragionamento lineare non è più indispensabile per prendere posizioni e assumersi responsabilità, decretando una sorta di cretinismo istituzionale, sempre intriso di quella furbizia che distingue la disonestà di ogni tempo, che nella più totale confusione e incapacità gestisce un potere fine a se stesso, a protezione di interessi particolari e mai collettivi, come quelli, per esempio, di ministri e ministre che hanno frodato lo Stato per decine di milioni di euro. Salvini e Santanché docet! Dovremmo tutti chiederci se nel frangente storico che stiamo vivendo esistono delle possibilità di reagire efficacemente, per evitare di soccombere al sentimento di un’impotenza finale. In altre parole, siamo davvero in grado e messi nelle condizioni di produrre azioni che si muovano nella direzione dei nostri desideri? Come possiamo in qualche modo sentirci fruttuosi e avere un minimo di certezza che il paese nel quale viviamo non sia destinato al peggio, se, più o meno quotidianamente, il dibattito pubblico è affidato a fini pensatori che a stento riescono a collegare una frase all’altra, ma che riescono bene, invece, nel comunicare risentimento e disprezzo per chi non assume la loro stessa posizione ideologica?
Intorno ai fatti di cronaca si può ragionare accampando ragioni e sentimenti di appartenenza: ideali, religioni e provenienza possono rendere limitata e faziosa qualsiasi congettura, anche la riflessione più austera che si prefigge l’assoluta correttezza di analisi. Argomentare nella complessità delle diramazioni a tema, e, dunque, sulla forza, la violenza e la disumanità imperante dei nostri giorni senza correre il rischio di attingere a luoghi comuni e a convinzioni sbagliate, richiede una compostezza lessicale e una rigidità morale non facilmente accessibili, che solo gli storici rispettosi della logica del metodo possono raggiungere. Ecco perché, di recente, sono ricorso allo studio di due donne di straordinario talento, per trovare spiegazioni ai fenomeni dell’attualità: Simone Weil e Marguerite Duras. Le due umaniste muovendo da prospettive diverse sono riuscite ad avvicinarsi all’argomento con la grazia e la capacità di scavare a fondo, garantite da un genio cristallino di assoluto valore: Le considerazioni che Simone Weil fa della guerra, della forza e della violenza in genere, distinguendole tra loro, sono incentrate sulla ricerca della purezza dell’affettuosità, contrapponendo alla suggestione perversa del conflitto la realtà dell’amore. Simone è stata una pacifista non estranea ai campi di battaglia, che allo scoppio della guerra civile spagnola si è arruolata nelle colonne degli antifascisti libertari e ha partecipato alla Resistenza francese, quasi a cercare nell’esperienza bellica una sorta di decontaminazione del male. Un tentativo da cui rimase profondamente delusa che la portò ad assumere, successivamente, un atteggiamento di totale repulsione per ogni guerra. Marguerite Duras, invece, pone la sua attenzione al lato disumanizzante e devastante della violenza, proponendo in special modo nell’opera, La douleur, una visione della brutalità che non riserva spazio a nessuna redenzione e purificazione, che coinvolge e macchia tutti, nessuno escluso. Ecco, probabilmente, le analisi diverse delle due studiose novecentesche rappresentano, oggi, rispetto alle guerre in corso e alla cronaca più nefasta, la prospettiva di maggiore pregnanza da cui partire per giungere ad analisi attendibili e, soprattutto, a nutrire una speranza protetta dal buon senso dell’indagine meticolosa e della libera riflessione.





Devi fare login per commentare
Accedi