Mondo
L’inedito movimento contro il genocidio in Palestina
Nelle ultime settimane si sono susseguite in tantissime città d’Italia manifestazioni, mobilitazioni e presidi in difesa della Sumud Foltilla e contro il genocidio a Gaza. Si è trattato di un ampio movimento, in larga parte spontaneo, sostenuto da associazioni, sindacati, partiti politici e movimenti, che – dopo mesi di mobilitazione dal basso – hanno preso coscienza anche a livello nazionale, dell’importanza di questa battaglia. Non che esponenti delle singole realtà non si fossero già ampiamente mobilitati in passato, ma l’escalation di violenze e di barbarie degli ultimi mesi ha reso impossibile una mancata presa di posizione. Qualcuno in queste settimane ha paragonato le piazze d’Italia di questi anni venti del nuovo secolo alle piazze del movimento per il Vietnam, che fra la fine degli anni Sessanta e l’inizio degli anni Settanta. Un paragone sicuramente evocativo ma che non tiene conto della profonda diversità di contesto – qui in occidente – fra le due epoche, che rende per certi versi inedito il movimento per Gaza. Gli anni Sessanta hanno infatti rappresentato il grande periodo del movimento politico dal basso in Italia. Studenti e lavoratori uniti nella lotta, i collettivi, le battaglie per i grandi diritti civili come divorzio e aborto, avevano coinvolto in modo trasversale e intergenerazionale il Paese. Destra e sinistra occupavano le piazze e il dibattito pubblico, non semplicemente attraverso lo schermo e i giornali, nei volti dei politici del tempo, ma nei cortei e nelle assemblee, nei picchietti e nei comizi di piazza. Il posizionamento politico, a prescindere dalla sfera di appartenenza e dal grado di coinvolgimento attivo, era un presupposto quotidiano per il vivere “pubblico” di larga parte delle persone. A partire dagli anni Ottanta invece, il disimpegno individualistico – figlio degli anni di piombo, tanto quanto dell’avvento di un nuovo clima socio-culturale – ha segnato un grande fermo in termini di impegno e interesse per il “pubblico”. Il ritirarsi nel privato ha portato a una delega sempre più ampia ai rappresentanti – siano essi partiti, sindacati, associazioni – e meno corpi in piazza. Un discorso generale, che meriterebbe maggiori approfondimenti, ma che – fatto salvo alcune brevi stagioni di mobilitazione – l’Onda universitaria dei primi anni Duemila, il movimento Se non ora quando ad esempio – le piazze sono rimaste appannaggio di brevi mobilitazioni organizzate da soggetti – in senso ampio – politici. E veniamo a oggi.
Le piazze per Gaza partono dal basso e lo fanno, a differenza del Vietnam, non sulla scorta di un posizionamento di fronti del blocco USA/Blocco comunista, ma sulla scia di un impegno di carattere umano, prima ancora che umanitario. Partono sicuramente da una fetta di popolazione da tempo sensibilizzata sulla questione palestinese ma, in brevissimo tempo e soprattutto anche grazie ai social network, strumento potentissimo di diffusione delle notizie, di immagini e video direttamente dai territori interessati prima al conflitto e poi al genocidio, si estende alla maggioranza della popolazione scesa in piazza. Persone senza una tessera di partito in tasca, spesso non sindacalizzate, che hanno deciso di dedicare il loro tempo – e sacrificare parte del loro stipendio in fase di sciopero – al sostegno a una battaglia di diritti umani. A differenza del Vietnam la questione politica occidentale resta sullo sfondo. I partiti parzialmente hanno preso parte al movimento, ma come aderenti a un input arrivato dal basso. Il mestiere che, peraltro, da sempre gli competerebbe. Un altro importante elemento di riflessione – e di differenza sostanziale rispetto alle battaglie per il Vietnam ad esempio – e la modalità di mobilitazione. Le persone si sono mosse sulla scorta di informazioni che hanno viaggiato in larga parte su nuovi canali, con un approccio corale e condiviso all’informazione. Le stesse manifestazioni sono state documentate dal basso, rendendo impossibile una narrazione riduttiva del movimento in atto. Partendo dall’impossibilità di un’informazione realmente neutra, la diretta ha reso anche più difficile confondere le “proporzioni”. A differenza dell’ormai lontano G8 ad esempio, non è stato possibile gonfiare il numero dei cosiddetti contestatori facinorosi, minimizzando la presenza dei pacifisti in corteo. Anche a fronte di alcune narrazioni che hanno accentuato l’elemento del danno arrecato da una minoranza di manifestanti a beni e strutture in alcune città, le migliaia di testimonianza di cortei pacifici, con bambini e famiglie, ha restituito profondità e complessità al momento che stiamo vivendo. Le persone si mobilitano, lo fanno trasversalmente e per cause che non li riguardano in prima persona, ma che sono vissute e sentite – come deve essere – come universali. Anche in passato le strade si sono riempite in nome dei diritti, ma in questo caso il richiamo all’elemento universale ha risvegliato qualcosa di ancora più profondo della lotta in difesa di uno specifico bisogno sociale. Siamo di fronte a qualcosa di nuovo e inedito, che meriterebbe davvero una riflessione da parte di partiti e movimenti. Purtroppo tutto questo nasce sulla scorta di un genocidio che sarà ricordato nei libri di storia.

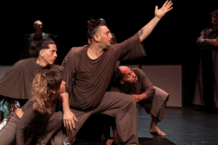

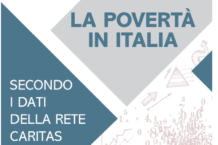

Devi fare login per commentare
Accedi