
Milano
Una politica che non crede più nel pubblico
A Milano aleggia da tempo un tema che raramente viene affrontato in modo esplicito: la sensazione diffusa che la città si sviluppi secondo dinamiche che la politica osserva o asseconda più di quanto governi. Il dibattito pubblico si concentra sugli effetti – disuguaglianze, rendita, espulsione dei ceti medi – ma molto meno sulle cause che rendono questi esiti quasi inevitabili: e sono cause culturali. Prima ancora che una questione di strumenti, risorse o rapporti di forza, che ovviamente hanno il loro peso, siamo di fronte a una questione di idee: di ciò che la politica ritiene legittimo, possibile o persino pensabile fare attraverso le istituzioni pubbliche.
Individuare le radici culturali di questa auto-limitazione è decisivo. Non si tratta semplicemente di vincoli esterni o di impotenza amministrativa, ma di una visione interiorizzata del ruolo pubblico che precede l’azione e ne restringe l’orizzonte. Una visione che oggi non appartiene più solo o principalmente alla burocrazia, ma alla politica stessa.
Quando entra nelle istituzioni, la politica porta con sé una convinzione forse inconscia ma profonda: che le istituzioni e la pubblica amministrazione non solo non possano, ma non debbano promuovere direttamente lo sviluppo. Lo sviluppo, in questa prospettiva, è materia propria del mercato; il pubblico può al massimo regolare, facilitare, rendere “attrattivo” il contesto. Non è dunque solo la macchina amministrativa a sottrarsi o a non potere esercitare il ruolo di attore in molti settori, ma la politica a non chiederle di esercitarlo.
Questa convinzione non è né naturale né neutra. È il prodotto di una lunga sedimentazione culturale che, negli ultimi decenni, ha permeato classi dirigenti e forze politiche: è il mainstream, bellezza.
È una delle conseguenze meno evidenti, certamente più insidiose, del graffiante paragrafo “anticapitalista” del Discorso alla città dell’Arcivescovo Delpini (Ma essa non cadde. La casa comune, responsabilità condivisa). Milano, più di altre città italiane, rappresenta oggi una realizzazione quasi in purezza di questa ottica: una metropoli pienamente allineata a un modello di sviluppo fondato sull’attrattività dei capitali, sulla centralità della rendita immobiliare e sulla competizione globale tra territori. Il successo della città viene così misurato più dalla capacità di attrarre investimenti che dalla qualità degli esiti economici e sociali che produce per i cittadini.
E questo modello di sviluppo – che tutti sono pronti a condannare nel primo paragrafo delle proprie relazioni, chiedendo immediatamente discontinuità -, diciamocelo, in questi anni non è stato subito, non è stato accettato, non è stato nemmeno interpretato: è stato sposato in toto e per piena condivisione culturale.
Il punto critico è che questo modello contiene il bug culturale citato. La politica interiorizza l’idea di essere strutturalmente inadeguata a intervenire nel mercato – non solo a negoziare con esso o, nella peggiore delle ipotesi, ad aprirgli la porta senza chiedere nemmeno la visura camerale; e, di conseguenza, si autolimita. Non formula strategie industriali urbane, non investe in modo selettivo, non costruisce filiere. Chiede invece alla pubblica amministrazione di abilitare, accompagnare, semplificare: è una rinuncia preventiva, prima ancora che politica, cognitiva.
Questa rappresentazione del ruolo pubblico non nasce spontaneamente. È il prodotto di una lunga stagione che, a partire dagli anni Ottanta, ha ridefinito il modo stesso in cui le istituzioni pensano la propria funzione. Era il paradigma del “New public management”: un insieme di pratiche, linguaggi e criteri di legittimazione che hanno spostato progressivamente l’asse dell’azione pubblica dalla promozione e guida dello sviluppo alla sua “abilitazione”. Sono decenni di report, linee guida e corsi di formazione finalizzati a diffondere e normalizzare questa impostazione nelle classi dirigenti globali. Titoli come Serving the economy better, un celeberrimo libro bianco dell’Ocse, se non vanno letti come manifesti ideologici del liberismo, sono però espressione emblematica di una stagione culturale in cui la pubblica amministrazione è stata pensata sempre più come infrastruttura funzionale all’economia e sempre meno come soggetto legittimato a orientarne gli esiti.
Il paradosso emerge con forza se lo si guarda in prospettiva storica. La tradizione delle imprese pubbliche municipali del Novecento, e di cui Milano fu una culla, mostra come le istituzioni locali abbiano saputo essere attori diretti dello sviluppo: nella produzione di servizi, nelle infrastrutture, nell’innovazione urbana, istituzionale e sociale. Quelle esperienze non erano anomalie, ma il frutto di una cultura politica ed economica che considerava necessario l’intervento pubblico nell’economia locale: che considerava legittimo il “governo economico municipale”. Oggi, a Milano, quella tradizione prima che impedita da mancanza di risorse e da vincoli normativi, è rimossa culturalmente: non viene più pensata come opzione possibile.
Ripensare Milano significa allora anche scardinare questo bug culturale: rimettere al centro l’idea che le istituzioni pubbliche non sono un ostacolo al mercato e allo sviluppo, ma uno dei suoi motori possibili. Perché senza un progetto pubblico esplicito la città non smette di svilupparsi: semplicemente smette di scegliere come e per chi farlo.



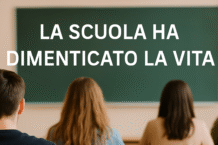

Devi fare login per commentare
Accedi