Palermo
De Gasperi, uomo di fede e statista
Intervento reso alla presenza di Maria Romana De Gasperi in occasione del 130° anniversario dalla nascita. De Gasperi, l’uomo e lo statista del secondo dopoguerra
La concezione dello Stato in Alcide De Gasperi ed il suo ruolo nel secondo dopoguerra
Non sempre la storia fa giustizia ma, in qualche caso, il miracolo avviene. È incredibile sentire infatti ricordare, con convinto rimpianto, il nome di Alcide De Gasperi, a uomini che l’avevano ferocemente avversato, avendolo additato come colui che abilmente arrestò il processo di radicale cambiamento avviato dalle forze progressiste con la caduta del fascismo, impedendo così alla democrazia italiana di raggiungere quegli obiettivi di crescita civile e sociale che il nostro Paese meritava.
De Gasperi, in un contesto come l’attuale, caratterizzato da una profonda crisi culturale, prima ancora che economica, è divenuto infatti il riferimento ideale dello stile dell’uomo politico, il come dovrebbe essere colui che dedicandosi alla cosa pubblica non cerca l’affermazione personale, “il successo”, la crescita sociale e, perché no!, la ricchezza, ma bensì si carica umilmente della Croce, affrontando le grandi difficoltà, le troppo frequenti incomprensioni e gli ostacoli che, usiamo una frase di san Paolo, per “una buona battaglia” pone di fronte al combattente.
“La politica, indica un grande Papa come Paolo VI, è un modo esigente di vivere l’impegno cristiano al servizio degli altri.” Quel “modo esigente” di vivere “l’impegno politico” segnò storia personale di De Gasperi, il quale non disdegnò di sporcarsi le mani e non ebbe paura di contaminarsi rifugiandosi in un aristocratico privato per, magari, giudicare dall’alto sui vizi e difetti degli altri.
Il Nostro, rappresenta un modello di politico oggi difficilmente rintracciabile: la sua “austerità” personale, atteggiamento naturale e non certo snobistico, si accompagnava infatti alla “serietà” dei comportamenti.
Scriveva un laico, come Piero Gobetti, che De Gasperi “non ammette che non si sia presi e dominati dalla serietà dell’azione”. Una serietà che lo portava ad approfondire gli argomenti sui quali interveniva e a disdegnare ogni e qualsiasi improvvisazione. Questa constatazione ci aiuta a rivedere qualche giudizio, anch’esso improvvisato, che vede un De Gasperi non sempre troppo attento alla cultura. Tutt’altro, fu uomo di profonda e radicata cultura, estremamente sensibile al fascino delle grandi idee, attento ai segnali che proprio dal mondo degli intellettuali provenivano, non certo affetto da quel provincialismo culturale del quale troppo si sono nutriti i protagonisti della storia del nostro Paese.
De Gasperi fu, soprattutto, uomo di profonda fede, diremmo un cristiano a 360°, rispettoso, anche se spesso con sofferenza, del magistero della Chiesa, e il suo pensiero, la sua azione difficilmente potrebbero essere interpretati senza tenere conto di questo assunto. Sottolineo “sofferto” perché in più occasioni, qualcuna drammatica, gli fu posto il problema della scelta, lo scegliere fra la fedeltà alla Chiesa ed il suo impegno nei confronti del Paese. Perchè De Gasperi fu, anche, un uomo delle istituzioni, garante intransigente di quelle istituzioni democratiche che lui stesso aveva contribuito a disegnare. Non a caso si può ricordare l’opuscolo “Idee ricostruttive della Democrazia cristiana” nel quale è annunciata, in sintesi, l’architettura istituzionale che avrebbe trovato accoglimento nella Costituzione del 1948. Proprio in questo documento incontriamo, chiara, l’opzione culturale del politico trentino. Fondamentale e pregiudiziale, secondo De Gasperi, avrebbe dovuto essere “la libertà politica…segno di distinzione del regime democratico”, libertà declinata secondo “il metodo democratico…segno di riconoscimento e impegno d’onore di tutti gli uomini veramente liberi”.
Mentre “Una democrazia rappresentativa – egli affermava – espressa dal suffragio universale, fondata sull’eguaglianza dei diritti e dei doveri e animata dallo spirito di fraternità, che è fermento vitale della civiltà cristiana…deve essere il regime di domani”. Ecco, dunque il succo della concezione politica di De Gasperi, una sintesi del pensiero sociale cattolico arricchita da una concezione dello Stato come garante della libertà dei cittadini, una visione che richiama in modo evidente quella dei cattolici liberali i cui padri nobili furono Antonio Rosmini, Vincenzo Gioberti, Gioacchino Ventura e Alessandro Manzoni.
Anche De Gasperi, come loro, aspirava a dirigere il rinnovamento civile nazionale dirimendo le difficoltà teoriche, reali o apparenti, della coscienza civile dell’italiano e di quella del cattolico. Lo Stato, dunque, come garante delle libertà “contro – ed è ancora un richiamo alle Idee ricostruttive – ogni intolleranza di razza e di religione, il regime democratico serberà il più riguardoso rispetto per la libertà delle coscienze”.
Nell’esaltarne le funzioni, De Gasperi, tuttavia, non idolizza il ruolo dello Stato. Infatti, per il nostro, esso non può essere concepito come espressione della potenza e della forza della nazione, ma è, più semplicemente, strumento organizzativo giuridico di garanzia, di tutela e di stimolo della vita nazionale. Tale concezione trova riscontro nella costruzione del partito, a suo giudizio, necessario per tradurre le idee in progetto. Un partito che si candida alla guida di uno Stato da ricostruire dopo la tragica esperienza del regime fascista ma, anche, che si candida a confrontarsi, dialetticamente, con i nuovi soggetti e le nuove sensibilità emerse dopo la caduta dello stesso fascismo. Il partito dei cattolici, che sana la frattura risorgimentale che aveva determinato la nascita della cosiddetta “questione cattolica”. Dunque, ricostruire l’idea di Stato, strumento regolatore dello sviluppo democratico, nel quale tutti potevano e dovevano riconoscersi, e strumento necessario per ricostruire sul piano materiale il territorio di una nazione devastata dalla terribile avventura bellica.
De Gasperi, dunque, il Costruttore, termine felice usato da Antonio Polito nella sua biografia. La strategia progettuale degasperiana per raggiungere l’obiettivo di riportare alla normalità democratica il Paese si mosse dunque, per mezzo del partito e, successivamente, attraverso anche l’azione di governo, su alcune linee fondamentali, a partire dall’8 settembre del 1943, data emblematica e tragica ad un tempo che, sinteticamente, si possono riassumere in tre le direttrici. La prima di esse conduce all’obiettivo immediato e pregiudiziale alla stessa azione politica.
Si trattava di ricostituire l’autorità dello Stato al di sopra delle fazioni e dei giochi di parte, anche per offrire quelle garanzie necessarie a ristabilire l’ordine. Bisognava in questo senso dare certezze, creare punti di riferimento, “punti fermi” avrebbe detto Sturzo che non vedeva di buon occhio la scelta degasperiana affezionato com’era alla formula “partito di cattolici” con quale aveva battezzato il partito popolare italiano. Quel ristabilire l’autorità dello Stato avrebbe consentito di “sconfiggere il clima di paura e di apprensione che inquinava allora l’intera società italiana”. Quale investitore avrebbe scommesso in un clima di precarietà e di insicurezza qual era quello che presentava l’Italia del dopoguerra? Per il raggiungimento di quest’obiettivo fu decisivo il contributo di Mario Scelba, il quale si assunse l’ingrato compito di riportare l’ordine meritandosi il tanto ignominioso che ingiusto epiteto di “ministro di polizia”.
La seconda strada percorsa fu quella delle alleanze a livello interno e a livello internazionale. Anche in questo caso, scelte ardue concepite in un clima poco sereno che vedeva emergere pressioni interne ed esterne. Nella neonata Democrazia cristiana il problema delle alleanze diveniva motivo di dibattito e di scontro soprattutto con chi avrebbe voluto fare del partito lo strumento d’impegno, sul piano sociale e politico, per ricristianizzare le strutture, le leggi e le istituzioni così da potere instaurare la “civiltà cristiana”. Era, questa, la traduzione in salsa italiana del pensiero di Maritain della “nuova cristianità” di cui si facevano carico giovani e motivati intellettuali cattolici, fra essi Dossetti, La Pira, Fanfani, Lazzati e Moro. A questa insidiosa proposta politica, De Gasperi, con il realismo che lo contraddistingueva, contrapponeva la tesi, poi vincente, di puntare sulle alleanze con i partiti di tradizione laica e riformista. Un’opzione che non nasceva da un’esigenza quantitativa, cioè dalla ricerca di consensi utili a irrobustire la maggioranza, ma da un’esigenza qualitativa e strategica, che si può sintetizzare nel dimostrare al Paese, realtà plurale, che il partito che era nato e la maggioranza che veniva legittimata a governare, non aveva alcuna intenzione di rappresentare gli interessi e le aspettative di una sola parte, ma che invece guardava agli interessi della Nazione, sintesi del molteplice. Era un messaggio forte che veniva rivolto anche all’elettorato di riferimento, cioè ai cattolici italiani, i quali avrebbero sempre dovuto fare i conti con le altre tradizioni, come quelle laiche e socialiste, a pieno diritto presenti nel Paese.
Sul piano delle alleanze internazionali, anch’esso spinoso tema, considerata la situazione che si era venuta a creare dopo il conflitto mondiale, cioè la divisione in blocchi, per de Gasperi l’unica scelta possibile era quella dell’alleanza con gli Stati Uniti che si erano ritagliati il ruolo di antemurale nei confronti dell’avanzata del comunismo. C’è da chiedersi se esistessero altre soluzioni, se l’Italia non avrebbe potuto scegliere, come avrebbero voluto anche espressioni interne al partito, la strada del neutralismo, lo stare in mezzo fra i due blocchi. Chi proponeva questa opzione, non aveva chiaro il fatto della duplice condizione nella quale si trovava il Paese, e cioè la sua posizione critica fra i due blocchi e la necessità di un solido alleato che contribuisse e garantisse la rinascita democratica della nazione. Proprio questa scelta, la scelta Occidentale, fu ferocemente avversata sul piano interno come su quello esterno. Si accusò De Gasperi ed il governo che presiedeva di “sudditanza nei confronti degli Stati Uniti”. Ed il pericolo di “sudditanza” era reale, De Gasperi stesso se ne rendeva conto, tanto è vero che per impedire che si realizzasse una tale condizione, sfidando l’ostilità conservatrice delle destre e delle sinistre interne ed esterne, inaugurò con slancio ideale la strada dell’integrazione europea. Scrive a questo proposito Sandro Fontana che “egli intendeva sottrarre, per un verso, l’Italia e l’intera Europa alla logica opprimente dei due <blocchi> e, per altro, le nuove generazioni alle sirene insidiose del nazionalismo e dell’internazionalismo comunista”.
La terza direttiva sulla quale avviò il partito fu quella sociale. Qui emerge il di più rispetto al liberale quale, appunto, abbiamo detto ch’egli fosse, e cioè l’uomo che guarda alla società, alle sue iniquità, alle ingiustizie sociali che suonano vergogna per il cattolico impegnato in politica. E l’Italia del dopoguerra mostrava un volto deturpato dalle ingiustizie sociali. La questione sociale, una delle tre grandi questioni aperte dal processo unitario dopo circa novant’anni dall’epopea risorgimentale era più che mai presente costituendo una contraddizione evidente. La questione sociale, riconosceva De Gasperi, dava alimento e stimolo alla proposta comunista. Ecco allora che accanto alla democrazia politica, all’affermazione delle libertà, doveva costruirsi una democrazia sociale che rimediasse, sono parole del leader trentino, “alla grande sperequazione di ricchezza, alle insopportabili ingiustizie sociali, alla lunga incuria nel combattere la miseria che, per oltre un secolo, hanno caratterizzato la politica egoistica, avida e cieca delle nostre classi dirigenti. Esse non hanno operato secondo i dettami della religione e perciò Dio ha voluto che una grande forza cattolica sia chiamata oggi a restaurare in Italia la dottrina cristiana sul piano sociale eliminando le maggiori iniquità”. Questo obiettivo, più che gli altri, si appalesava difficile, la giustizia sociale non poteva realizzarsi in un contesto obiettivamente debole, bisognava infatti ricostruire le strutture produttive e per fare questo, obtorto collo, era necessario confrontarsi con un padronato che, in genere, alla questione sociale, era poco sensibile. Sono certo che De Gasperi, che in quell’occasione fu accusato dalle sinistre di avere svenduto le spinte di rinnovamento che avevano animato l’antifascismo militante, quando ben presto si dovette trovare a fare i conti con quello che definì “il quarto partito”, cioè il partito del padronato, e quindi a dovere moderare le sue motivate spinte sociali, da cattolico impegnato ebbe particolarmente a soffrirne.
Con i limiti, determinati, soprattutto, dal clima avvelenato del dopoguerra che portava a privilegiare la concezione di “democrazia protetta” rispetto alla iniziativa riformatrice, e dalle preoccupazioni costanti di sconfiggere le tendenze illiberali e giacobine, così fortemente radicate nella cultura italiana, presenti in egual misura, nelle formazioni politiche di destra e di sinistra, possiamo dire che gli obiettivi posti dall’azione politica di De Gasperi, furono in gran parte raggiunti. L’Italia, grazie alla sua forte presenza, poté tranquillamente incamminarsi sulla via del progresso civile, economico e sociale. Non possiamo dunque meravigliarci se, placate le passioni e rasserenati gli animi, la figura del più grande statista italiano del dopoguerra, emerga in tutta la sua grandezza divenendo motivo di rimpianto per quanti guardano con giustificata tristezza la politica odierna del nostro Paese.
Sciacca 2011



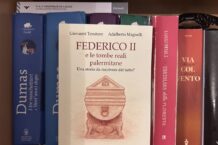

Devi fare login per commentare
Accedi