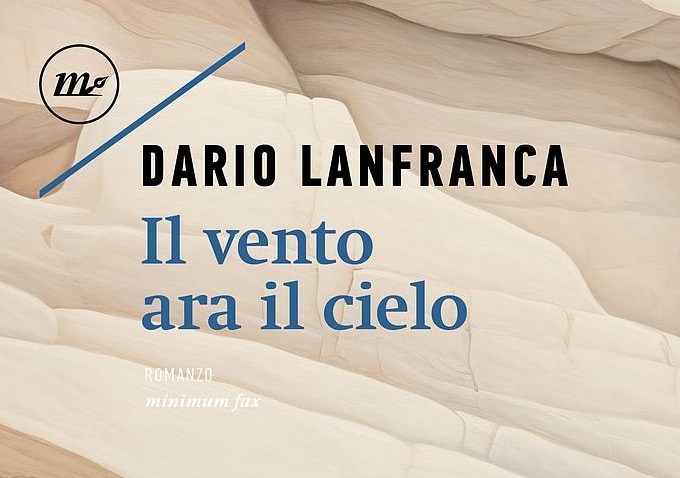
Letteratura
“Il vento ara il cielo”, il romanzo sull’inconsapevolezza umana di Dario Lanfranca
‘Il vento ara il cielo’ è il primo romanzo del regista e sceneggiatore Dario Lanfranca
Nelle polverose campagne di Agrigento, dai rami di un albero pende una collana di acquamarina il cui contorno sembra ricordare l’immagine della Madonna. A Sabrina, ingenua ragazza muta che sembra destinata a un’esistenza miserevole, pare un miracolo. Sta tutto in questa immagine l’incipit del romanzo di Dario Lanfranca ‘Il vento ara il cielo’, edito da Minimum Fax. Un libro che è una riflessione sulla borghesia mafiosa, entità che come un gas, in certi territori, ha permeato tutto. E qui sorge la domanda: quanto effettivamente sia possibile opporsi al diffondersi di un gas come quello mafioso, perché la mafia permea il particolare fino a confondere tutto, e non si sa più se è quel che si respira a intossicarci o se è proprio il nostro fiato a inquinare il mondo.
Di Sabrina, fin dalle prime pagine del romanzo, conosceremo la sua famiglia: l’arrivista padre-padrone Gregorio, in lotta perenne con suo cognato Calogero, comunista atipico, la moglie Liana e i due fratelli di Sabrina. Da questi sei personaggi parte una storia che, dal 1959 e per circa un decennio, da Agrigento a Palermo, incrocia persone realmente esistite – come il capo della mobile Cataldo Tandoy, morto in un agguato fatto passare per delitto passionale – e trae spunto da eventi accaduti successivamente – la costruzione della diga Garcia, oggetto delle mire dei corleonesi e teatro di omicidi – per raccontare la genesi della cosiddetta borghesia mafiosa.
Ma Sabrina chi è? L’autore confessa che questo personaggio nasce come dato autobiografico dal racconto di una domestica sordomuta a cui venivano fatti degli scherzi goliardici da lui e da altri bambini. È lei il soggetto attorno a cui si concentra la pietas del racconto. Un personaggio a cui l’autore sembra in un primo momento voler affidare il ruolo di protagonista del libro. Poi, per successive stratificazioni, l’orizzonte si è ampliato, dando a ‘Il vento ara il cielo’ un senso molto più grande. E dentro il romanzo sono finite tante cose: l’autorità patriarcale di Gregorio, padre di Sabrina e tutto il suo mondo ctonio, brutale, tanto da farne un personaggio estremo, sempre attento al puro tornaconto personale, anche nelle relazioni più strette, più intime.
Dario Lanfranca è molto efficace a descrivere l’involucro culturale all’interno del quale la mafia ha attecchito. Lanfranca ha studiato a lungo il fenomeno mafioso, approfondendo come abbia attecchito in Sicilia. Nel suo saggio ‘La spugna d’oro’ (2019), edito da Rubettino, ha approfondito come i poteri periferici dell’isola siano riusciti a erodere il potere centrale. L’ideologia nazionalautonomista siciliana si è sempre fondata su una complessa articolazione di conflitto e negoziazione in cui un ruolo primario era giocato dal parlamento isolano nel suo relazionarsi con re e viceré. Ma questa ideologia, secondo Lanfranca, non poteva reggersi senza fare ricorso alla violenza, concretizzandosi in relazioni tutte caratterizzate da pure dinamiche di potere.
Giovanni Falcone ha definito la Sicilia come “l’isola del potere e della patologia del potere”. Un luogo in cui si incontrano facilmente, all’interno della stessa famiglia, gli opposti. E a Gregorio viene opposto il cognato Calogero, portatore di una visione opposta. Lui possiede una terra sopra la Scala dei Turchi, ha un rapporto empatico con la natura, con quella natura a cui non interessano mai i giochi e le logiche del potere. E la Scala dei Turchi, bianca, calcarea, è un luogo insieme simbolico e autobiografico. Un luogo a cui Lanfranca è legato dai ricordi dell’infanzia. Per arrivarci, ricorda l’autore, c’era un tratto di litorale da fare. Era un ecosistema ricco di fauna marina. Poi si è cominciato a pensare di realizzarci un eliporto in quel tratto di litorale, rompendo quell’ambiente d’incanto a cui Lanfranca è molto legato.
Dal romanzo di Dario Lanfranca esce una Sicilia che è metafora dell’inconsapevolezza in cui è destinato a muoversi sulla Terra qualsiasi essere senziente. Come quella pietra della lettera di Spinoza a Schuller, riportata in apertura del libro. E quel che si dice della pietra deve intendersi di qualunque cosa singola. Perché si può presupporre che la pietra sappia di muoversi. “Ma ciascuna cosa è necessariamente determinata da qualche altra causa esterna. E la pietra così scagliata crederà di essere perfettamente libera e di continuare nel suo moto per il semplice motivo che lo vuole. Così è fatta la famosa libertà umana di cui tutti si vantano: gli uomini conoscono il proprio desiderio e ignorano le cause da cui sono determinati”.
Altre recensioni dello stesso autore





Devi fare login per commentare
Accedi