
Letteratura
La conquista dell’infelicità. Il nuovo libro di Raffaele Alberto Ventura
Come siamo diventati classe disagiata
Ho appena finito di leggere “La conquista dell’infelicità” di Raffaele Alberto Ventura. (Einaudi 2025). Un libro bello, denso, brillante e un po’ angosciante. E con un finale con colpo di scena, direi a copertina chiusa, controintuitivo vista l’esposizione dei temi fin a quel momento condotta. Avete presente, tutte le proporzioni viste, il finale del “Principe” di Machiavelli, con quella invocazione ai Principi italiani, di speranza e lotta, in controtendenza rispetto ai capitoli precedenti così spietati nel loro realismo “machiavellico” tanto è passato in leggenda?
Solo che qui è al contrario: dopo una esposizione condotta sui toni di un idealismo risentito e antiadattivo succede una proposta realista, che condivido in pieno, eppure distonica rispetto agli accenti precedenti.
Ma andiamo con ordine.
Scrive Ventura: «La tesi di questo libro è semplice. Per quanto si sforzi di soddisfare i nostri bisogni materiali, la società liberale produce delusione, e questa delusione la rende sempre piú ingovernabile.» Eh beh, sì, il mondo in cui nolens volens viviamo non è certo oggetto di consensi o lodi. «Oggi siamo tutti Amleto – chiosa con una certa enfasi Ventura – principi decaduti di un regno immaginario, esiliati nelle terre del realismo capitalista». Un altro mondo è sicuramente possibile rispetto al postaccio in cui ci è toccato vivere? Certo, lo invocano e lo auspicano in tanti, anche se personalmente ho sempre dubitato, per il semplice fatto che ci ho vissuto e lavorato, che il nostro Paese — il cui listino di borsa è dominato da aziende pubbliche o parapubbliche e municipalizzate (e ciò dai tempi dell’IRI ispirato alla “economia sociale di mercato” di Walter Rathenau che il Mussolini giovane e socialista incontrò quand’era redattore dell’Avanti!), economia dominata da aziende dove si accede perlopiù per morbido familismo visto che i concorsi sono stati parzialmente smantellati—, abbia i tratti feroci notomizzati da Mark Fisher, inventore della locuzione “Realismo capitalista”, calzante invece per la sua Inghilterra rivoltata come un calzino dalla Thatcher, «la bocca di Marilyn Monroe, gli occhi di Caligola», secondo François Mitterrand. Per intanto, per molti disagiati italiani, la vita resta un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit. (Spleen de Paris) annoto a margine col mio Baudelaire.
Ventura, col suo saggismo curioso, proliferante, sapido e insonne perviene a quella sentenza citata in esordio, e ad altre, scorate e scoraggianti lungo la trattazione, attraverso una sarabanda di argomentazioni in otto densissimi capitoli, che vanno dall’amletismo paradigmatico delle personalità dell’età moderna — gli infelici molti della Morante — presso cui l’intelligenza e il sentimento sono estremamente sviluppati ma la potenza di azione pressoché assente, all’analisi temeraria della teoria dei bisogni, a quelle della meritocrazia, al fenomeno dell’iper-intellettualizzazione, alla «messa al lavoro» del tempo libero e la conseguente intrusione del lavoro nel contesto domestico ecc, fenomeni reali e allarmanti che chiederebbero quantomeno una esplosione più dettagliata, ma Ventura non arretra certo a costo di condensare tematiche da far tremare i polsi in svelte argomentazioni a piglia e lascia, toccando tutto e tutto lasciando con tocchi lievi e brillanti, con accenni a libri, frame di pellicole cinematografiche, strisce di fumetti, e con la traccia sottocutanea del dimostrare che il proposito nicciano del come «si diventa ciò che si è » di Ecce homo (che pare fosse di Alberto Magno e risalisse a Pindaro), sia impossibile da realizzare nel nostro mondo evoluto e neocapitalista. Ma quando ho scorto la frase «eppure del senso della vita parleremo spesso in queste pagine» ho fatto un balzo indietro temendo che il nostro sveglio saggista si stesse instradando sulla scia dei tanti paraguru che affollano la pubblicistica italiana e che in genere archivio con rapida mossa mentale nel diffidente segmento “midcult & self help” dove osano i Crepet del «te lo spiego io come aiutarti se dio non ti aiuta.»
C’è una scelta redazionale forse in favore dei tanti disagiati che si riconosceranno in queste pagine che va in tal senso e che non saprei se attribuire all’autore o a indicazioni superiori di regia (editore o editing) di lardellare la pagina di citazioni graficamente in grassetto paradigmatiche prelevate dal testo a mo’ di apoftegmi segnanti per scolpire momenti salienti del discorso, tipo «Oggi si parte per «ritrovare se stessi» e si scopre di essere esattamente identici a centinaia di altri. Via dalla pazza folla c’è soltanto un’altra folla.»
Questo nuovo saggio di Ventura è composito quanto a temi e argomentazioni, dicevo. Da un lato è una ricognizione dello stato dell’arte di quella classe che era al centro dell’indagine del suo studio del 2017 (Teoria della classe disagiata) ovvero, per ricapitolare il nodo tematico principale, di quei soggetti sociali (perlopiù giovani) provenienti da una condizione familiare di partenza «troppo ricca per rinunciare alle proprie aspirazioni, ma troppo povera per poterle realizzare». Aspirazioni che sarebbero principalmente quelle di poter ricavare un adeguato reddito da professioni prevalentemente creative (giornalismo, illustrazioni di giornali, creatività assortita nel web ecc.). Se questo è il tema centrale, ad esso si intrecciano una serie di sottoargomenti che Ventura tratta more solito, ossia alternando, a supporto delle proprie argomentazioni, romanzi classici, scene di film e gli immancabili fumetti. Dico immancabili, perché il ricorso ai comics era una procedura di Ventura già ai tempi di “Prismo”, una rivista online di una decina di anni fa. Qui i fumetti si affiancavano ai grandi classici della letteratura e del pensiero, rendendo per uno come me, di quasi una generazione e mezza precedente la sua, la realizzazione di quel film che il produttore del “Caimano” di Nanni Moretti con grande ironia intendeva titolare “Maciste contro Freud”. Operazione che solo oggi seppur con un residuo di sprezzatura per via della fusione dei codici della cultura moderna ritengo legittima, anche se un tantino chic e choc.
Inaspettata la chiusura della parabola saggistica dicevo. Ricordo che il mio Flaubert ricorreva a Goethe — come fa Ventura nel suo ultimo capitolo — il quale aveva optato definitivamente per il contenimento classico delle passioni, il controllo sapiente delle emozioni, l’irreggimentazione colta della sensibilità (dopotutto si occupava di miniere mentre scriveva il Meister, e aveva sposato “sa servante” annotava Flaubert). Occorreva, secondo lo scrittore normanno, saper accettare i limiti della finitezza, anche filistea, dell’esistenza, abbassare l’ideale al reale, cominciare a cambiare se stessi quando è difficile cambiare il mondo (è una delle regole della morale provvisoria di Descartes). E concludeva con un verso di Orazio “Sibi constet” stai, rimani in te, sii te stesso. Ventura parla di downshifting e in un eccesso di saggezza dice qualcosa di analogo appellandosi a Kierkegaard, il quale decide di dichiarare lotta a sé stesso e propendere per la saggezza della “menzogna vitale”. Una chiusura delle sue linee argomentative finora brillantemente svolte, tanto saggia quanto inaspettata dicevo, che sottoscrivo toto corde perché provenendo anch’io da una classe disagiata seppur di altro tipo — il sottoproletariato urbano più disperato senza arte e né parte — ho dovuto raccontarmi altrettante menzogne vitali per sfangarla, la prima tra tutte quella presa in prestito dal francese Cocteau «il faut être un homme vivant et un artiste posthume»: marcare cartellino per decenni nella ostile Milano, e giunto in pensione (c’è un’allusione a essa come bene inseguito e sfuggente nel libro di Ventura) recensire signorilmente il bel libro di Raffaele Alberto Ventura.

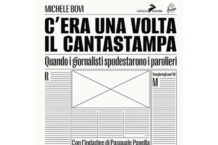

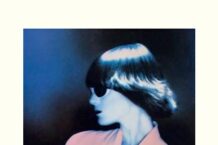
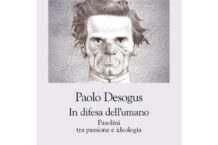
Devi fare login per commentare
Accedi