
Musica
Aboliamo non i generi ma il giudizio di valore che diamo ai generi
Musica delle avanguardie novecentesche e postmoderne interpretate dalla fisarmonica strabiliante di Samuele Telari
La fisarmonica – che in tedesco, lingua del paese in cui nell’Ottocento è stata inventata, si chiama Akkordeon, in francese accordéon, in spagnolo acordeón, in inglese accordion, e solo in inglese l’accento cade sulla penultima sillaba, mentre nelle altre sull’ultima – è uno strumento diffusissimo in Europa e in America, e nel mondo, in Argentina è quasi un emblema nazionale, un suono insostituibile del tango. È stato a lungo, anche, in Italia, lo strumento delle notti emiliane e romagnole. Ma ne è meno raro di quanto si pensi l’uso anche nella musica cosiddetta colta, Alban Berg, per esempio, la usa nel Wozzeck, a caratterizzare l’orchestrina dei balli popolari. Ma Samuele Telari, giovane musicista spoletino, affronta la sfida di esercitarsi anche nel repertorio della musica cosiddetta colta contemporanea. E così, per l’Accademia Filarmonica Romana, ma anche nell’ambito del Festival di musica sacra del Lazio 2025, ha proposto, in un gradevole pomeriggio settembrino, in una sala della Parrocchia romana di Santa Chiara, un concerto di musiche del Novecento, e di oggi, che si concludeva però nel nome di Johann Sebastian Bach, un corale luterano per organo, trascritto per la fisarmonica: “Nun komm’ der Heiden Heiland”, ora vieni, Salvatore delle genti, BWV 659. L’effetto musicale è stato che la musica di Bach ha in qualche modo illuminato anche ciò che si era ascoltato prima. Telari ha interpretato, in successione, senza interrompersi, e chiedendo di non applaudire alla fine di ogni brano, ma solo alla fine del concerto, composizioni di Nicola Campogrande (nato nel 1969) – Preludio da viaggio n. 1, n. 2 e n. 3 -, del compositore francese Bruno Mantovani (1974) – 8′ 20″ -, di Dmitrij Šostakovič (1906-1975) – Preludio e fuga n. 7 e n. 15 -, di Sofia Gubaidulina (1931-2025) – Et expecto – di György Ligeti (1923-2006) – Musica ricercata n. 9 (e il termine ricercata la dice lunga sul suo significato di brano pensato, molto pensato) – di John Zorn (1953) – Road Runner -. Dalle seduzioni ritmiche di Campogrande alle rifrazioni armoniche e aggregazioni di masse sonore di Mantovani, al contrappunto reinventato di Šostakovič, alle esplosioni selvagge di Gubaidulina, all’introspezione esasperata degli intervalli che Ligeti conduce, fino a una sorta di rassegna della memoria musicale, canzonette che affiorano da un magma indefinibile, ch’è il percorso imprevedibile del camminatore Zorn, si arriva così alla sintesi bachiana, in cui sembra non già prefigurarsi la musica dell’avvenire, ma catalogare la musica avvenuta. L’Aria delle Variazioni Goldberg, concessa come bis, concludeva l’avventura del bel concerto con un canto che sembra davvero l’idea platonica di ogni canto. Uno penserebbe che il pubblico potesse rimanerne disorientato: lo sperimentalismo di certe avanguardie novecentesche e postmoderne – in particolare le spericolate indagini sulla materia sonora di un Mantovani o l’imprevedibile materialità di una Gubaidolina sono indagini che qualcuno, nostalgico di una musica che accarezzi l’orecchio, potrebbe rifiutare. Soprattutto oggi che viviamo un’epoca alla disperata ricerca di certezze, sicurezze, consolazioni, un’epoca che diffida dell’avventura, che si rinchiude su sé stessa, che cerca il noto, ha paura dell’ignoto, del diverso.
Samuele Telari c’invita invece ad affrontare la sfida di una ricerca che vuole indagare il possibile, l’ignoto, il diverso, rigetta il già compiuto, il noto, il conforme. È qui che Bach c’illumina: la sua musica ci appare contemporanea, o meglio, inattaccata dall’usura del tempo, perché in un percorso, che dovrebbe apparirci familiare, distoglie sempre il piede dalla successione prevista per osare quella imprevista. Che è poi la radice della musica del Novecento. O, forse, di ogni musica, che sia davvero grande musica. Chi nella musica, nella letteratura, nel teatro, nel cinema, insomma nell’arte, cerca l’evasione, il conforto, la conferma di ciò che già conosce, Bach lo delude, o quando crede di riconoscervi l’usato passo, non si accorge di essere stato trasportato altrove. Che è esattamente ciò in cui consiste la sfida di Telari, Ma la sorpresa maggiore viene dal fatto che un tale viaggio verso l’ignoto non è condotto attraverso le comode, e rassicuranti, configurazioni di un pianoforte, di un violino, di una voce, di un’orchestra, ma dai mutevoli e ora aggressivi ora dolcissimi lamenti di una fisarmonica, lo strumento del tango, delle balere, delle canzoni popolari tedesche o russe. Saltano i codici di riferimento. L’alto e il basso si confondono, il sublime e l’umile si uniscono, l’aristocratico e il plebeo si stringono la mano. È questa trasversalità della fisarmonica che Teleri ci scaraventa addosso, c’inonda, ci sommerge, ma non con rabbia, né tanto meno con asprezza, bensì con una sterminata e accattivante tenerezza. È questo crollo delle barriere, questa caduta delle mura di Gerico, che ci conquista. I generi risultano una menzogna, una spudorata ideologia la separazione di “colto” e “leggero”, un abuso di classe dividere il piacere di una sonata di Beethoven dal fascino di una canzone di Jacques Brel. È il rifiuto non della diversità, perché Beethoven non è Brel, ma di attribuire un valore alla diversità. Di credere che qualcosa sia alto, e che qualcos’altro sia basso, attribuendo ad alto e basso non il significato che hanno di campi d’uso diversi, ma un senso di valore, di giudizio di valore. La musica, come tutte le arti, è naturalmente democratica, non perché eguagli tutte le sue espressioni, ma perché le accetta tutte, accetta le diversità di tutte. Proprio il contrario di ciò che invece oggi sembra la tentazione dominante di artisti e di istituzioni: appiattire ogni espressione al livello più basso. Per una malriposta ricerca di comprensibilità. La musica, la poesia, il teatro, la pittura non devono essere comprensibili a tutti, non consiste in questo la democrazia. Si deve invece riuscire a costruire una società in cui tutti possano capire anche ciò ch’è difficile. Telari compie in qualche modo il miracolo. Con uno strumento popolare come la fisarmonica – e lui usa la più complessa fisarmonica a bottoni –: propone al pubblico l’aristocratica musica sperimentale delle avanguardie. Bach fa lo stesso: l’ultima variazione Goldberg associa al tema una volgare canzone da taverna. Gli applausi, calorosi e fragorosi, premiano la sfida. Ecco la via da percorrere, oggi, in ogni campo, non solo in quello dell’arte: educare tutti al difficile, non ingannarli con improbabili e menzognere semplificazioni. La semplificazione, in ogni tempo, è servita sempre solo a mantenere la divisione tra chi controlla e chi è controllato.




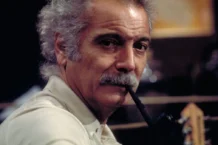

Devi fare login per commentare
Accedi