
Musica
Alla ricerca del paradiso perduto
Giacomo Menegardi, nella Sala Casella dell’Accademia Filarmonica Romana, conclude i Dialoghi d’autuno con un bel conerto dedicato alla musica pianistica del Romanticismo, dall’inizio alla sua fine.
I Dialoghi d’autunno si sono conclusi. Nella Sala Casella dei giardini dell’Accademia Filarmonica Romana il giovanissimo pianista Giacomo Menegardi, vincitore nel 2023 del Premio Venezia, ha chiuso la rassegna con una sorta di lezione magistrale sull’inizio e la fine del romanticismo, se si considera la cronologia delle pagine interpretate, una divagazione sulla ricerca di una nuova forma e sulla fine di ogni forma prestabilita, se si confrontano le strutture musicali dei brani. Da Mendelssohn a Skrjabin il romanticismo europeo sfida una tradizione centenaria, almeno dal Seicento a tutto il Settecento, per lanciarsi nella ricerca di un nuovo sistema che tenga insieme una pagina di musica. La conclusione, con Skrjabin, è che una forma convenuta, concordata, si è fatta ormai impossibile, e ogni compositore deve inventarsene una tutta per sé, ma inefficace per gli altri, per ogni pagina che compone. Le avanguardie novecentesche tenteranno di colmare la lacuna, fallendo tutte, una dopo l’altra. Come sempre, la nostalgia del paradiso perduto tenterà alcuni d’inventarsene un altro, ripetendo le forme già sperimentate, ma è come riempire d’acqua un vaso senza fondo. Ogni compositore, oggi, non ha punti di appoggio che in sé stesso, deve inventarsi lui stesso le regole, che una volta erano tradizione comune, ma non più per costruire qualcosa, bensì, come dichiara in un lucidissimo scritto Boulez, “per il piacere d’infrangerle”. Ma questo è un altro discorso e riguarda l’oggi.
E non solo la musica, ma anche la letteratura, le arti figurative e performative, perfino la politica, che anch’essa sembra avere perduto qualunque punto di riferimento che non si la propria volontà di potenza. Provate adesso a dire che Nietzsche si sbagliava. Il concerto di Giacomo Menegardi ce ne presentava le premesse. E giustamente comincia con una pagina, allora rivoluzionaria: la Fantasia in fa diesis minore di Felix Mendelssohn-Bartholdy. È sempre più raro ormai ascoltare Mendelssohn in un concerto. Male, perché nella sua enigmatica, anche se apparentemente cristallina, scrittura, che suggerisce l’effetto di un sovrano e quasi olimpico equilibrio, scorre una irrequietezza sotterranea che è appunto il segno di un mondo che si sta sgretolando. Ancora ragazzo, Mendelssohn regala a Goethe, per il suo compleanno la traduzione dell’Andria di Terenzio. Terenzio, non Plauto. Plauto è la derisione di un mondo consolidato. Terenzio la testimonianza che quel mondo si sta sgretolando. E allo sfascio contrappone l’ordine di una forma poetica impeccabile. Terenzio era piaciuto molto, due secoli prima, e non a caso, a Spinoza. Menegardi fa subito percepire la quadratura del canto che apre la fantasia. Ma piano piano la conduce all’esplosione dell’irrequietezza ritmica, più che armonica, all’aprirsi di scenari che si concedono all’imprevisto. L’acustica infelice della sala non lo aiuta, ma si coglie bene la contrapposizione di momenti di mobilità a momenti di quiete provvisoria. La rifrazione rende però ancora più difficile cogliere il percorso, soprattutto armonico, dei Phantasiestücke op. 12 di Robert Schumann.
L‘architettura della successione degli otto brani che la compongono un po’ si perde. Ma si coglie molto bene il pensiero che costruisce ogni brano da una cellula minima, un intervallo, un ritmo. Ecco il passo che Mendelssohn non osa: buttarsi nell’ancora ignoto suggerimento che non si sa dove possa condurre. Schumann invece osa affrontarlo, ci si butta dentro. È davvero il più romantico dei romantici, e supera anzi perfino i limiti dell’invenzione romantica, anticipando atteggiamenti che saranno di Brahms, di Mahler e perfino di Schoenberg. A questa pagina indimenticabile di Schumann Menegardi fa seguire uno dei punti di riferimento assoluto della ricerca musicale romantica: Après une lecture de Dante di Liszt. Il sottotitolo è significativo: “Fantasia quasi Sonata”. È il rovesciamento di un sottotitolo beethoveniano, “Sonata quasi una fantasia”, che Beethoven premette alle due Sonate op. 27, e la seconda è la famosissima sonata chiamata impropriamente Chiaro di luna. L’allusione ha un senso preciso: Beethoven è l’ossessione di una intera vita, per Liszt. Non solo perché allievo di un allievo di Beethoven: Czerny. Ma perché in Beethoven Liszt coglie, e giustamente, il punto di svolta della nuova musica. Liszt esaspera l’idea beethoveniana di ridurre al minimo la cellula da cui parte tutta l’invenzione. Qui è addirittura più scarna della cellula su cui è costruita la Quinta Sinfonia beethoveniana: là quattro note, qui solo due, là tre brevi e una lunga, nella metrica classica un peone quarto, qui una breve e una lunga, nella metrica classica un giambo. E rigorosissimamente tutto il brano è costruito sul ritmo del giambo iniziale. Menegardi lo fa sentire con icastica evidenza. Infine la seconda Sonata in sol diesis minore op. 19 di Aleksandr Skrjabin, “Sonate-fantaisie”, e il cerchio si chiude, anzi resta aperto all’abisso che ormai si spalanca davanti al compositore. Menegardi concede, come dice, un “fuori programma”: un notturno di Respighi. Veramente fuori, un alieno.



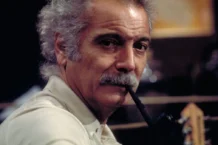

Devi fare login per commentare
Accedi