
Lavoro
Povera Italia povera
In Italia una parte sempre più consistente di lavoratori è sotto la soglia di povertà e richiede l’aiuto di associazioni ed enti locali per poter sopravvivere.
La notizia forse coglie qualcuno di sorpresa pare, ma il tema è così antico che minimo minimo ha già compiuto la maggiore età. Di definizione del lavoro e dei criteri e categorie per i quali definire occupato, inoccupato o disoccupato qualcuno (attenzione non in termini astratti, ma come definizione per le normative italiane) ho iniziato a ragionare quando, ancora all’università, ho fatto le 150 ore in un ufficio che si occupava, fra le altre cose, del salone dell’orientamento. Allo stand della mia facoltà venivano riportati i dati, predisposti da un’agenzia terza, sull’indice di occupazione dei laureati a un anno dalla laurea. Dati davvero molto incoraggianti, che – letti così – avrebbero fatto pensare che in Italia valesse la pena sobbarcarsi le spese e lo sforzo di acquisire un titolo di studio “alto” per trovare poi un lavoro soddisfacente.
Già allora però mi ero accorta che, scritto piccolo piccolo fra asterischi, veniva indicato il significato di “occupato”, ovvero (cito la definizione di Openpolis):
“Occupato è chi svolge un lavoro. In particolare, sono occupate le persone dai 15 anni in su che hanno lavorato almeno un’ora durante la settimana di riferimento o erano assenti solo temporaneamente dal luogo di lavoro. La condizione di occupato non dipende dal compenso. Gli occupati possono essere retribuiti per il lavoro svolto o non ricevere un compenso ma lavorare per un guadagno familiare (ad esempio, nella ditta di famiglia). Inoltre, essere occupato prescinde dalla sottoscrizione di un contratto, ragione per cui sono considerati occupati anche i lavoratori irregolari”.
Ed ecco che scatta il primo problema. Occupato è praticamente chiunque faccia qualcosa. Dal consegnare i volantini per 5 euro l’ora per 8 ore la settimana al dirigere una maxi azienda da milioni di euro di fatturato (e di stipendio del manager). E già qui abbiamo un problema, se non leggiamo correttamente il dato. Perché se interpretiamo la definizione in modo stringente è chiaro che il tasso di disoccupazione può essere fatto salire e scendere a piacere comunicativo, senza alcun reale riferimento alla possibilità di sostentamento del lavoratore in questione.
Secondo grande tema: sempre al tempo mi sono trovata a lavorare per una realtà che forniva servizi a un ente pubblico. In pratica ero una “dipendente indipendente” indistinguibile a occhio nudo per l’utente medio da chi svolgeva il suo lavoro al tavolo di fianco al mio, con la piccola differenza che non avevo ferie, non avevo malattia, guadagnavo un quarto rispetto al collega de facto. Dettagli? No, perché al tempo ero pienamente occupata da statistica, lavorando dalle 7 alle 8 ore al giorno. Era un contratto irregolare? No, assolutamente. Era l’ente di riferimento che aveva chiesto di utilizzare questo tipo di forza lavoro? Nemmeno. Lo stato prevedeva questo tipo di contratto, aveva progressivamente tagliato i fondi per alcune funzioni esercitate da quell’ente, e – per continuare a garantire i servizi all’utenza – si era fatto di necessità virtù. Una virtù pessima, perché siamo in tanti che hanno lavorato, chi per mesi, chi per anni, con questi contratti per poi avere una posizione contributiva inesistente su quel periodo. Bello? Non proprio. Se ne riparlerà quando proveremo ad andare in pensione e capiremo se lo stato di allora potrà compensare i danni del passato.
Al tempo però, in quella posizione, lavoravamo praticamente solo noi “giovani”. Persone neo laureate, con qualche velleità di ulteriore crescita formativa, tutte senza famiglia e senza obblighi particolari verso il mondo. Di fatto un lavoro per non pesare ancora sulle spalle della famiglia di origine per il quotidiano, ma che non avrebbe permesso a nessuno – ricordo con 8 ore al giorno impegnate – di rendersi indipendente.
E veniamo a oggi. Finalmente scopriamo che le persone non vanno più in ferie, non comprano più la macchina (o non pagano l’assicurazione a loro rischio), non vanno più dal dentista o, anche questo molto comune, devono ricorrere ai risparmi familiari o all’aiuto dei genitori per pagare affitto, bollette, spese impreviste ma necessarie come gli occhiali per i figli.
Ci accorgiamo che lo stipendio medio di un docente della scuola dell’obbligo (stipendio statale) non regge in una città medio grande, a meno che questa persona non conviva con altre (non necessariamente per scelta affettiva) per dividere le spese. Non regge perché fra quello stipendio e il costo di un affitto, della spesa, delle utenze, senza parlare di auto (necessaria per molti per raggiungere il luogo di lavoro) e vestiti, non ci si “sta dentro”. E spesso, ulteriore nota amara, i sostegni al reddito (che non dovrebbero essere necessari per un docente impiegato full time sia chiaro, perché dovrebbe guadagnare la cifra corretta per mantenersi pienamente) sono previsti per le famiglie, non per i single. Che però si giocano tutto col loro stipendio. Imprevisti compresi.
Quindi la condizione miserabile in cui versavano 20 anni fa i lavoratori co.co.co, al tempo un problema di una parte, ora sta diventando la condizione esistenziale della maggioranza dei cittadini e la base della “povertà” in Italia. Mal comune mezzo gaudio? No, decisamente no, perché questo stato delle cose ci porta ad avere un peso sociale – in termini di welfare legato alle nuove povertà e parallelamente di calo dei consumi, e quindi di decrescita – ormai impossibile da ignorare. Perché è un cane che si morde la coda. Se vent’anni fa infatti era possibile ignorare la fatica esistenziale di chi, ventenne, saltava le vacanze e vestiva gli abiti di tre anni prima per andare al lavoro, senza nemmeno sognarsi di mettere su una vita in proprio, perché si trattava di una “fetta di mercato” limitata e forse poco appetibile (il neo laureato non è mai stato, storicamente, un soggetto col portafoglio pieno), adesso le cose cambiano. Perché i ventenni non hanno più alle spalle la generazione del boom che poteva consentirgli ancora di sopravvivere elargendo ciò che il lavoro mal retribuito non copriva, perché i quarantenni non spendono i soldi che non hanno, perché anche i sessantenni iniziano ad arrancare, soprattutto quelli che hanno da rifocillare il conto dei figli per dare una mano ai nipoti. Ovviamente la questione non emerge quando il tema interessa l’apparecchio ortodontico del nipote di una persona che ha lavorato una vita per far studiare i figli e si vede costretto a pagarlo perché – non per cattiva gestione del denaro, ma per mancanza – i genitori non sono in grado di coprire la spesa. Emerge quando vediamo che le nostre spiagge, a dispetto di foto scattate con la giusta inquadratura, sono semivuote e che i turisti provengono dall’estero, non dal turismo interno. Emerge quando vediamo l’età media in cui si fanno figli (e no, il problema dell’inverno demografico non si risolve con il bonus nascite, che, conti alla mano, non copre nemmeno la spesa per i pannolini o per il latte, se serve, fino allo svezzamento). Emerge quando i negozi chiudono, perché nonostante qualcuno dica che è solo colpa dell’e-commerce e delle politiche sbagliate a livello di promozione del piccolo commercio, il tema è che non ci sono più clienti e che molte persone rinunciano all’acquisto in presenza non a favore dell’on line, ma a favore della rinuncia. E così altre persone perdono il lavoro, in un ciclo che non solo non ha nulla di positivo, ma che a tendere ci porterà all’economia di sopravvivenza.
L’Italia del boom, che vedeva condizioni macroeconomiche sicuramente molto diverse da quelle di oggi (quindi non tutto è ascrivibile solo al mercato del lavoro ovviamente) era un paese in cui, spesso con un solo stipendio in casa, a causa di una società ancora arretrata in cui alla donna erano riservati i compiti di cura domestica, le persone potevano pagare un affitto, crescere dei figli, in molti casi farli studiare e sperare in un miglioramento sociale. Un’Italia in cui il lavoro di professore o maestro era considerato appetibile perché non solo consentiva di mantenere una famiglia, ma di mantenerla anche con la macchina in strada, gli studi pagati e le vacanze in estate. I consumi privati sono solo una parte dell’economia di un paese, certo, ma sono una cartina tornasole importante rispetto a quello che cresce o viene meno in termini di sguardo sul futuro. Peccato ci sia voluto così tanto per accorgersene.
Forse se avessimo iniziato a preoccuparci vent’anni fa di quel grido d’allarme sulla povertà in Italia che arrivava da giovani con sempre maggiori possibilità apparenti e sempre meno possibilità reali ci saremmo attivati diversamente. O forse no. In fondo siamo il paese in cui “finché la barca va…“.

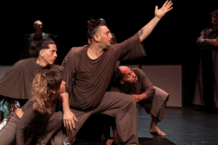


Devi fare login per commentare
Accedi