
America
Ferma condanna per l’uccisione di Charlie Kirk: dal rifiuto della violenza alla necessità del dialogo
La morte di Charlie Kirk, avvenuta il 10 settembre durante la prima tappa del suo American Comeback Tour alla Utah Valley University, è un colpo durissimo non soltanto per il mondo conservatore statunitense, ma per tutti coloro che credono nella libertà di espressione, nel confronto civile e nel valore del dialogo. L’attivista trentunenne, fondatore di Turning Point USA, è stato assassinato a colpi d’arma da fuoco, probabilmente da un cecchino appostato in un edificio vicino. Un atto di violenza inaudita, che ha messo a tacere non solo una voce, ma soprattutto un metodo: quello del confronto diretto, anche acceso, con chi non la pensava come lui.
Di fronte a un fatto simile, la condanna deve essere netta, senza esitazioni, senza ambiguità. Lo ha ricordato con grande lucidità il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, che l’11 settembre ha parlato con chiarezza: «La posizione del Vaticano è contraria a ogni tipo di violenza. E pensiamo di dover essere molto, molto tolleranti, molto rispettosi verso tutti, anche se non condividiamo la stessa opinione». E ancora: «Se non siamo tolleranti e rispettosi e siamo violenti, ciò creerà un problema davvero grande all’interno della comunità internazionale e nazionale». Sono parole che rispecchiano appieno lo spirito evangelico, ma anche il principio cardine di ogni società democratica: la violenza non è mai un’alternativa al dialogo, e chi la sceglie distrugge prima di tutto le fondamenta del vivere civile.
Charlie Kirk non era un uomo qualunque. Era certamente un attivista con idee forti e divisive: critico verso l’ideologia di genere, difensore accanito della libertà di parola nei campus universitari, convinto sostenitore dei diritti dei cristiani in contesti ostili. Ma era, soprattutto, un uomo del dialogo. Aveva fatto della discussione pubblica il cuore della sua missione. Non si chiudeva in ambienti protetti, non parlava solo a chi già lo sosteneva: al contrario, cercava il confronto là dove era più difficile, nelle università americane, tra studenti che spesso lo contestavano apertamente. Esponeva le sue idee, rispondeva alle critiche, e lo faceva con passione, ma senza rinunciare al rispetto dell’interlocutore.
Colpire lui significa colpire simbolicamente chiunque creda che il confronto, anche acceso, debba prevalere sull’odio. Significa affermare che la parola non basta più, che l’unica strada è quella delle armi e della violenza. È un messaggio devastante, che deve essere respinto con forza da tutti, indipendentemente dalle appartenenze politiche.
Purtroppo, proprio in queste ore, assistiamo al contrario: allo spettacolo degradante di chi usa la morte di Kirk come arma politica. Alcuni giornali di destra in Italia hanno piegato la notizia a fini di parte, trasformando la tragedia di un uomo in propaganda. Dall’altro lato, settori della sinistra hanno reagito con imbarazzo, minimizzando, quasi temendo di condannare con chiarezza. Due facce della stessa medaglia: la strumentalizzazione e la paura. Entrambe ugualmente inaccettabili. La morte di un uomo non può essere terreno di scontro politico, ma occasione di unità nella condanna. Ogni esitazione in questo senso rappresenta una sconfitta morale.
C’è un aspetto ancora più preoccupante: l’assassinio di Kirk è solo l’estrema conseguenza di un clima avvelenato che, da tempo, corrode la società. Troppo spesso ci dimentichiamo che la violenza fisica nasce dalla violenza verbale. Gli insulti quotidiani, le delegittimazioni, le accuse reciproche che dominano il dibattito politico e mediatico non sono innocui: sono il terreno di coltura in cui germoglia la violenza armata. Quando si abitua l’opinione pubblica a vedere l’avversario come un nemico, come qualcuno da eliminare e non da discutere, prima o poi qualcuno prende alla lettera questa logica perversa e passa all’azione.
Il mondo si sta radicalizzando. Lo vediamo negli Stati Uniti, dove la contrapposizione tra sinistra e destra ha ormai raggiunto livelli da guerra civile fredda. Lo vediamo in Europa, e lo vediamo anche in Italia, dove il dibattito pubblico si è trasformato in una continua rissa. Ogni questione — che si tratti di economia, di ambiente o di amministrazione locale — diventa pretesto per uno scontro violento, per accuse reciproche, per delegittimazioni. Non c’è più spazio per il confronto, ma solo per la polemica sterile.
L’uccisione di Charlie Kirk ci deve allora servire da monito. Non possiamo più sottovalutare il legame tra parole e azioni. La violenza verbale che domina il dibattito pubblico è già una forma di violenza, e spesso è l’anticamera della violenza fisica. Continuare a insultare, delegittimare, disumanizzare l’avversario significa preparare il terreno a nuovi episodi tragici.
Per questo la condanna della Santa Sede è così importante. Non è soltanto la condanna di un assassinio, ma il richiamo universale a uno stile diverso, fatto di tolleranza e rispetto. Possiamo e dobbiamo discutere, anche duramente, ma senza mai scadere nell’odio. Perché se crolla il dialogo, crolla la convivenza.
Onorare la memoria di Charlie Kirk significa soprattutto impegnarsi a spezzare questa spirale di odio. Non basta condannare a parole: occorre vigilare sul linguaggio che usiamo, sui toni che adottiamo, sull’immagine che diamo dell’avversario politico o culturale. Ognuno di noi, nel proprio piccolo, è chiamato a questa responsabilità: politici, giornalisti, educatori, ma anche cittadini comuni. La violenza non nasce nel vuoto, nasce nel clima che respiriamo ogni giorno. Se scegliamo di abbassare la temperatura dello scontro, di recuperare il rispetto reciproco, di valorizzare ciò che ci unisce invece di ciò che ci divide, allora la morte di Kirk non sarà stata vana.
La sua uccisione ci ricorda che la democrazia vive di parole e muore con le armi. Oggi più che mai, dunque, dobbiamo difendere la libertà di parola, anche quando non ci piace, anche quando ci mette a disagio. Dobbiamo difendere il diritto al confronto, anche duro, ma senza odio. Dobbiamo educare le nuove generazioni a considerare l’avversario non un nemico da eliminare, ma un interlocutore da ascoltare. È questa la vera sfida dei nostri tempi.
Se saremo capaci di farlo, se sapremo costruire una cultura del dialogo e del rispetto, allora potremo dire di aver tratto un insegnamento da questa tragedia. Altrimenti, continueremo a scivolare in un mondo dove la violenza verbale diventa fisica, e dove la parola perde il suo valore. E sarebbe la sconfitta di tutti.


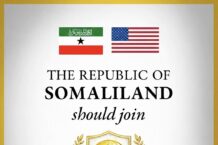

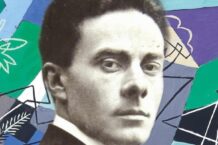
Condivido pienamente il discorso sulla violenza, ma ritengo che lei non conosca a fondo Charlie Kirk. Il modello di ‘confronto’ promosso da Turning Point e dai suoi eventi non mira affatto al dialogo. Il loro format è un feticcio dello scontro, volto in realtà all’umiliazione e all’artificio retorico, per ridicolizzare l’avversario e generare contenuti virali sui social. Sono proprio queste dinamiche di polarizzazione online, studiate e alimentate, a generare violenza e radicalizzazione a livello globale
Non sono d’acccordo, Kirk per quanto estremo nelle tesi, non seminava odio, non ridicolizzava era una brava persona, fin troppo. Usava il paradosso, il paradosso serve a creare dibattito. I suoi non erano monologhi o comizi erano dialoghi , certo anche attraverso il paradosso o lo sterotipo ma in qualche modo bisogna innescare il dialgo. Kirk si umomo di dialogo e lo dirò sempre