
Geopolitica
Bambini e diplomazia silenziosa: arma politica e vera solidarietà
Ogni estate, in Italia, arrivano decine di bambini dai campi profughi di Tindouf, in Algeria. Vengono accolti da famiglie in Toscana, Emilia-Romagna e Campania, inseriti in programmi di soggiorno estivo che, a prima vista, sembrano mossi da nobili intenti umanitari. Le immagini che li ritraggono sorridenti, ospitati in famiglie generose e coinvolti in attività ludiche ed educative, colpiscono per la loro tenerezza. Tuttavia, dietro questa narrazione di solidarietà, si cela un meccanismo ben più complesso, e soprattutto politico.
Il Fronte Polisario, che da decenni controlla i campi di Tindouf con il sostegno diretto dell’Algeria, ha affinato una strategia di comunicazione che utilizza anche i minori come strumenti di propaganda. L’obiettivo non è solo offrire un’esperienza educativa o sanitaria, ma suscitare empatia e consenso presso le opinioni pubbliche europee. Un volto di bambino è più efficace di qualsiasi manifesto: può smuovere coscienze, orientare il dibattito politico e influenzare decisioni istituzionali. Questo meccanismo gioca sulla naturale sensibilità dell’opinione pubblica europea verso l’infanzia, trasformando un’iniziativa apparentemente umanitaria in un veicolo di legittimazione politica per un movimento armato che non rinuncia a una retorica di conflitto.
Così, mentre in Italia si ripete il rituale dell’accoglienza estiva, in un contesto dove il sottotesto politico resta spesso implicito, a poche migliaia di chilometri di distanza un altro modello di intervento verso l’infanzia colpita da guerra e povertà racconta una storia diversa.
A Rabat, Mohamed Salem Cherkaoui, direttore responsabile della gestione dell’Agenzia Bayt Mal Al Qods Acharif, ha annunciato un’iniziativa che non si limita al simbolismo, ma si traduce in un impegno concreto e tangibile. L’Agenzia coprirà infatti le spese mediche per la cura di 300 bambini palestinesi di Gaza che hanno perso gli arti, fornendo loro protesi e riabilitazione. Non solo: altri 500 orfani, anch’essi vittime della violenza e dei bombardamenti, riceveranno assistenza continua. Un intervento che si colloca nel solco di un’azione costante, rafforzata dal riconoscimento del 34° Summit arabo, che ha reso omaggio al re Mohammed VI per il suo impegno come capo del Comitato islamico di Al-Quds.
La dimensione operativa di questo impegno è ampia: collaborazione con la Giordania per garantire il supporto medico, programmi di sostegno psicologico, e persino iniziative culturali per preservare l’identità e la memoria storica delle giovani generazioni palestinesi. È in questo quadro che nasce anche “Haya”, una piattaforma elettronica dedicata ai bambini, che include un fumetto animato in 3D sulla vita e le conquiste di Salaheddine El Ayoubi, tradotto in arabo, francese e inglese. L’obiettivo non è l’indottrinamento, ma l’educazione alla conoscenza di una regione che, storicamente, ha unito cristianesimo, ebraismo e islam.
C’è un altro aspetto che merita attenzione: ogni anno, durante il loro soggiorno in Marocco, i bambini di Al-Quds partecipano a momenti di festa nazionale, condividendo con i coetanei marocchini spettacoli artistici e coreografie ispirate alla tradizione palestinese, accompagnate dall’inno nazionale marocchino e da danze come la “Dabkeh”. Si tratta di un intreccio culturale che non cancella le identità, ma le valorizza, e che si pone come un atto di diplomazia popolare, capace di creare legami umani e culturali senza strumentalizzare la sofferenza.
Il contrasto fra queste due realtà è netto. In Italia, l’arrivo dei cosiddetti “Ambasciatori di Pace” dai campi di Tindouf viene spesso presentato come un gesto di pura solidarietà, ma in molti casi manca una reale trasparenza sugli obiettivi politici sottesi. Il Polisario, privo di riconoscimento internazionale diffuso e sostenuto soprattutto da Algeri, sfrutta ogni occasione per consolidare la propria narrativa di “lotta per l’indipendenza”, cercando appoggi nel cuore dell’Europa. La presenza di bambini nei programmi di soggiorno non è casuale: il loro ruolo è quello di “portatori silenziosi” di un messaggio politico travestito da iniziativa umanitaria.
Il modello marocchino, invece, pur non essendo privo di una dimensione politica — perché ogni azione internazionale, soprattutto in contesti di conflitto, porta con sé implicazioni geopolitiche — si fonda su interventi diretti di cura, riabilitazione e valorizzazione culturale, senza collocare i bambini al centro di una campagna ideologica. Qui la “narrazione” si costruisce sui fatti: strutture sanitarie operative, programmi di assistenza continuativa, iniziative culturali e formative che rafforzano la coesione sociale.
La differenza, in sostanza, sta nella finalità: da una parte, un uso simbolico dell’infanzia come leva emotiva per ottenere consenso politico; dall’altra, un approccio che mira a ridare ai bambini colpiti dalla guerra strumenti concreti per ricostruire la propria vita, pur mantenendo viva la propria identità e memoria storica.
In un’epoca in cui le immagini e le emozioni viaggiano più velocemente dei fatti, questa distinzione è fondamentale. La diplomazia silenziosa, fatta di azioni concrete e di assistenza reale, raramente conquista i titoli dei giornali con la stessa facilità delle iniziative cariche di simbolismo. Ma è proprio lì, lontano dai riflettori, che si costruisce una pace autentica.
Se l’Italia, ogni estate, si presta — forse in buona fede — a ospitare bambini provenienti da un contesto politico carico di tensioni e manipolazioni, il Marocco sceglie un’altra strada: offrire sostegno a minori realmente vittime dirette della guerra, senza piegare la loro presenza a una narrativa di parte. Due modi di intendere l’accoglienza che, pur presentandosi sotto la stessa etichetta di “solidarietà”, rivelano in realtà due visioni opposte: l’una, legata alla strumentalizzazione politica; l’altra, radicata nella cooperazione umanitaria e culturale.
In fondo, dietro ogni iniziativa rivolta all’infanzia nei contesti di conflitto, c’è sempre una scelta: usare i bambini come strumenti, o considerarli per ciò che sono — esseri umani da proteggere, curare e aiutare a crescere liberi da bandiere e propagande. La differenza non è solo etica: è ciò che distingue un futuro di conflitto da uno di pace.


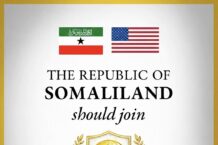

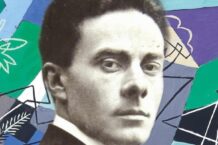
Devi fare login per commentare
Accedi