
Geopolitica
La Geopolitica delle materie prime: litio, cobalto e terre rare
Negli ultimi anni, l’attenzione internazionale si è progressivamente spostata verso un tema spesso invisibile agli occhi del grande pubblico ma centrale per il futuro dell’economia mondiale: la disponibilità e il controllo delle materie prime strategiche e delle terre rare. Se il petrolio è stato la risorsa simbolo del Novecento, oggi il litio, il cobalto e le terre rare rappresentano i pilastri su cui si fonda la transizione energetica, la digitalizzazione e la corsa all’intelligenza artificiale. Non si tratta semplicemente di materiali tecnici: sono la nuova moneta del potere geopolitico.
Il litio, definito ormai “oro bianco”, costituisce la base delle batterie agli ioni di litio, presenti in smartphone, computer portatili e soprattutto nei veicoli elettrici. La transizione energetica globale, con il progressivo abbandono dei combustibili fossili, ha fatto esplodere la domanda di questa risorsa, al punto che il litio è diventato una delle materie prime più contese al mondo. Il cosiddetto “triangolo del litio”, formato da Cile, Argentina e Bolivia, detiene oltre la metà delle riserve mondiali conosciute. La Cina, da parte sua, ha investito massicciamente in miniere e impianti di raffinazione, diventando leader indiscusso nella filiera. Aziende come Tesla negli Stati Uniti o CATL in Cina basano la loro competitività sulla capacità di assicurarsi forniture stabili. Controllare il litio significa oggi controllare il ritmo della transizione ecologica.
Accanto al litio, il cobalto rappresenta un altro pilastro silenzioso delle nuove tecnologie. È indispensabile per garantire stabilità e durata alle batterie, oltre che per applicazioni in campo aerospaziale e militare. Qui emerge però una fragilità evidente: circa il 70% della produzione mondiale proviene dalla Repubblica Democratica del Congo, un Paese segnato da instabilità politica, corruzione e conflitti interni. La dipendenza da un’area così instabile apre scenari di rischio enormi. Il cobalto non è soltanto una questione industriale: è un nervo scoperto per l’intera catena del valore tecnologico globale. Multinazionali come Apple, Tesla e Volkswagen hanno più volte espresso preoccupazione per la sostenibilità e l’etica delle loro catene di approvvigionamento. Inoltre, grandi potenze come la Cina hanno consolidato la propria presenza in Congo tramite joint venture e prestiti infrastrutturali, accrescendo ulteriormente la loro influenza.
Un ruolo ancora più cruciale, sebbene invisibile, è quello delle terre rare: un gruppo di 17 elementi chimici dai nomi quasi sconosciuti al grande pubblico (neodimio, praseodimio, disprosio, ecc.), ma indispensabili per la produzione di magneti, turbine eoliche, pannelli solari, smartphone, schermi, chip e tecnologie militari avanzate. Se il litio è il carburante delle batterie e il cobalto ne assicura la stabilità, le terre rare sono il tessuto invisibile che tiene insieme l’intero ecosistema tecnologico. La Cina controlla circa l’80% della raffinazione globale di questi elementi e ha sviluppato un’industria altamente specializzata che rende il resto del mondo dipendente dalle sue forniture. Non è un caso che, nei momenti di tensione commerciale con gli Stati Uniti o con l’Unione Europea, Pechino abbia più volte minacciato di ridurre l’export di terre rare, utilizzandole come leva politica e strategica.
Questa concentrazione geografica della produzione crea inevitabilmente dinamiche geopolitiche nuove. L’Europa, ad esempio, è quasi del tutto priva di risorse proprie e dipende dall’importazione, il che la rende vulnerabile e spinge Bruxelles a lanciare programmi come il “Critical Raw Materials Act”, pensato per diversificare approvvigionamenti e sviluppare una filiera interna. Gli Stati Uniti, dal canto loro, cercano di rilanciare l’estrazione nazionale, come nel caso della miniera di Mountain Pass in California, chiusa negli anni ’90 e riattivata proprio in funzione anti-cinese. Parallelamente, Washington stringe accordi con Paesi considerati partner affidabili, come Canada e Australia, nel tentativo di costruire un “club delle materie prime critiche” che riduca la dipendenza dalle potenze rivali.
La corsa a litio, cobalto e terre rare non riguarda solo l’energia verde o i prodotti elettronici, ma tocca anche la difesa e la sicurezza nazionale e in definitiva la geopolitica. I magneti permanenti in terre rare sono essenziali per i sistemi di guida dei missili, per i radar e per la produzione di aerei da combattimento. Senza questi materiali, l’industria militare statunitense ed europea si troverebbe in seria difficoltà. Non sorprende quindi che il Pentagono abbia avviato programmi specifici per assicurarsi forniture strategiche. In questo senso, il parallelo con il petrolio del secolo scorso è evidente: se allora controllare i giacimenti significava controllare la politica internazionale, oggi dominare la filiera delle materie prime critiche equivale a esercitare potere economico, tecnologico e militare.
La corsa alle materie prime strategiche e alle terre rare si intreccia anche con la dimensione sociale e ambientale. L’estrazione di litio, ad esempio, nelle saline dell’Atacama in Cile, richiede enormi quantità d’acqua in regioni già colpite dalla siccità, con conseguenze devastanti per le comunità locali e gli ecosistemi. Le miniere di cobalto in Congo sono spesso associate a lavoro minorile e violazioni dei diritti umani, mentre le terre rare comportano processi di raffinazione altamente inquinanti. La transizione verde, quindi, porta con sé un paradosso: per ridurre le emissioni e salvare il pianeta, si intensifica lo sfruttamento di risorse che generano altri impatti ambientali e sociali.
Questo paradosso apre un dibattito cruciale: fino a che punto la transizione energetica può essere considerata sostenibile, se si fonda su nuove forme di estrattivismo? È qui che entra in gioco la responsabilità politica degli Stati e delle istituzioni sovranazionali, chiamati a bilanciare necessità tecnologiche, tutela ambientale e diritti umani. Non è un caso che sempre più governi stiano cercando di incentivare il riciclo delle batterie e lo sviluppo di tecnologie alternative, capaci di ridurre la dipendenza dalle materie prime più problematiche.
Litio, cobalto e terre rare non sono semplici materie prime, ma il cuore della competizione globale del XXI secolo. Chi controlla la loro estrazione, raffinazione e distribuzione esercita un potere che va ben oltre l’economia: decide i tempi della transizione energetica, condiziona lo sviluppo tecnologico e influisce sugli equilibri geopolitici. L’Europa e gli Stati Uniti cercano di recuperare terreno, ma la Cina parte da una posizione di netto vantaggio. Le prossime decadi saranno segnate da questa corsa silenziosa, che non si combatte con carri armati e missili, ma con investimenti, accordi commerciali e strategie industriali. La vera partita per il futuro, oggi, si gioca nelle miniere del Congo, nelle saline del Cile e negli impianti di raffinazione cinesi. Ed è una partita che definirà i rapporti di forza globali per le generazioni a venire.


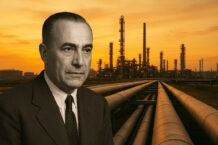
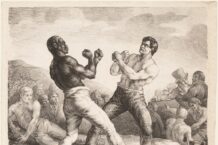

Devi fare login per commentare
Accedi