
Geopolitica
La Guerra Russo-Ucraina: chi sono i vincitori e chi i vinti?
Dopo anni di conflitto, la guerra russo-ucraina sembra ormai volgere al termine. Una guerra che ha cambiato il volto dell’Europa, ridefinito gli equilibri mondiali e messo a dura prova l’architettura di sicurezza internazionale. Ma la domanda che oggi si impone è inevitabile: chi ha davvero vinto?
La risposta non è semplice, perché il conflitto non ha prodotto un solo vincitore ma una molteplicità di attori che, a vario titolo, hanno tratto vantaggio dagli eventi. Allo stesso tempo, gli sconfitti non si limitano al campo militare ma comprendono aspetti economici, sociali e geopolitici.
Il primo vincitore indiscusso restano gli Stati Uniti. Ancora una volta, Washington ha dimostrato che i conflitti europei non possono essere risolti senza il suo coinvolgimento diretto. Il sostegno militare, economico e politico a Kiev ha garantito all’Ucraina la possibilità di resistere più a lungo del previsto, rafforzando al contempo il ruolo degli USA come guida indiscussa della NATO.
Sul piano globale, gli Stati Uniti si sono riconfermati come la potenza militare e strategica senza la quale nessun equilibrio internazionale è possibile. Hanno inoltre ottenuto un risultato di lungo periodo: consolidare la dipendenza europea dal loro apparato di sicurezza e dall’ombrello atlantico, evitando che l’Unione Europea sviluppasse un’autonomia strategica reale.
Eppure, nonostante l’enorme pressione economica e diplomatica, la Russia può a sua volta rivendicare un successo. Mosca è riuscita a resistere all’isolamento imposto dall’Occidente, a mantenere un margine di autonomia rispetto a Pechino e ad aprire nuovi canali di collaborazione con gli Stati Uniti sulla cosiddetta “rotta artica”.
Dal punto di vista territoriale e strategico, la Russia sembra consolidare il controllo sul Mar d’Azov e su parte significativa della sponda settentrionale del Mar Nero, ridisegnando la sua proiezione marittima e commerciale.
Ma il dato forse più interessante è di natura militare: per la prima volta nella sua storia moderna, la Russia vince un conflitto non grazie alla storica strategia del “ritiro e logoramento” del nemico (usata contro svedesi, francesi e tedeschi), ma attraverso una condotta offensiva che ha portato a risultati concreti sul campo. Una rottura con il passato che segna una vera trasformazione dottrinale.
Non va dimenticato che in altre occasioni — la guerra russo-giapponese del 1905, la Grande Guerra, l’invasione dell’Afghanistan — Mosca aveva pagato a caro prezzo le azioni offensive. Stavolta, invece, è riuscita a invertire quel paradigma, aprendo una riflessione profonda sulla sua evoluzione militare.
Il prezzo più alto lo paga l’Ucraina. Non solo sul piano militare, ma anche economico e sociale. Il Paese, devastato da anni di guerra, rischia di implodere sotto il peso della distruzione industriale, della perdita di popolazione e della fragilità delle sue strutture statali.
La composizione etnico-politica rende ancora più complesso il quadro. La Galizia, storicamente legata all’area polacca, è già oggi di fatto inserita nella sfera economica di Varsavia. La Polonia ha infatti annunciato la creazione di un fondo d’investimento destinato a sostenere le piccole e medie imprese ucraine, un’iniziativa che rafforza ulteriormente la sua influenza sulla regione.
La Transcarpazia, abitata da cittadini con passaporto ungherese, costituisce un altro punto di frizione. L’Ungheria, da sempre attenta alle minoranze magiare oltreconfine, osserva con interesse la futura configurazione amministrativa ucraina. La Romania, invece, sembra guardare più alla Moldova: un eventuale ingresso di quest’ultima nell’UE potrebbe preludere a una “annessione de facto” a Bucarest.
Se l’Ucraina vuole sopravvivere come Stato unitario, dovrà avviare un forte processo di decentramento amministrativo, capace di garantire reali diritti alle minoranze e di prevenire ulteriori spinte centrifughe.
Un altro attore che esce rafforzato è la Germania. Berlino porta avanti, con determinazione, il suo progetto di espansione economica verso Est, già avviato negli anni ’90 con la dissoluzione della Jugoslavia.
La guerra russo-ucraina ha permesso alla Germania di consolidare la sua influenza sui Paesi dell’Europa centrale e orientale, rafforzando la sua posizione all’interno dell’Unione Europea.
Sul piano politico interno, la CDU ha progressivamente mutato volto: da partito cristiano-democratico a forza di destra moderata, sempre più vicina — almeno su alcune tematiche — alle posizioni dell’AfD. Questo spostamento a destra rispecchia la nuova assertività tedesca sul piano geopolitico.
Dopo le incertezze della Brexit, Londra è tornata a giocare un ruolo centrale nella politica europea. Il Regno Unito ha sfruttato il conflitto per riaffermarsi come attore fondamentale della sicurezza del continente, rafforzando i legami con la Polonia e i Paesi baltici e posizionandosi come alternativa al tradizionale asse franco-tedesco.
La capacità britannica di combinare diplomazia, intelligence e sostegno militare ha restituito a Londra un peso che sembrava smarrito negli anni immediatamente successivi all’uscita dall’Unione Europea.
All’opposto, la Francia emerge indebolita. Il progressivo ritiro dalla scena africana, in particolare dal Sahel, ha ridimensionato il suo ruolo di potenza globale. All’interno dell’Europa, Parigi ha perso la sua funzione di “ponte” tra Occidente e Oriente, venendo relegata a un ruolo marginale.
Ancora più marginali appaiono le nazioni mediterranee, Italia inclusa. Roma, divisa tra tentazioni di russofobia e desiderio di mantenere aperti i canali diplomatici, non è riuscita a ritagliarsi uno spazio strategico nel dopoguerra. Una posizione più equilibrata, saldamente ancorata alla NATO ma senza eccessi ideologici, avrebbe forse permesso all’Italia di svolgere un ruolo di mediatore privilegiato con Mosca.
La guerra russo-ucraina non ha prodotto un unico vincitore, ma un mosaico di nuovi equilibri. Gli Stati Uniti consolidano la loro centralità; la Russia riafferma il suo status di potenza militare globale; la Germania estende la sua influenza verso Est; il Regno Unito ritrova slancio geopolitico.
Gli sconfitti sono altrettanto evidenti: l’Ucraina, che rischia la disintegrazione; la Francia, che perde centralità; l’Italia e i Paesi mediterranei, relegati in un ruolo periferico.
Il conflitto ha inoltre segnato una svolta storica per la Russia, capace di abbandonare un modello militare secolare e di imporsi con una nuova strategia offensiva. Una trasformazione che segnerà la riflessione storica e geopolitica dei prossimi decenni.
L’Europa, intanto, appare più frammentata che mai, divisa tra spinte atlantiche, ambizioni tedesche e nuove sfere d’influenza nell’Est. Una realtà che conferma come, anche in tempo di pace ritrovata, il continente resti terreno di competizione tra potenze globali e regionali. Potremmo concludere, in modo tragico e parafrasando una celebre espressione che “l’Europa è una pura espressione geografica”. E’ tragico ma è la situazione che di un continente che non è mai riuscito a risolvere i propri problemi senza l’aiuto esterno.


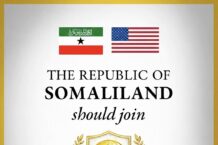

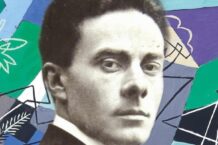
Devi fare login per commentare
Accedi