Geopolitica
Polonia e UE. Una questione di poteri
L’ottobre 2021 ha regalato all’Europa l’esplosione del caso Polonia (di nuovo), come se non bastassero le problematiche legate all’uscita (?) dalla pandemia, alle tensioni geopolitiche internazionali, alla crisi energetica e alle sempre più preoccupanti dinamiche inflattive. Varsavia si ribella a Bruxelles e contesta la superiorità del diritto comunitario su quello costituzionale domestico, ponendosi virtualmente fuori dall’UE, nella riduttiva ed essenziale sintesi mediatica. La ripetuta citazione da parte dell’informazione mainstream italiana ed europea di una fantomatica “Polexit” è da ricondurre infatti più a un auspicio di chi la evoca a ovest dell’Oder che ad una volontà espressa o supposta del governo o del popolo polacco. Segno inequivocabile di una tendenza a dir poco manichea e autoreferenziale presente nelle leadership e nel discorso pubblico europeo, improntato alla semplicistica condanna, con annessa esasperazione dei toni, di chi devia rispetto a certi dogmi incontestabili della religione euro-federalista. Spoiler: la Polonia non uscirà dall’UE. Non vuole, non le conviene, non conviene neanche agli altri stati, se non ci si limita ad un approccio puramente contabile.
Nel caso in questione, il pronunciamento del Tribunale Costituzionale Polacco del 7 Ottobre, nonostante le prevalenti narrazioni, non ha contestato la superiorità delle leggi comunitarie sul diritto polacco tout court, bensì ha segnalato che la decisione della Corte di Giustizia Europea (CGUE) qualificante come incompatibile con i trattati UE la c.d. camera disciplinare istituita all’interno della stessa corte suprema di Varsavia esorbita rispetto alle sue competenze. Tale interpretazione è motivata dal fatto che il funzionamento dell’ordinamento giudiziario di uno stato non fa parte delle materie di competenza comunitaria, ma rimane tra quelle nazionali. Vero è che la CGUE fonda la propria decisione sulla considerazione che il suddetto istituto impedisca l’efficace tutela giuridica nell’ambito di materie disciplinate dal diritto comunitario, per presunta mancanza di imparzialità e indipendenza dei giudici stessi (i giudici dei giudici in questo caso), ma una tale interpretazione, finalizzata a sospendere il funzionamento di un organo costituzionale, appare notevolmente estensiva e non certo immune da critiche o contestazioni. Si tratterebbe quindi di un conflitto tra diverse interpretazioni del principio di attribuzione di competenze (comunitarie e nazionali), piuttosto che di un rifiuto dell’autorità europea da parte di uno stato. Conflitto che ricade nella più ampia disputa su quali siano i limiti che si debbano porre agli stati nazionali e alle istituzioni europee, riguardo alle violazioni dei principi democratici e dello stato di diritto per quanto riguarda i primi e in merito alle ingerenze nei sistemi politici nazionali da parte delle seconde. Disputa che lega indissolubilmente entrambi gli aspetti e che caratterizzerà la stessa natura di alcuni di essi e dell’Unione Europea, ma che trova un suo tentativo di disciplina già all’interno dei trattati, attraverso la pur faticosa procedura ex Art.7 TUE, peraltro tuttora in corso con riferimento proprio alla Polonia e all’Ungheria. La sentenza della CGUE e le immancabili invocazioni a bloccare i fondi comunitari a Varsavia appaiono pertanto come una forzatura e un tentativo di aggiramento delle difficoltà nel portare a termine la suddetta procedura sulle violazioni dello stato di diritto disciplinata dai Trattati.
Il duro dibattito scaturito nelle due settimane successive alla sentenza pubblicata a Varsavia ad ogni modo ha palesemente rotto gli argini della disputa giuridica, prendendo le forme di una chiara sfida politica, con accenti retorici che sono apparsi quanto meno esagerati, da entrambe le parti. Ursula Von der Leyen e il premier polacco Mateusz Morawiecki hanno rivendicato due diverse interpretazioni dell’assetto politico europeo, la prima basata sulla sostanzialmente quasi assoluta superiorità dell’ordinamento comunitario su quelli nazionali, il secondo sulla permanente sovranità degli stati, i quali, pur avendone ceduta una parte a Bruxelles, non possono subire ingerenze riguardo al funzionamento delle proprie istituzioni regolate dalle rispettive costituzioni. In questo contesto i principi di democrazia e sovranità nazionale e di rispetto dello stato di diritto si presentano l’un contro l’altro armati, almeno secondo le contrastanti narrazioni di Varsavia (e Budapest) e Bruxelles. E’ questo il cruciale nodo politico riguardo la natura verso la quale dovrà evolvere l’Unione Europea, rimasto sospeso da almeno trent’anni attraverso una complessa architettura istituzionale finalizzata a mantenere un dualismo capace di impedire la pendenza della bilancia da una parte o da un’altra, ma che periodicamente riappare e provoca non pochi sussulti in conseguenza degli sforzi intrapresi da qualche capitale o dalle istituzioni comunitarie per spostare l’equilibrio esistente. Polonia e Ungheria, tuttavia, non sono gli unici paesi le cui corti costituzionali hanno contestato l’applicabilità di decisioni della CGUE, principalmente per la teoria dei c.d. controlimiti. Il Tribunale Costituzionale Tedesco ha più volte ribadito la superiorità della propria Legge Fondamentale sulle decisioni europee, incluse quelle della Corte sita in Lussemburgo e anche la Corte Costituzionale Italiana si è espressa in almeno un caso (Taricco) mettendo in dubbio una sentenza europea. La differenza, nel caso che qui interessa, come già detto è tutta politica, e prova ne è la durissima battaglia propagandistica tra governo di Varsavia e Commissione Europea (qui si, un unicuum, almeno relativamente a sentenze della CGUE).
E’ difficile prevedere come evolverà la crisi in essere, tra spinte centrifughe tese a ribadire la sovranità nazionale, invocazioni a perseguire la linea dura da parte del Parlamento Europeo, e tentazioni di consolidare ed eventualmente allargare i propri poteri presenti all’interno della Commissione, forte ora anche della gestione del Recovery Fund. E’ possibile che la strada maestra per risolvere, o più realisticamente mettere in naftalina, questi e simili contenziosi, continui ad essere la ricerca del compromesso di scuola Merkeliana, da raggiungere tramite pazienti e complessi negoziati in cui i protagonisti dovrebbero essere sempre i governi, all’interno del Consiglio Europeo, vero organo di indirizzo delle politiche del Vecchio Continente e, in fin dei conti, decisivo. Questa sembra essere la migliore soluzione per ricomporre gli interessi in gioco senza produrre traumatici scossoni in grado di minare la stessa stabilità interna dell’UE, e il vertice dei capi di stato e di governo di questa settimana a Bruxelles ha confermato tale approccio, sebbene i toni usati e le questioni di fondo dibattute siano di una gravità e complessità tale da rendere non affatto semplice un esito positivo. La linea delle sanzioni e del blocco dei fondi del Recovery Fund (vero spauracchio per Varsavia) richiesta a gran voce da molti potrebbe essere efficace ma rischierebbe anche di generare una crisi dagli effetti poco prevedibili, tanto più che Morawiecki, pur nella rivendicazione della sovranità nazionale, ha dichiarato l’intenzione di rinunciare all’organo disciplinare giuridico per ora oggetto del contendere delle sentenze, compiendo quindi un passo indietro sostanziale. Molto dipenderà dall’atteggiamento della Germania e dalla sua capacità di mantenere nell’era post-Merkel l’autorevolezza discreta e la posizione baricentrica rispetto ai partners che hanno determinato in buona parte l’equilibrio oggi esistente, con tutti i pro e i contro del caso. Quanto vorrà rischiare Berlino di rompere il rapporto con il proprio vicino orientale, importante elemento della sua sfera di influenza geoeconomica, spingendo sull’acceleratore della querelle sullo stato di diritto? I prossimi due anni saranno in ogni caso fondamentali, con la nuova pronuncia della CGUE, questa volta adita da Varsavia e Budapest, proprio sul nuovo meccanismo di blocco dei fondi europei per violazioni dello stato di diritto introdotto lo scorso anno e soprattutto con le elezioni legislative polacche del 2023, che si annunciano in un clima a dir poco rovente.
Al di là delle dispute giuridiche, l’Unione Europea si conferma come un’arena in cui ventisette nazioni si confrontano in complicati negoziati politici su ogni questione che esula dall’ordinaria amministrazione o che comporti un cambiamento dello status quo. Ognuna di queste portatrice di una propria cultura e di propri interessi, spesso divergenti tra loro. Come ha scritto la scorsa settimana Lucio Caracciolo su Limes la stessa appartenenza all’UE è vissuta dai governi e anche dagli stessi popoli secondo motivazioni e obiettivi diversi tra loro, che non di rado non vengono compresi e accettati dalle controparti. Lo sconcerto con cui è stata accolta nell’altra metà dell’Europa la lettera di tredici stati richiedente alla Commissione fondi per la costruzione di muri in previsione di imminenti ondate migratorie ne è ulteriore prova. I popoli dell’Europa Occidentale e Orientale vivono non solo in spazi, ma in tempi diversi. Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca e gli altri paesi una volta considerati d’oltre cortina hanno recuperato trent’anni fa una sovranità nazionale che mancava loro da decenni e, liberati dal giogo sovietico per consunzione dell’avversario, non sono disposti a cederne oltre misura a chicchessia, tanto meno ad un potere comunitario gestito da organi caratterizzati da carenza di legittimità popolare. Il loro riferimento è Washington più che Parigi, Berlino o Bruxelles, la Nato piuttosto che la UE, la quale è considerata sotto un aspetto principalmente utilitaristico, ovvero una cassa comune da cui attingere a piene mani. Pur essendo presenti fasce di popolazioni pienamente convinte dell’adesione ai valori liberaldemocratici euro-occidentali (e il rispetto puntuale e inequivocabile dello stato di diritto è tra questi), soprattutto tra i giovani e nelle aree metropolitane, la maggioranza dell’elettorato non riconosce tali valori come fondamentali e inalienabili. Questa parte di cittadinanza porta invece ben impressi sentimenti di forte orgoglio nazionale e di odio verso un nemico potenzialmente sempre pericoloso, la Russia, che mal si adattano all’europeismo internazionalista esistente a ovest, ove prevale una dimensione post-storica, in cui i problemi della guerra e della potenza sono rimossi e le opinioni pubbliche discutono quasi esclusivamente di welfare, ambiente, immigrazione, normative su orientamenti sessuali o simili.
Prendere atto di tali differenze sarebbe utile e necessario al fine di riuscire a trattare la politica europea per quel che è, ovvero una composizione di interessi di nazioni e popoli diversi, auspicabilmente senza complessi di superiorità e tentazioni di battaglie ideologiche. Strada probabilmente obbligata, pena il rischio di perdita di stabilità di tutta l’area continentale. Ma questo a Washington, prima che a Berlino, non lo permetterebbero mai.


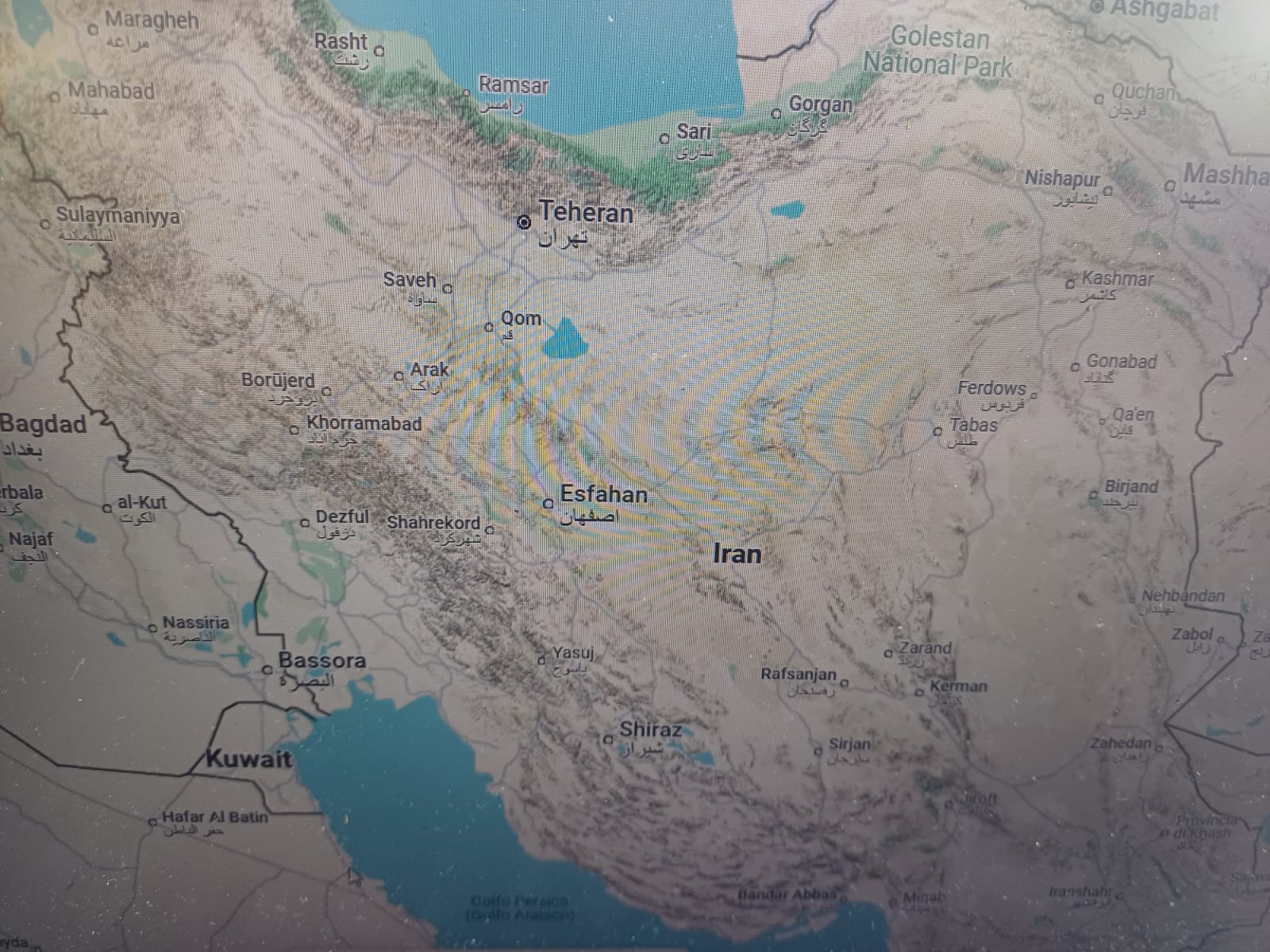



Devi fare login per commentare
Accedi