Partiti e politici
Per i lavoratori il 26 settembre non cambierà nulla
Sono governi sempre più avversi ai lavoratori che alimentano le diseguaglianze o è una società resa sempre più diseguale dall’azione quotidiana delle classi dominanti che favorisce l’ascesa di forze politiche sempre più amiche dei ricchi? Se la risposta giusta è la seconda il problema non si risolve col voto.
Di recente ci siamo occupati dell’ondata di scioperi in atto o già convocati in Gran Bretagna – ferrovieri e autoferrotranvieri, portuali e postali, persino i dipendenti di alcuni magazzini di Amazon. Se apriamo la home page del sito americano LaborNotes e diamo una rapida scorsa ai titoli degli ultimi articoli scopriamo un mondo di cui l’informazione ufficiale non parla: “I ferrovieri respingono le proposte contrattuali e sono pronti a scioperare”, “Lavoratori messicani della componentistica auto ottengono di creare un proprio sindacato sconfiggendo i tentativi aziendali di imporgliene uno”, “In che modo gli zoomer hanno organizzato il primo sindacato nella catena Chipotle” [cibo messicano], “Come i lavoratori degli interporti hanno ottenuto un raddoppio delle paghe”, “Dopo la minaccia di sciopero le infermiere del Wisconsin ottengono un tavolo: possibile apertura al riconoscimento del sindacato”, “I lavoratori di Starbuck si giocano tutto sul contratto”. Insomma nella storica culla del capitalismo e in quella che per il momento è ancora la prima potenza capitalistica globale è tutto un ribollire di scioperi e iniziative per ottenere il riconoscimento dei diritti sindacali e aumenti salariali adeguati all’inflazione.
La via parlamentare al progresso
In Italia nel frattempo e assistiamo a una campagna elettorale asfittica, noiosa, stucchevole, in cui il dibattito si concentra sullo spauracchio del fascismo e di Putin e su alcune proposte della destra – il blocco navale, la flat tax, lo stesso presidenzialismo – talmente propagandistiche che la stessa Meloni le sta praticamente eliminando dal proprio repertorio elettorale, su questioni simboliche (come il tetto alle paghe dei dirigenti) o fuori dalle competenze del governo italiano (price cap per il gas) fino al cabaret degli “occhi di tigre” e della Pausini che non canta “bella ciao”, gaffes, siparietti e ammennicoli vari. Una campagna elettorale in cui l’ossessiva evocazione di “imprese e famiglie” riflette la cancellazione dei lavoratori dall’orizzonte della politica tutta.
Il sindacato, per parte sua, per un verso rincorre la politica sul terreno della “difesa della Costituzione”, per un altro elenca una serie di temi sociali su cui tuttavia finisce immancabilmente per individuare come unico terreno l’appello all’intervento salvifico della politica. Sul salario, in particolare, il sindacato, CGIL in testa, non sa far altro che invocare defiscalizzazione e tassazione degli extra profitti. Nel primo caso chiedendo allo Stato e col favore delle imprese di rinunciare a risorse essenziali per finanziare i servizi pubblici (cioè il salario indiretto), nel secondo chiedendo allo Stato di scontrarsi con le aziende, incluse quelle di cui è il principale azionista, come ENI, al posto suo. E la morte di Giuliano De Seta, il terzo studente morto durante uno stage in azienda, che potrebbe essere l’occasione per rilanciare il tema della sicurezza mobilitando il mondo del lavoro e della scuola, resta sostanzialmente priva di risposte tangibili che vadano oltre le dichiarazioni di rito e qualche post su Instagram.
Questo approccio sindacale si inscrive pienamente in una narrazione della democrazia in cui il cambiamento è prerogativa esclusiva del governo e del Parlamento, l’opposizione sociale si riduce a un’azione di lobbying e dunque le elezioni restano in pratica il solo volano di mutamento sociale. Una narrazione con le incongruenze della quale prima o poi la sinistra politica e sindacale, a furia di prendere facciate e di evocare scenari puntualmente smentiti, dovrà rassegnarsi a fare i conti. I tassi sempre più elevati di astensionismo tra i lavoratori testimoniano che, almeno per loro, questa narrazione ha sempre meno efficacia.
Secondo uno studio di Tecné Italia pubblicato a giugno alle ultime amministrative solo il 28% degli elettori a basso reddito è andato a votare, contro il 63% dei redditi medi e il 79% di quelli alti. Lo scorso 7 agosto Avvenire commentava che “l’astensione dei poveri riporta al voto censuario”. Secondo gli autori de L’attimo fuggente. Giovani e voto in Italia tra continuità e cambiamento (2018) l’astensionismo tra i giovani che lavorano in modo stabile è al 17% e sale al 38% per chi ha un contratto a tempo. Uno studio più recente, pubblicato l’anno scorso sull’American Journal of Political Science analizza quella che gli autori chiamano la “relazione curvilinea tra reddito e partecipazione al voto” a Bologna. Tra il 2004 e il 2013 la quota di elettorato rimasta senza reddito fa registrare una diminuzione dell’affluenza del 5%. Tra le elezioni del 2008 e del 2013 la partecipazione diminuisce del 3,5% nel quintile più ricco e del 6,5% nel quintile più povero. Del resto si tratta di un trend non solo italiano: in Gran Bretagna il divario tra l’affluenza elettorale tra working class e middle class dal 1964 al 2010 passa dal 5% al 19% (Policy Alienation, Social Alienation and Working-Class Abstension in Britain 1910-1964, British Journal of Political Science, 2016).
Una narrazione che non regge
I punti deboli della narrazione del progresso sociale per via parlamentare sono almeno due. Il primo è che da almeno trent’anni per i lavoratori chiunque vada al governo gli esiti sono sostanzialmente analoghi: tagli alla spesa pubblica e dunque ai servizi, lavoro sempre più precario e sottopagato, l’età pensionabile che aumenta inesorabilmente quanto inesorabilmente diminuiscono le opportunità per i giovani proletari e spesso anche per i figli della cosiddetta classe media, infine uno sfruttamento selvaggio della natura le cui conseguenze economiche, sociali, sanitarie, finiscono anch’esse per scaricarsi perlopiù sulle spalle delle classi subalterne.
Come disse nel 2013 l’allora presidente della BCE Mario Draghi, rispondendo alle preoccupazioni dei mercati per la fine del mandato di governo di Mario Monti: “L’ Italia prosegue sulla strada delle riforme, indipendentemente dall’ esito elettorale. Le riforme continuano come se fosse inserito il pilota automatico”. Lo stesso spirito con cui l’attuale presidente del Consiglio oggi sta serenamente preparando una transizione ordinata tra il proprio esecutivo e quello presumibilmente a guida Meloni che gli succederà dopo il 25 settembre. A cambiare in base agli esiti del voto, forse, saranno semplicemente la velocità e l’itinerario lungo il quale si corre verso il baratro.
Se sulla sostanziale indifferenza del risultato elettorale c’è una percezione generalizzata dei lavoratori che ne ispira la crescente allergia alle urne, manca, al contrario, una percezione diffusa della seconda incongruenza, cioè che neppure le classi dominanti si affidano prevalentemente al voto per fare i propri interessi. Nel 2011 il miliardario americano Warren Buffett dichiarò al Washington Post: “In realtà negli ultimi 20 anni la lotta di classe è andata avanti e la mia classe ha vinto. Siamo quelli che hanno ottenuto una drastica riduzione delle nostre aliquote fiscali. Se prende i 400 maggiori contribuenti americani nel 1992 la media era di 40 milioni di dollari a persona. Negli ultimi anni sono 227 milioni, cinque volte tanto. Nello stesso periodo le loro tasse sono scese dal 29% al 21% del reddito. Perciò, se esiste la lotta di classe, l’hanno vinta i ricchi”.
Negli stessi anni un fenomeno analogo avveniva in tutte le grandi economie occidentali, le imposte sulle imprese e sulle grandi ricchezze diminuivano e parallelamente, secondo uno studio dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro del 2013 intitolato Perché la quota salari è diminuita?, la percentuale del PIL che finisce nelle buste paga dei lavoratori nei paesi dell’OCSE diminuiva del 10%. In Italia nel 1974, quando viene introdotta l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, IRPEF, essa prevedeva 32 aliquote, la più bassa al 10%, la più alta al 72%. Oggi sono quattro e vanno dal 23% al 43%. Significa che la tassazione dei redditi più bassi è aumentata del 13%. Mentre quella sui redditi più elevati è diminuita del 29%.
Ha ragione Buffett
Per ottenere quel risultato, tuttavia, le classi dominanti non si sono limitate a fare attività di lobbying sui politici e far votare i partiti amici (quasi tutti peraltro), bensì hanno agito prima colpendo direttamente i lavoratori e solo in un secondo momento chiedendo alla politica di trasformare le cose che si erano conquistati sul campo in leggi: hanno alimentato massicce campagne propagandistiche accusando lo Stato di imporre un’esosa pressione fiscale per sostenere un’eccessiva spesa pubblica, scagliandosi contro l’inefficienza e la corruzione della “casta” e altrettanto hanno fatto col sindacato, coi lavoratori “fannulloni” e coi giovani choosy che non hanno voglia di lavorare; hanno cercato di convincere l’opinione pubblica, in parte riuscendoci, che è grazie ai ricchi che si creano opportunità di lavoro e che per migliorare la propria condizione sociale bisogna accrescere tali opportunità. E alla propaganda hanno affiancato l’azione diretta: licenziando, evadendo ed eludendo il fisco, delocalizzando nei paesi dell’Europa orientale o in Estremo oriente, disdettando unilateralmente accordi sindacali, persino portando in piazza impiegati e quadri aziendali per protestare contro il sindacato, come avvenne nel 1980 con la celebre “marcia dei 40.000” organizzata dalla FIAT a Torino.
È questo attivismo delle classi dominanti, la lotta di classe vittoriosa evocata da Warren Buffett, che ha spostato l’asse politico dei governi sempre più a destra. La narrazione comune, secondo cui in Italia tutto ha iniziato ad andare a rotoli perché è arrivato Berlusconi, va capovolta: piuttosto Berlusconi ha vinto le elezioni perché tutto andava a rotoli e le elezioni, lungi dal modificare la rotta disegnata dai rapporti di forza tra le classi sociali, ne hanno semplicemente registrato il tracciato. Così come la “deriva moderata del PD” non è stata provocata dall’ascesa di Renzi, bensì Renzi è stato la figura che meglio incarnava una tendenza immanente.
Alla vigilia di elezioni che vedranno la “sinistra”, nelle sue più variegate e pittoresche forme, prendere l’ennesima sonora facciata e il giorno dopo recriminare contro l’elettorato che non le ha dato fiducia, magari rispolverando sciocchi luoghi comuni, come quello che l’Italia è un “paese di destra”, a me sembra che per i lavoratori italiani l’unica soluzione sia quella, pur difensiva, accidentata e gravida di incognite, indicata dai lavoratori britannici e americani e, dal punto di vista diametralmente opposto, da Warren Buffet. La lotta di classe.
Articolo tratto dalla newsletter di PuntoCritico.info del 20 settembre 2022. Immagine: Lahoucine Boukhanchouch, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons


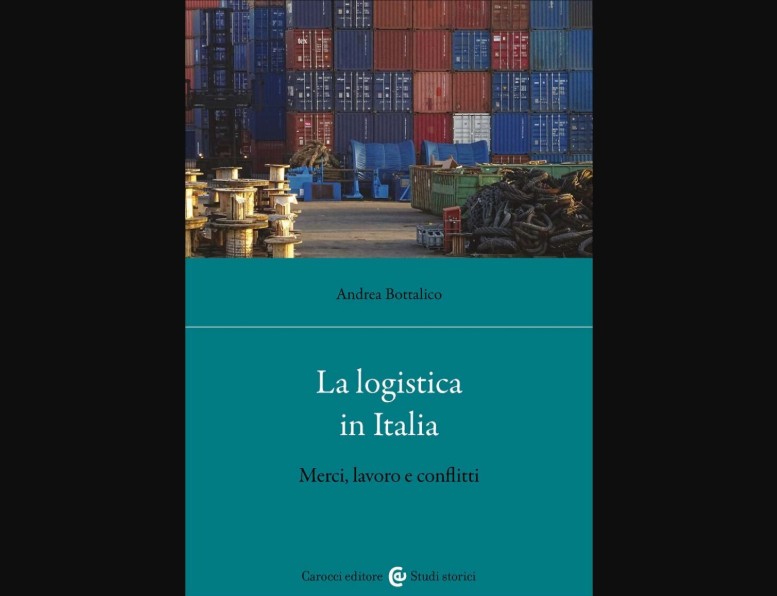


Devi fare login per commentare
Accedi