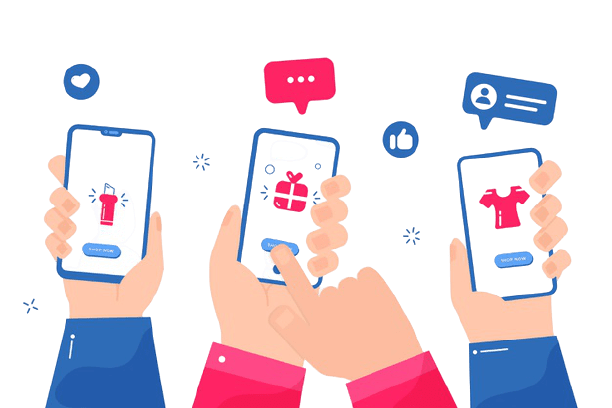
Internet
Sui social non esistono consigli disinteressati: la creator economy vive di pubblicità occulta
Non sono consigli da amici ma da strategie di vendita. L’influencer marketing alimenta un flusso costante di pubblicità mascherata e la regolamentazione europea non riesce ancora a colmare il divario tra trasparenza e business.
Che si tratti di Millennial che intenti a scorrere i reel di Instagram o Gen Z immersi nello scroll infinito di TikTok, il copione è lo stesso: prodotti da comprare ovunque. Dalle sponsorizzate dichiarate agli unboxing, dai consigli “da amici” agli inviti in ristoranti esclusivi o vacanze esotiche, l’influencer marketing è diventato parte integrante dell’esperienza online.
Un business milionario costruito sulla fiducia
Il vero nodo sta qui: non siamo abituati a considerare come pubblicità tutto ciò che in realtà lo è. Non solo i post etichettati come adv o partnership, ma anche l’infinità di recensioni, unboxing e consigli all’apparenza spassionati che popolano i feed social rientrano a pieno titolo nella sfera commerciale. Ed è proprio questa normalizzazione della pubblicità travestita di spontaneità a contribuire all’ascesa della “creator economy”: Forbes ha stimato che i soli Top Creators 2024 abbiano guadagnato 720 milioni di dollari in un anno. Un successo che si regge sul legame emotivo – definito “parasociale” – che fa percepire gli influencer come modelli vicini, autentici, con cui identificarsi e di cui fidarsi.
Pubblicità occulta e algoritmi complici
L’errore diffuso sta nel credere che un contenuto commerciale debba necessariamente avere dietro un pagamento monetario, quando in realtà il ventaglio delle pratiche è molto più ampio. Un capo firmato in regalo, il sorteggio di un premio tramite ‘giveaway’ o i guadagni tramite affiliate marketing (codici sconto che fruttano percentuali su ogni acquisto) sono esempi di scambi non monetari ma ugualmente commerciali, che andrebbero trattati come pubblicità a tutti gli effetti.
Ma le grandi piattaforme spesso non considerano queste pratiche nei loro strumenti per segnalare i contenuti sponsorizzati. Inoltre, ogni social ha regole diverse, rendendo macchinoso e poco intuitivo dichiarare una sponsorizzazione. Questo non è un dettaglio tecnico, ma una scelta di design che rientra nei cosiddetti “dark patterns” – meccanismi manipolativi pensati per condizionare le scelte degli utenti.
Non sorprende che, secondo un’indagine della Commissione Europea su 22 Paesi, solo il 20% degli influencer dichiari sistematicamente le proprie attività pubblicitarie. Una delle ragioni è che alle piattaforme conviene mescolare contenuti personali e commerciali, dando vita ad inserzioni ibride, già calibrate sul pubblico che segue un determinato creator.
Norme frammentate e paradossi europei
Il quadro legislativo europeo è complesso e frammentato, ma c’è. Il Digital Services Act (DSA) impone nuove regole di trasparenza alle Big Tech, che devono mantenere archivi pubblici delle inserzioni e spiegare agli utenti perché vedono determinati annunci. Tuttavia, mentre la pubblicità mirata è sotto stretta sorveglianza, l’influencer marketing “off-platform” – cioè quelle sponsorizzazioni negoziate direttamente tra brand e creator al di fuori della piattaforma – resta fuori dalla portata del DSA.
D’altro canto, il riferimento della legge alle “comunicazioni commerciali” apre a un’interpretazione più ampia, in linea con la Direttiva sull’E-commerce che include anche la promozione indiretta di beni e servizi. Inoltre, una sentenza della Corte di Giustizia europea ha stabilito che anche scambi non monetari costituiscono pubblicità occulta e rientrano tra le pratiche ingannevoli vietate dalla normativa europea a tutela dei consumatori.
Il risultato è una regolamentazione incoerente che lascia scoperto un intero settore in continua evoluzione, dove gli utenti-consumatori – talvolta giovanissimi – sono sempre più vulnerabili.
I rischi dell’“influenza” dalla moda alla politica
Il rischio di venire “influenzati” non si limita a cosa comprare, ma può anche riguardare cosa votare, come è emerso durante le elezioni presidenziali rumene di fine 2024, poi annullate, in cui una rete di micro-influencer era stata pagata per promuovere un candidato di estrema destra su TikTok, nonostante la piattaforma vieti esplicitamente gli annunci politici. Un caso che mostra come l’influencer marketing, se non regolamentato, possa avere conseguenze dirette sulla democrazia.
Il cuore del problema resta la fiducia. Un utente che, su consiglio del proprio idolo digitale, sceglie cosa acquistare o quale politico sostenere, ad oggi non ha modo di sapere se dietro c’è un contratto commerciale. Senza trasparenza, ogni interazione digitale diventa un terreno minato, dove il pubblico è esposto a manipolazioni invisibili.
Ma la responsabilità non può ricadere solo sui creator: sono le piattaforme che devono assumere un ruolo attivo nel rendere i contenuti sponsorizzati immediatamente riconoscibili. Ancora più a monte, spetta all’Unione Europea armonizzare le regole, senza affidarsi all’autodichiarazione di attori guidati dal profitto.
In un ecosistema digitale in cui i confini tra informazione, intrattenimento e pubblicità sono sempre più sfumati, la trasparenza non è un eccesso di scrupolo, ma un principio fondamentale. Senza, rischiamo di vivere in un continuo inganno, dove ciò che crediamo autentico è solo l’ennesima forma di marketing mascherato.

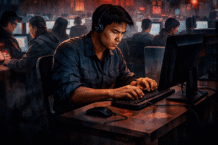



Devi fare login per commentare
Accedi