
Mondo
La guerra come ritorno del reale: perché il XXI secolo non sarà pacifico
I conflitti di oggi non sono più guerre-lampo, sono guerre di logoramento e guerre ibride in cui le operazioni militari si accompagnano a sanzioni economiche mirate, controllo delle filiere strategiche, guerre cibernetiche e disinformazione
Quando cadde il Muro di Berlino, nel 1989, una certa euforia pervase l’Occidente. Sembrava che la storia, quella fatta di grandi conflitti , fosse giunta alla sua conclusione. La tesi di Francis Fukuyama (politologo statunitense) secondo cui la democrazia liberale e il capitalismo avrebbero rappresentato la “forma finale di governo umano” fu interpretata come come un verdetto definitivo: le grandi alternative ideologiche son state sconfitte, la guerra diventa un retaggio del passato.
Ma la storia non finisce. Il XXI secolo, ancora giovane, ci ha mostrato il contrario: guerre convenzionali sono tornate nel “cuore” dell’Europa, conflitti etnici e religiosi devastano il Medio Oriente e l’Africa, la corsa agli armamenti è di nuovo globale, le potenze emergenti contestano l’egemonia americana. Il mito di una pace perpetua si è infranto contro la realtà dura della politica internazionale.
Come scriveva Carl Schmitt, “il concetto del politico è fondato sulla distinzione tra amico e nemico“. Questa distinzione non è un accidente storico, ma una costante antropologica e politica. L’illusione liberal-globalista di un mondo pacificato si è dissolta. Il conflitto è tornato a essere la condizione naturale e la guerra ne è la manifestazione estrema. Parlare di “ritorno del reale” significa riconoscere che le narrazioni consolatorie, secondo cui basterebbe commerciare per diventare amici o “diffondere la democrazia” per eliminare le guerre, erano fantasie. Oggi, più che mai, ci troviamo di fronte a un mondo hobbesiano, dove la forza resta la moneta ultima della politica.
Il periodo 1991-2008 è stato una eccezione storica. Gli Stati Uniti, vincitori della Guerra Fredda, godevano di un egemonia incontrastata. L’ordine mondiale era unipolare: nessuna potenza poteva sfidare Washington in maniera simmetrica. Gli interventi in Kosovo (1999), Afghanistan (2001) e Iraq (2003) furono condotti con relativa facilità militare, anche se con esiti politici controversi.
Oggi però, l’assetto è cambiato, viviamo in un multipolarismo incompiuto, in cui diverse potenze competono per ridefinire le regole del gioco:
- RUSSIA, dal 2008 in Georgia, passando dall’annessione della Crimea (2014), fino all’invasione su larga scala dell’Ucraina, ha dimostrato di esser pronta a usare la forza per difendere e ampliare la propria sfera di influenza. Mosca non riconosce la legittimità dell’ordine liberale nato nel 1991.
- CINA, ormai non solo “fabbrica del mondo” ma attore geopolitico assertivo. L’espansione nel Mar Cinese Meridionale, l’ossessione per Taiwan e la “Belt and Road Initiative” (è un’iniziativa strategica della Repubblica Popolare Cinese per il miglioramento dei suoi collegamenti commerciali con i paesi nell’Eurasia.) indicano una strategia globale di lungo periodo.
- MEDIO ORIENTE, un mosaico di guerre, rivoluzioni fallite e conflitti settari. Siria e Yemen sono guerre ibride in cui si intrecciano potenze regionali e globali.
- AFRICA, colpi di stato in Niger, Mali e Burkina Faso rivelano fragilità statale e il ritorno della competizione fra potenze esterne
- OCCIDENTE, colpito da crisi energetiche, instabilità politica interna, polarizzazione sociale e perdita di fiducia nelle istituzioni.
Questi conflitti non sono più guerre-lampo, sono guerre di logoramento e guerre ibride in cui le operazioni militari si accompagnano a sanzioni economiche mirate, controllo delle filiere strategiche, guerre cibernetiche e attacchi informatici, campagne di propaganda e disinformazione. Clausewitz scriveva: “La guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi”. Oggi potremmo dire che la guerra è la continuazione della politica con tutti i mezzi: militari, economici, tecnologici e informativi.
Hobbes, nel Leviatano (1651), descrive lo Stato di natura come una condizione di “bellum omnium contra omnes“, guerra di tutti contro tutti, dove la vita dell’uomo è solitaria, povera, sgradevole, brutale e breve. Per Hobbes, la guerra non coincide solo con lo scontro armato: è presente ogni volta che manca una sicurezza reciproca garantita da un autorità superiore, nel contesto odierno le relazioni tra Stati somigliano a quello Stato di natura: non esiste un’autorità globale capace di garantire la sicurezza di tutti, e così ogni potenza deve contare sulle proprie forze. Carl Schmitt, nella sua opera Il concetto politico (1932), critica l’idea liberale di un mondo depoliticizzato: “L’umanità non esiste come unità politica“. Esistono popoli e Stati che definiscono chi è amico e chi nemico e la globalizzazione non ha cancellato questa logica; l’ha semplicemente resa più interdipendente, aumentando il rischio di conflitti quando l’interesse vitale di un attore viene minacciato. Queste due prospettive smontano l’ottimismo ingenuo secondo cui il commercio o la diffusione di regimi democratici possano garantire la pace, mentre la storia dimostra che il conflitto è una costante e che la pace è il risultato temporaneo di un equilibrio di forze, spesso imposto dalla potenza dominante.
Negli anni ’90 e nei primi 2000, molti credevano che la forza militare fosse ormai secondaria, la guerra veniva ridotta a “operazioni chirurgiche” ad alta tecnologia, trasmesse in diretta televisiva come spettacolo. L’Occidente si illudeva di poter esportare la democrazia senza resistenze, convinto che la globalizzazione economica avrebbe reso le guerre troppo costose per essere combattute.
Ma, come ricorda Slavoj Zizek (filosofo, sociologo e politologo sloveno, esponente della filosofia marxista), “il reale ritorna sempre”: è ciò che resiste alla nostra rappresentazione, ciò che non possiamo ignorare, nella politica internazionale il reale è il conflitto violento.
L’invasione russa dell’Ucraina nel 2022 ha rappresentato un trauma per le opinioni pubbliche occidentali: improvvisamente l’Europa ha riscoperto che i carri armati possono attraversare i confini e che città moderne possono esser bombardate come nel 45′, lo stesso vale per la guerra a Gaza, dove la logica della forza prevale su quella dei negoziati, in Asia-Pacifico l’ombra di un conflitto per Taiwan incombe, mentre Giappone e Australia si riarmano. Anche l’Unione Europea, nata per “bandire la guerra” dal continente, è costretta a discutere di industria bellica e spese militari, il linguaggio del potere torna a imporsi sul linguaggio dei diritti.
Come ho scritto poc’anzi la pace è un eccezione e anche la storia delle relazioni internazionali lo conferma, prendiamo in esame la Pax Brittanica (1815-1914) mantenuta grazie alla supremazia navale ed economica britannica e a un equilibrio di potere europeo garantito dal Congresso di Vienna, oppure la Pax Americana (1945-1991) fondata sull’egemonia statunitense, sull’equilibrio nucleare e su istituzioni internazionali sotto influenza occidentale, in entrambi i casi la pace era garantita da una chiara asimmetria di potere e dalla capacità della potenza egemone di imporre regole; quando quella asimmetria si erode, il sistema torna instabile come sta accadendo oggigiorno con il declino relativo degli Stati Uniti e la crescita di potenze revisioniste.
Come scriveva Raymond Aron: “La pace internazionale non è che la sospensione provvisoria della guerra“. In altre parole, la pace è sempre un equilibrio precario pronto a rompersi quando il bilanciamento di potere si sposta.
Noi come Italia, militarmente, come siamo messi?
L’Italia entra nel XXI secolo con un paradosso strutturale: è una nazione dal peso culturale e strategico superiore alla sua capacità militare. La nostra posizione geografica è un ponte tra Mediterraneo e cuore d’Europa, un “centro naturale” per commercio, energia e traffici marittimi. Eppure, questa centralità geopolitica si accompagna a una dipendenza strutturale dalla protezione NATO, in particolare statunitense, che condiziona tanto la nostra politica estera quanto la nostra percezione di sicurezza.
Dal punto di vista militare, l’Italia spende circa l’1,46% del PIL in difesa (2024), pari a poco più di 32 miliardi di euro annui, ben al di sotto dell’obiettivo NATO del 2%. Le Forze Armate contano circa 160.000 effettivi (Esercito, Marina, Aeronautica), più 30.000 Carabinieri di cui una parte significativa impegnata in missioni internazionali (Libano, Iraq, Kosovo, Somalia) o in operazioni interne di ordine pubblico e sorveglianza.
La Marina Militare è tra le più moderne in Europa, con due portaerei leggere (Cavour e Trieste), sottomarini U-212A a propulsione convenzionale e fregate di nuova generazione FREMM. Tuttavia, la dimensione complessiva resta contenuta: circa 30.000 unità di personale e una capacità di proiezione limitata rispetto ai colossi navali globali. L’Aeronautica Militare, con circa 40.000 uomini, gestisce una flotta in transizione verso la quinta generazione: accanto agli Eurofighter Typhoon, sono in servizio i nuovi F-35A e F-35B, ma il numero complessivo di velivoli da combattimento resta sotto le 150 unità operative.
Sul piano industriale, l’Italia possiede eccellenze strategiche: Leonardo è tra i primi dieci gruppi mondiali della difesa, Fincantieri è un leader globale nella cantieristica militare, Avio Aero e MBDA Italia contribuiscono a sistemi aerospaziali e missilistici di altissima tecnologia. Queste realtà, pur trainanti, operano in un contesto in cui la domanda interna è compressa dalla spesa pubblica vincolata e dalla mancanza di una strategia di riarmo coerente.
Dal punto di vista economico generale, l’Italia è la terza economia dell’Eurozona, con un PIL di circa 2.200 miliardi di euro e un export che supera i 650 miliardi annui, trainato da meccanica, moda, agroalimentare e farmaceutica. Tuttavia, la nostra bilancia energetica resta fragile: importiamo più del 75% del fabbisogno energetico, rendendoci vulnerabili a crisi geopolitiche e oscillazioni di mercato.
La verità è che l’Italia, pur vantando potenziale industriale e capitale umano, ha rinunciato a pensarsi come potenza militare autonoma. Questo non è solo un fatto di bilancio: è una scelta politica e culturale che riflette la rimozione del concetto di sovranità armata dal dibattito pubblico.
Ci tengo a precisare che affermare che il XXI secolo non sarà pacifico non equivale ad auspicare la guerra, ma riconoscere che essa sia una possibilità sempre presente, l’errore del dopoguerra fredda è stato credere che la pace fosse norma e il conflitto l’eccezione. Il compito di chi vuole difendere la propria comunità non è sognare un’armonia universale ma prepararsi. Hobbes ci ricorda che la pace si mantiene solo quando esiste un’autorità capace di imporla, Schmitt ci avverte che senza capacità di riconoscere il nemico, ogni ordine politico è destinato a dissolversi, Clausewitz ci ricorda che la guerra non è mai un fatto isolato, ma uno strumento politico. Il “ritorno del reale” ci impone di guardare in faccia la verità: la forza e la volontà contano più delle dichiarazioni e il futuro prossimo sarà segnato dalla competizione per il potere. La differenza la farà chi saprà affrontare il conflitto senza illusioni. La guerra non è una parentesi anomala, ma la verità ultima delle relazioni tra potenze , ogni tregua è solo un armistizio tra due tempeste. Nel XXI secolo, la globalizzazione non ha cancellato il conflitto: lo ha reso più rapido, asimmetrico, imprevedibile. Rifiutare questa realtà significa condannarsi all’impreparazione. Chi accetta la durezza della realtà, invece, può ancora difendere la propria libertà. La pace è un premio, mai un diritto (purtroppo): va conquistata ogni giorno.


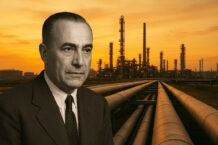
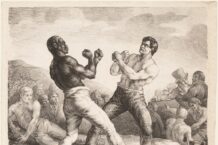

Devi fare login per commentare
Accedi