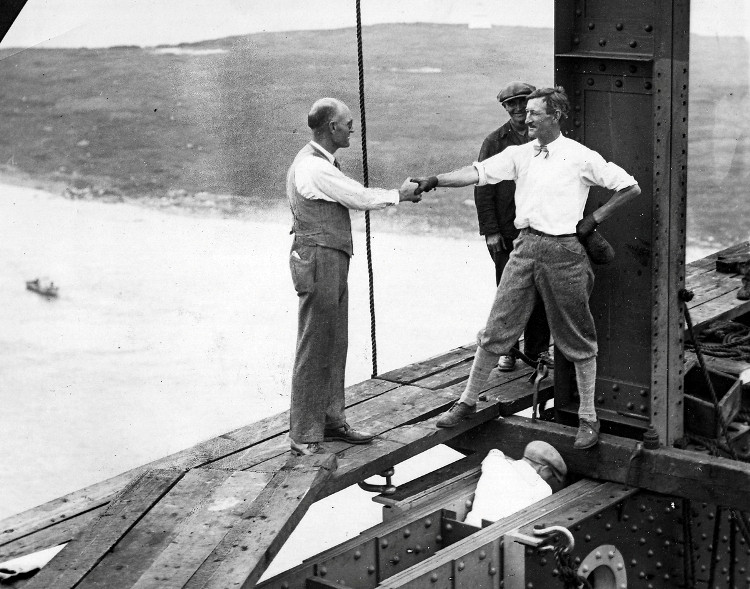
Milano
Edilizia e urbanistica: serve chiarificare, non semplificare
Semplificazione fa ormai rima con confusione, soprattutto in campo urbanistico. Serve il coraggio di essere chiari e netti nei confini. Solo così sia gli imprenditori, sia i decisori, sia i cittadini potranno vedere meno presunzione di opacità nella trasformazione delle città
In questi tre anni si è assistito a un terremoto giudiziario e giuridico – il cui epicentro è Milano – che ha investito l’urbanistica. Milanese in primis ma, come si può notare da segnali che arrivano da altre città italiane, non solo.
Non voglio qui entrare nei fatti di cronaca giudiziaria, poiché ritengo che i processi vadano fatti – in tempi ragionevoli – nelle sedi istituzionali dei Tribunali. Quello che mi sento di dire senza retorica è che un’inchiesta non è una sentenza. Per questo la presunzione di innocenza è, a mio avviso, una solida garanzia costituzionale da difendere sempre e ovunque.
Detto ciò non si può però fingere di non vedere le ragioni che hanno innescato queste articolate inchieste, connesse alla applicazione di (apparentemente) controverse norme urbanistico/edilizie. Le ragioni risiedono, a mio modesto avviso, in uno sviluppo delle trasformazioni urbane che ha generato forti dissensi territoriali – più o meno robusti, più o meno fondati, più o meno sensati – probabilmente uniti a una non adeguata pubblicità degli atti e connessi a un processo di crescita dei valori immobiliari che genera il cosiddetto fenomeno della “gentrificazione”: modifica impetuosa del tessuto urbano da un lato e impossibilità dei residenti di godere appieno o in parte da tale modifica dall’altro.
Il cortocircuito sociopolitico e istituzionale germina, forse, da qui.
La situazione dell’edilizia residenziale di Milano è giunta così a un livello di criticità – se non di drammaticità – paragonabile in termini di blocco delle attività a quanto accade nel post 1992 – (anche se, è bene essere netti e chiari, le vicende attuali non hanno nulla a che vedere con i fatti di quegli anni); per molte realtà imprenditoriali e di impresa cooperativa la garanzia della continuità aziendale non è più così scontata.
Come si può ripartire?
Dal mio punto di vista multifocale – sono urbanista di formazione, ho fatto per 11 anni l’amministratore locale occupandomi di urbanistica e di edilizia privata (oltre che di viabilità) avendo un grande mentore e consulente legale del calibro di Mario Viviani e oggi sono un cooperatore di abitazione, cioè imprenditore del settore immobiliare – ritengo che per uscire un po’ dalla cronaca e fare tesoro delle questioni critiche messe in luce dalle molteplici inchieste, si debba chiarificare il quadro.
Fare chiarezza semplificando, è cosa diversa dalla presunzione di semplificare. La semplificazione, paradossalmente si porta sempre appresso una stratificazione normativa incomprensibile e un continuo rinvio a interpretazioni di leggi, col risultato di avere caos e presunzione di opacità.
Una premessa necessaria: dire, come si legge dalle cronache, che le inchieste evidenziano discrepanze tra la legge 1150 del 1942 e la legislazione regionale (lombarda in tal caso) solo in riferimento alla presenza di un edificio alto più di 25 metri, è una semplificazione non aderente alla realtà che non aiuta a trovare una via d’uscita il più possibile condivisa.
Se si leggessero in filigrana le contestazioni che hanno visto la messa in campo di provvedimenti giudiziari, ci si renderebbe conto che le situazioni più problematiche vedono la compresenza di uno o più fattori di discrepanza normativa, che sinteticamente sono: l’utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati (la ormai famosa SCIA) al posto di permessi di costruire o piani attuativi; la qualificazione degli interventi come “ristrutturazione edilizia” al posto di “nuova costruzione”, con la conseguente riduzione di oneri di urbanizzazione e dotazione degli standard richiesti (con un eccessivo ricorso alla monetizzazione); un indice fondiario superiore ai 3 metri cubi su metro quadro; uno o più edifici con una altezza superiore ai 25 m (la più ingombrante e visibile conseguenza); esclusione degli organi elettivi collegiali dal processo decisionale.
Sulle responsabilità penali o civili, essendoci procedimenti in corso, vale quanto sopra detto.
Ma, da un punto di vista normativo, penso si possa arrivare a una chiarificazione importante, che potrebbe anche diventare una sorta di regola di indirizzo generale.
La proposta che faccio è molto semplice. Siccome serve chiarezza, penso si debba riportare la sfera degli strumenti attuativi a 3 ambiti di azione, stabilendo un confine netto tra ciò che ha natura a dominante edilizia (pur con modificazioni urbanistiche) e ciò che ha invece natura a dominante urbanistica.
Il primo confine, dunque, è quello di utilizzo dello strumento più semplice e “veloce”: la SCIA. Questo dovrebbe essere pacificamente utilizzato, anche per interventi di modifica di ambiti urbani quando:
-si effettua una ristrutturazione integrale dell’edifico senza modifica di sagoma e sedime;
– si effettua una demolizione e ricostruzione di un immobile con sua trasformazione, senza modifica di sagoma e sedime ma con un incremento volumetrico massimo del 10%;
– si effettua una demolizione e ricostruzione di un immobile con sua trasformazione, con modifica di sagoma e sedime senza nessun incremento volumetrico.
Stop. La SCIA per interventi di scala superiore non si potrà più utilizzare.
L’ambito successivo vede la chiara e univoca ridefinizione normativa e il consolidamento di uno strumento importante, a mio avviso valido sostituto del Piano Attuativo. Siccome ritengo una chimera immaginare che vi sia un Piano Attuativo per ogni intervento di trasformazione che non abbia una rilevanza di scala urbana e siccome penso che l’utilizzo della SCIA crei i problemi che abbiamo visto affermarsi, serve affinare una credibile via di mezzo.
Questa via di mezzo c’è già e si chiama Permesso di Costruire Convenzionato (PdCC). Innanzitutto andrebbe definita una soglia quantitativa della superficie fondiaria oggetto di trasformazione fino alla quale tale strumento entra strutturalmente in campo; io qui abbozzo 15.000 mq di superficie come dimensione di soglia massima, oltre la quale scatterebbe l’obbligo di Piano Attuativo.
Sotto tale soglia e sopra i limiti consentiti con la SCIA, con un indice inferiore ai 3 mc/mq, senza edifici sopra ai 25 m di altezza, qualificando l’intervento come “sostituzione edilizia” e dunque come “nuova costruzione”, avendo altresì l’obbligo di verifica della dotazione di standard, si tratterebbe di avere uno strumento, il PdCC appunto, che vedrebbe un ruolo importante della pubblica amministrazione nella definizione del planivolumetrico (conformemente allo strumento di pianificazione urbanistica), nella definizione delle dotazioni di standard da cedere in termini di aree o da monetizzare nel caso in cui la verifica delle dotazioni desse esito positivo, negli ulteriori aspetti convenzionali. Si dovrà sancire con chiarezza che il dirigente designato è pienamente legittimato e titolato a gestire il processo di definizione del progetto, con il coinvolgimento di tutti gli strumenti amministrativi del caso (Commissione Paesaggio, Conferenza dei Servizi, ecc). Quando si arriverà al progetto definitivo e alla convenzione urbanistica pronta per la sottoscrizione, dovrebbe entrare in gioco un passaggio obbligatorio: l’operatore provvederà a installare sull’immobile oggetto della trasformazione edilizia a dominante urbanistica, un cartello che illustri – con adeguata rappresentazione – il progetto, indicando il sito del Comune dove si troverà tutta la documentazione che ogni cittadino potrà consultare (l’Albo Pretorio). I soli cittadini controinteressati, ossia a mio avviso tutti quei cittadini che vivono in un cerchio territoriale con un raggio di 400 m dal punto della trasformazione (i 400 m corrispondono a una plausibile definizione di accessibilità pedonale che connota il “vicinato”), avranno 30 giorni di tempo per prendere visione della documentazione e 15 per presentare formali osservazioni al PdCC. Perché solo i cittadini controinteressati? Perché, essendo ormai vecchio e avendo gestito l’urbanistica della cosiddetta “prima repubblica”, ho buona memoria del mercimonio di osservanti e osservazioni e di osservazioni fatte apposta per mettere i bastoni tra le ruote a questo o quell’operatore concorrente.
Finiti i 45 giorni – se non dovessero esserci osservazioni – ecco che il Dirigente comunale potrà serenamente procedere alla firma della convenzione davanti a un notaio, con il successivo rilascio del titolo; se al contrario dovessero esserci osservazioni sarà invece compito della Giunta Comunale procedere alla loro controdeduzione e risposta, con successivo incarico al Dirigente per la firma della convenzione modificata.
Il PdCC sarebbe una sorta di Piano Attuativo semplice. Al di fuori di tutto ciò, resta lo strumento del Piano Attuativo, che richiede passaggi ancora più approfonditi e una pubblicità ancora più ampia.
In questo modo, avendo chiara la necessità di rafforzare, formare ed equamente remunerare i funzionari pubblici, si potrebbe ripartire con maggiore chiarezza per tutti.
Un processo chiarificato – come accade per il burro – sarebbe forse migliore di un processo semplificato. E si potrebbe riprendere un percorso di trasformazione della città equo e più teso alla concordia.

Devi fare login per commentare
Accedi