
Milano
Milano: la partecipazione oltre la sperimentazione
Gli istituti e gli strumenti di partecipazione – previsti, pensati, creati nel tempo – rappresentano un ingrediente imprescindibile, tutt’altro che generico e sperimentale.
La democrazia è rappresentanza
La democrazia rappresentativa che conosciamo, con tutti i suoi limiti, resta – come ricordava Winston Churchill – “la peggior forma di governo ad eccezion di tutte le altre”.
Una democrazia oggi piuttosto malandata che si concretizza più o meno blandamente (anche nelle città) in un indirizzo politico basato su un programma elettorale che si traduce in atti amministrativi, portati avanti da una coalizione e un governo locale che opera spesso con risorse e poteri limitati: personale ridotto, vincoli normativi, scarse risorse economiche, apparati burocratici spesso rigidi a cui si aggiunge un peso crescente della finanza internazionale sulle vicende urbane (ogni riferimento alla recente vicenda relativa all’area di San Siro non è casuale).
Anche nella nostra Milano la sfida del governo municipale in tempi in cui progressivamente votano meno della metà dei cittadini coinvolge, tra un’elezione ed un’altra, una serie di minoranze che sono un’importante componente della democrazia: persone stabilmente impegnate nel terzo settore, nell’attivismo politico o civico. Ad esse si aggiungono cittadini, cittadine e realtà impegnate anche solo episodicamente. Nel complesso queste persone, gruppi e organizzazioni costituiscono un bene prezioso, un capitale sociale importante, perché – come ricorda la ex Sindaca di Barcellona Ada Colau – “la definizione di città è la vita in comune dei cittadini”.
Si tratta di minoranze attive (con una certa costanza o in maniera intermittente) che di dedicano alla cura dei luoghi e delle persone di cui è fatta la città e i suoi quartieri periferici l’atmosfera di alcuni dei quali è ben descritta da questa frase di un pezzo di Marracash: “fame di fama, ovunque la fuori e sento aria di casa tra sti palazzoni e il massimo dell’ambizione che c’è quaggiù è passare dalla parte della gente che ruba” (Bravi a Cadere, I Polmoni – Persona).
La rappresentanza si alimenta con la partecipazione
Giorno per giorno la partecipazione in una comunità urbana implica livelli multipli di pensiero e di azione assai variegato: associazioni, cooperative, parrocchie, altri luoghi di culto, imprese sociali, comitati locali, organizzazioni politiche, gruppi informali, spazi di produzione sociale e culturale autogestiti, spazi ibridi, diverse comunità di pratica, comunità virtuali (Social District…).
Ci sono gli abitanti che percepiscono la loro appartenenza alla città ma sempre più anche i molti che si sentono di passaggio o nelle condizioni di non volere o non poter mettere radici a Milano e nei suoi quartieri. Una considerazione che potrebbe portarci verso altre interessanti riflessioni rispetto ai temi della partecipazione.
Se, alla luce dell’intelligenza e azione collettiva rappresentata dalle diverse forme di partecipazione, non si aprono e coltivano canali efficaci di dialogo, gestione e costruzione delle politiche con le istituzioni, il rischio è che le persone perseguano quelle che Albert Otto Hirschman definiva come opzioni di uscita e abbandono (exit) degli interessi pubblici, in alternativa al dare voce (voice) e al (ri)costruire nuove forme di lealtà e fiducia (loyalty) nel confronto pubblico.
La crescita impetuosa e progressiva dell’astensionismo elettorale e ad altre manifestazioni di disaffezione (exit) nei confronti della politica non sono affatto casuali e non possono essere interpretate come un fisiologico ed inarrestabile segno dei tempi bui o del destino cinico e baro.
Altro fenomeno in atto da tempo immemore è quello costituito dalla caduta dei cosiddetti corpi intermedi (partiti, sindacati, associazioni e gruppi di rappresentanza…)
La partecipazione è gestione del conflitto endemico
“Non sempre si è capito che le società di mercato pluralistiche sono particolarmente abili nel trarre forza dalla specie di conflitti che tipicamente generano. Accanto alla nuova ricchezza, esse producono costantemente nuove forme di disuguaglianza a livello personale, settoriale, regionale. Ne segue che emergono continuamente nuove richieste di riforme e di giustizia, con cui è giocoforza fare i conti, e che, una volta constatata la possibilità di una soluzione di compromesso, lasciano dietro di sé un residuo positivo: l’esperienza di vivere in una società che sa come far fronte ai suoi conflitti” (Albert Otto Hirschman, 1997).
Le nostre sono società nella quali, soprattutto nei contesti urbani, alla generazione di ricchezza si associano con regolarità diseguaglianze crescenti, a processi di inclusione dinamiche di esclusione.
Anche alla luce di tutto questo sarebbe invece opportuno impegnarsi con tenacia per “dare voce” (voice) nutrendo la trama della collaborazione comunitaria in cui istituzioni, organizzazioni, leadership locali, gruppi informali, nuove community, rappresentanze di interessi e ideali, referenti politici e sociali possano attivare e coinvolgere persone e gruppi in maniera efficace, stimolante e non strumentale (solo e soprattutto per le campagne elettorali o delle emergenze tematiche o territoriali) per ricostruire con continuità e tenacia fiducia (loyalty).
Per riannodare i fili nel cambiamento e promuovere capitale sociale occorrono tanto adeguate politiche pubbliche (top-down) quanto azioni dal basso (bottom-up) in un reciproco e costante dialogo (canali di comunicazione, punti di contatto) e movimento (scambio reciproco di informazioni, risorse, pareri, competenze, cessione di poteri) tra i due livelli.
La partecipazione da sale a lievito
In questo senso gli istituti e gli strumenti di partecipazione – previsti, pensati, creati nel tempo – rappresentano un ingrediente imprescindibile, tutt’altro che generico e sperimentale come se si trattasse di un “sale” blando e quasi insapore. Dovrebbero essere invece un ingrediente indispensabile; un “lievito” per dare anima e corpo all’informare, consultare, coinvolgere e, soprattutto, diffondere e redistribuire quote di potere decisionale.
Si tratterebbe infatti di aiutare e abilitare (situazione per situazione) a costruire e consolidare progetti su misura di ogni specifica condizione sociale e territoriale.
Poi c’è il ruolo dell’amministrazione e della politica a doversi e potersi alimentare e interagire nell’ambito di questo scambio e dei relativi canali di partecipazione.
Diverse forme e livelli di partecipazione
Potere e partecipazione hanno a che fare con una scala di possibilità di incidere davvero su scelte e cambiamenti.
In questo senso torna utile richiamare la “scala di partecipazione” – elaborata da Sherry R. Arnstein e rivista da David Wilcox –per analizzare la reale portata ed i limiti delle esperienze partecipative.
I processi partecipativi vanno letti sempre nella loro specificità per evitare mitizzazioni, prese in giro, ambiguità ed ingenuità.
Nei fatti ci si imbatte soprattutto nell’attivazione di dinamiche e pratiche di coinvolgimento, piuttosto che di partecipazione. Si va infatti dalla semplice informazione (“dire alle persone quel che è previsto”) alla comunicazione (“dire ai cittadini quel che è previsto per poi interagire, spiegare, precisare”) e alla consultazione (“offrire e raccogliere un certo numero di opzioni e ascoltare i feedback”). Si passa poi, a livello più alto, alla mediazione di conflitti (“gestire e risolvere problemi insieme”) fino alla concessione di potere delegato (“realizzare pratiche di democrazia deliberativa promettendo di mettere in atto le scelte emerse”).
La partecipazione a Milano
Penso alla mia città, passando in rassegna ciò che si è mosso in questi decenni e anni, ad alcuni esempi concreti, (tutti con la maiuscola): Consigli di Zona-Municipi, Accesso agli atti, Trasparenza amministrativa, Osservazioni, Regolamento della partecipazione, Referendum consultivi, Delibere di iniziativa popolare, Regolamento dell’amministrazione condivisa, Patti di Collaborazione, Milano Attiva, Bilancio Partecipativo, Forum tematici, Co-programmazione, Co-progettazione, fino alla Civil Week…
Tutti questi strumenti e spazi compongono un lessico municipale ormai familiare (per noi “partecipativi”), al quale ci siamo forse un po’ assuefatti alle prese con qualche successo, risultato tardivo, una manciata di illusioni, disillusioni e qualche sonoro fallimento. Un armamentario di pratiche interessanti ma rituali, “che funzionano, sì, ma fino a un certo punto”, che occupano spazi e tempi limitati, e che raramente sono oggetto di una revisione critica, di un apprendimento sistematico, di una valutazione degli effetti e delle mancate ricadute.
Queste pratiche oggi come possono essere lette, spiegate, criticate, migliorate e precisate indossando gli occhiali della scala di partecipazione? Il problema è che mancano quasi sempre il tempo, le energie e forse anche la volontà politica per fermarsi a fare un bilancio serio e strutturato per capire cosa funziona e cosa no, se i processi partecipativi hanno davvero inciso sulle decisioni pubbliche. Spesso sembrano restare un’eccezione alla regola, una concessione episodica più che un elemento strutturale che produce risultati effettivi.
Molti di noi – tra coloro che questi strumenti li hanno vissuti, progettati, utilizzati, persino ripensati – vedono questi canali e opportunità di partecipazione ridimensionati, ridotti a “foglie di fico”, “spruzzatine di sociale”, elementi di green e social washing o di cosiddetta innovazione amministrativa mai messa a sistema.
Questi strumenti preziosi e limitati non possono essere piegati a semplici meccanismi di gestione del consenso o a dispositivi per anestetizzare il dissenso e neutralizzare il conflitto. Farlo significherebbe svilirne completamente il senso e il potenziale trasformativo.
Che fare?
Riepilogando schematicamente in una città come Milano, che ha intrapreso da tempo la strada della partecipazione, essa appare come troppo episodica ma diffusa, decisamente marginale, dotata di scarse risorse (economiche e di personale), mancante di strumenti di coordinamento con ruolo e potere efficaci nell’incidere sulle politiche, non integrata quanto servirebbe con i diversi Settori e Assessorati
Nel contempo va anche sottolineato per onestà intellettuale che il cosiddetto Terzo Settore non di rado manifesta la tendenza a spendersi in termini di delega (“dateci i soldi che ci pensiamo noi”) più che su una reale volontà di co-costruzione delle politiche. D’altro canto la cittadinanza non sempre è orientata a portare contributi costruttivi e propositivi secondo una logica di protesta e allontanamento dei problemi altrove.
E’ forse arrivato il momento di avviare una riflessione pragmatica e vitale su queste politiche e pratiche:su chi vi partecipa, su ciò che promettono (e su ciò che realmente mantengono anche solo in parte, sui campi d’intervento che toccano, sul loro rapporto con le scelte politiche e sul ruolo dell’amministrazione nell’implementarle.
Come esplicitava Paolo Fareri anni fa: “La partecipazione (non solo in quanto partecipazione dei cittadini, ma più in generale come strategia di coinvolgimento degli attori rilevanti – e di mobilitazione di nuovi attori – nei processi decisionali) è un processo di progettazione collettiva (che si caratterizza come evento locale) il cui obiettivo primario è la produzione e messa in gioco di conoscenza utilizzabile (di diverso tipo: scientifica, ordinaria, interattiva) o in altri termini lo sviluppo di processi di apprendimento da parte degli attori coinvolti, in funzione di un aumento dell’efficacia e conseguentemente dell’efficienza del processo decisionale”.
Come si vede ci troviamo dinnanzi ad un potenziale ancora molto da coltivare in considerazione di quanto di buono fatto in questi anni ma di un’esigenza, ormai ineludibile, di rivederlo criticamente con una dose adulta di consapevolezza e speranza nell’affrontare le numerose sfide urbane che sono davanti a noi.
Ci attende provare a mettere in atto, un pezzo e un passo alla volta, un’opera titanica di trasformazione politica e sociale a partire dalle realtà del governo locale. La partecipazione può esserne lievito capace di alimentare confronto democratico (conflitto e collaborazione) e capitale sociale.
PS foto di Andrea Cerchi Milano vista dalla provincia di Bergamo.

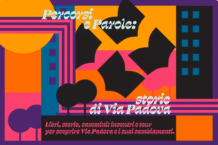

Devi fare login per commentare
Accedi