
Letteratura
Conoscere il dolore per salvarsi
Trascrizione di una lection magistralis sul dolore, tenuta da Umberto Eco nel 2014
Con l’abituale e riconosciuta vastità di riferimenti culturali, unita a verve e ironia, Umberto Eco (Alessandria 1932-Milano 2016) in una lectio magistralis tenuta all’Accademia delle Scienze di Medicina Palliativa nel 2014, aveva esposto alcune riflessioni personali sul tema del dolore, oggi riproposte in un libricino pubblicato da La nave di Teseo.
La sofferenza (fisica, psicologica, morale), strettamente collegata alla presenza del male nel mondo, è un’esperienza individuale e collettiva universale, perenne e inestinguibile: Eco qui la esplora attraverso un affascinante itinerario – tra filosofia, poesia, arte, letteratura e spiritualità – non solo nel suo indubbio carattere di negatività, ma anche come possibilità di salvezza e redenzione. A partire dalla mitologia greca – e precisamente da Eris, dea dell’oscurità, fomentatrice di odio e discordie, madre di varie divinità ostili, tra cui Algea (generatrice di dolori) -, tutte le filosofie e le religioni del mondo si sono interrogate sulla natura del dolore, sulle sue cause e finalità, sui rimedi atti a combatterlo. Pene dell’anima e pene del corpo si influenzano a vicenda, tormenti d’amore e afflizioni per un lutto hanno indubbiamente riflessi avversi sulla salute, così come le indisposizioni fisiche (dal mal di denti alle malattie più gravi) rendono malinconico l’umore, provocano depressione, fino a minacciare la salute mentale. Già dall’antichità sembrava più facile curare il malessere fisico (i medici ippocratici in Grecia lo facevano utilizzando metodi naturali e farmaci vegetali); problematico risulta tuttora trattare il dolore morale, che si presenta di volta in volta come nostalgia, melanconia, rimpianto, rimorso, angoscia. Su questo tipo di sofferenza si sono intrattenuti i primi filosofi occidentali, dapprima Democrito e poi gli stoici e gli epicurei, che raccomandavano di perseguire l’euthymìa, l’atarassia e l’apatia, cioè la moderazione e l’equilibrio, per arrivare all’imperturbabilità. Anche Aristotele, nell’Etica Nicomachea, scriveva che “Il saggio cerca di raggiungere l’assenza di dolore, non il piacere”.
Con il Cristianesimo il valore dato alla sofferenza, soprattutto corporale, assume un significato positivo e una funzione salvifica, come strumento di redenzione nella sua accettazione rassegnata e addirittura gioiosa. Il modello cui deve ispirarsi il vero cristiano è l’imitazione di Cristo (del Christus patiens, Christus dolens: flagellato, crocefisso, agonizzante), da perseguire fino al sacrificio estremo dei martiri e degli eremiti, celebrati da Agostino e Tertulliano. Nel Medioevo, sia la predicazione verbale sia le immagini nei luoghi sacri tendevano a ricordare l’imminenza e l’inevitabilità della morte e a coltivare il terrore delle pene infernali, tema particolarmente sentito in quei secoli in cui la vita era più breve di oggi, e minacciata da pestilenze, carestie, guerre e saccheggi, da cui ci si proteggeva con varie forme di penitenza (cilici, flagelli, digiuni), considerando il soffrire come occasione e promessa di salvezza. Con lo sviluppo della medicina rinascimentale, l’afflizione fisica appare non un bene da perseguire ma un male da eliminare, utilizzando tutte le conoscenze scientifiche a disposizione per diminuirla: al contrario, i filosofi e gli scrittori europei dal romanticismo in poi recuperano laicamente il significato del dolore come strumento di conoscenza di sé e del mondo. Fichte, Hölderlin, Hegel, Schelling, Nerval, Schiller, Leopardi, Schopenhauer, Dostoevskij, Nietzsche, Proust ritrovano nel sentimento del tragico un mezzo di scavo interiore per interrogarsi sullo scopo del vivere, sulla condizione della miseria umana, sul limite imposto dalla morte.
Forse solo nel ‘900 si è tornati giustamente a considerare il dolore, fisico e psicologico, come qualcosa da superare e abbattere, e non più una condanna ineliminabile. In questo la scienza ha favorito un cambiamento positivo nell’atteggiamento con cui ci si pone di fronte alla sofferenza, utilizzando la ricerca scientifica per alleviare le tribolazioni causate dalle malattie e per ridurre le pene dello spirito, come l’ansia o il panico. Concludendo la sua disamina del patire umano, Umberto Eco afferma che andrebbe incoraggiata un’educazione culturale al dolore, perché le persone imparino ad affrontarlo e ad accettarne la funzione biologica, in primo luogo approfondendone cause e rimedi.
UMBERTO ECO, RIFLESSIONI SUL DOLORE – LA NAVE DI TESEO, MILANO 2025.
Introduzione di Guido Biasco. Pagine 60


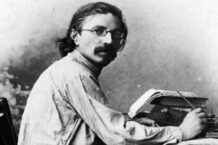

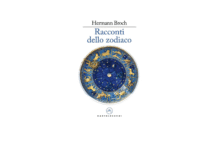
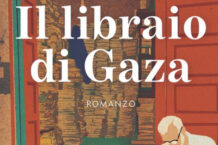
Devi fare login per commentare
Accedi