
Musica
Camminiamo dentro una foresta di simboli
Concerto del pianista Filippo Tenisci nella Cappella Paolina del Quirinale. Musiche di Debussy e di Bartók
I Concerti alla Cappella Paolina, nel Palazzo del Quirinale, si possono ascoltare, ogni domenica, sintonizzandosi sulle stazioni di radio3 alle 11.50. Ma ascoltarli dal vivo, dentro la bellissima cappella, è un’esperienza indimenticabile.
Domenica 12 ottobre – giorno della scoperta dell’America – suonava il pianista Filippo Tenisci, nato a Tirana nel 1998, allievo di Maurizio Baglini, e vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali, noto al pubblico per magistrali concerti e incisioni di musiche wagneriane trascritte da Liszt per il pianoforte. Ma questa volta si misurava con un repertorio novecentesco, due geni della musica del secolo breve: Claude Debussy e Bela Bartók.
Debussy muore nel 1918. Era nato nel 1862. Bartók nasce quasi 20 anni dopo e muore nel 1945. Tenisci ha però voluto mettere a confronto pagine composte nel giro degli stessi anni, e chiudere il concerto con una pagina bartokiana che segue di cinque anni la morte di Debussy.
Apriva l’ascolto una pagina famosissima di Debussy, dal primo libro dei Préludes, La Cathédrale engloutie, la cattedrale sommersa, del 1909-10. Una leggenda bretone immagina una cattedrale sommersa dalle acque che fa ascoltare di tanto in tanto i rintocchi delle sue campane. Debussy evoca, tra liquidi, impalpabili accordi – ottave e quinte parallele si sprecano! – proprio il suono di queste campane.
Come ha osservato Stefano Catucci, che come quasi sempre presenta il concerto paolino, prodotto da Radio3 -Rai Quirinale, ciò che conta non è l’imitazione del suono delle campane: la musica di Debussy è simbolica, come la poesia di Baudelaire, di Mallarmé, di Verlaine, non imitativa, le “impressioni” dell’impressionismo sono, come già si difendeva Beethoven, a proposito della Sinfonia Pastorale, stati d’animo, non ritratti naturalistici. Camminiamo dentro una foresta di simboli, dice Baudelaire. E la foresta possono essere le foglie di un albero attraverso cui ci arrivano i rintocchi di una campana, l’acqua di un lago dove è stata sommersa una cattedrale.
Tenisci prende Debussy alla lettera: gli accordi scivolano inafferrabili, come sensazioni fuggevoli, sfuggenti, indefinibili, il tocco leggero e volante. ma l’architettura che disegnano nell’aria definita, chiara, precisa. Profondi, duri, invece gli scocchi delle campane.
Si indietreggia di due anni, ed ecco la seconda serie delle Images: Cloches à travers le feuilles (campane attraverso le foglie), Et la lune descend sur le temple qui fut, e la luna scende sul tempio che fu, Poissons d’or, pesci d’oro. Di nuovo le campane, ma questa volta fanno barriera le foglie, non l’acqua, e il suono si fa più netto, più secco.
Il titolo del secondo brano di proposito non significa niente: oltretutto chi suona, in partitura il titolo non lo vede all’inizio della pagina, ma in fondo all’ultima e chiuso tra parentesi e puntini sospensivi – ( … Et la lune descend sur le temple qui fut … ), come un enigma, un suggerimento, più che una descrizione.
Tenisci evita la trappola di eseguire una musica evanescente; sfuggevole, ma non incorporea, non priva di forma. Debussy allude, non nasconde, non si sottrae all’impressione. Gli accordi possono perfino apparire talora brutali. L’inafferabilità armonica non è un fuggire qualunque determinazione, ma un costruire una sorta di griglia sonora dentro la quale inserire i lacerti di una memoria che sfugge.
E Debussy è un formidabile costruttore di edifici sonori. Basterebbero il Pelléas et Mélisande e La mer a testimoniarlo. Come per Wagner il rifiuto di una forma chiusa precisabile non è rifiuto della forma, ma ricerca di nuove forme.
Bartók lo intuisce subito. E non a caso, da subito, Debussy diventa, quasi un ante litteram bouleziano, un punto di riferimento, insieme a Brahms e a Beethoven. Ma la memoria, invece di pescare nella tradizione colta, pesca in quella popolare.
La tradizione colta – Beethoven resta un punto stabile di riferimento, per tutta la vita – gli offre non i contenuti, bensì la forma. O meglio, il modo di costruire una forma. Imprescindibile modello gli ultimi quartetti beethoveniani. Ma qui, sul pianoforte, il riferimento immediato è Debussy.
Tenisci propone due pagine coeve delle Images debussiane: le tre Burlesques, e il quinto dei 10 pezzi facili (che facili non sono per niente). Dove sta la differenza da Debussy, però? Il senso evocativo sembra lo stesso. Ma da subito si avverte che il ritmo procede per vie inusitate, che l’orecchio “colto” europeo non riesce a captare, nemmeno quello raffinatissimo e disponibile a qualunque nuova esperienza ritmica, oltre che armonica, di Debussy.
Perché sono i ritmi dell’improvvisazione popolare, di cui il romanticismo aveva avuto solo una vaga percezione, con Brahms, con Liszt, vaga perfino in compositori delle cosiddette “scuole nazionali”, Smetana, Dvořák, Grieg, dei quali comunque Bartók fa tesoro.
Ma qui c’è qualcosa d’altro: c’è l’uso imprevedibile, quasi un gioco di bussolotti, o delle tre carte, di piccoli moduli armonici e ritmici che si combinano in vari modi. Ed è qui che interviene la tradizione colta, in particolare quella rappresentata da Beethoven: nel modo di combinare contrappuntisticamente questi piccoli moduli.
Ecco quindi la sorprendente Suite di sei danze per orchestra del 1923, trascritte per pianoforte dallo stesso Bartók. Tenisci a questo punto sfodera tutta la sua intelligenza di lettura musicale attraverso una miracolosa varietà di tocco, a mettere in evidenza non solo la perpetua mobilità e imprevedibilità dei ritmi, ma anche la complicata e intricata costruzione polifonica delle voci.
Inevitabile l’applauso trionfale del folto pubblico presente nella Cappella. E, a sorpresa, il bis di un brano assolutamente contemporaneo, alle soglie del terzo millennio, nel 1999, una personalissima rievocazione – eh sì. siamo ancora e sempre lì – di una danza popolarissima, del tango, anzi di un tango famosissimo, la Cumparsita, che è sì un tango rioplatense, e dunque porteño, ma non di Buenos Aires, bensì di Montevideo, in Uruguay, sulla riva opposta del Rio de la Plata.
Il tango fu composto nel 1917 dal compositore uruguayano Gerardo Mate Rodríguez. Fausto Sebastiani ne ha tratto uno schizzo ironico e insieme sentimentale, una cartolina di viaggio, attraverso la cui frammentatissima scrittura s’indovina il ritmo e la melodia dell’indimenticabile tango, che in Uruguay una legge ha dichiarato pochi anni fa “inno nazionale”.
Gli applausi entusiastici che alla fine hanno accolto l’esecuzione del bis hanno premiato non solo la bravura – anche qui inconfondibile – del pianista, ma anche la finezza e il divertimento sapientissimo del compositore Fausto Sebastiani.




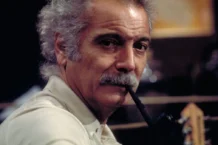
Devi fare login per commentare
Accedi