
Teatro
Welcome to Italy: la nuova stagione del teatro Fontana raccontata da Ivonne Capece
13 Settembre 2025
Welcome to Italy. La stagione del teatro Fontana di Milano, che da pochi giorni ha visto il suo avvio, racconta il nostro Paese e lo fa con sguardo curioso, plurale, con commistioni di stili e linguaggi, di visioni. Osservatori e oggetto di osservazione si mescolano, attraverso nuove produzioni e ospitalità. 7 produzioni, 36 ospitalità di cui 1 internazionale con robot e ologrammi in scena, 5 progetti performativi con interazione del pubblico, 27 spettacoli di nuova drammaturgia, 13 spettacoli dedicati a bambini e scuole, 12 compagnie/artisti under35, 2 festival di danza, 1 festival dedicato alle nuove generazioni: i titoli sono tanti, tante le esperienze che abiteranno il palcoscenico, ma alcuni fili rossi legano fra loro queste performance, che provano a interpretare il paese forse più raccontato al mondo. Un’Italia che si guarda e si riguarda — spesso in posa, a volte allo specchio, quasi sempre spiata. Welcome to Italy è un benvenuto ironico, tagliente, provocatorio, fatto in inglese, perché oggi l’Italia è un oggetto esotico, un set a cielo aperto, una destinazione da consumo culturale. Allo stesso tempo è anche un Paese che osserviamo da dietro la finestra (o lo schermo), come voyeurs, in attesa di commentare eventi ai quali non prendiamo parte.
Niente estetica da cartolina, niente filtri, niente nostalgia, ma la volontà di creare degli squarci attraverso i quali guardare dentro alla realtà, esaminarla al di là di immagini edulcorate, cercando di raggiungere l’identità vera di questo Paese. La stagione vuole riflettere complessità e contraddizioni, sfaccettature e sfumature, lontano dallo scatto “instagrammabile” e avvicinandosi invece allo scatto essenziale che la scena può ancora mettere a fuoco.
La stagione è un manifesto: memoria storica, nuove scritture, bellezza e conflitto, territori e tensioni. L’Italia che riduce tutto a un hashtag, che incanta o inquieta, che chiede di essere guardata non da turisti distratti, ma da testimoni attivi. Il teatro come lente, come set, come specchio. Non c’è invito, non c’è morale. Solo l’inquietudine di un Paese che si guarda — o si spia — continuamente, senza mai guardarsi davvero.
Ne abbiamo parlato con Ivonne Capece, Direttrice Artistica del Teatro Fontana, sede di Elsinor Centro di Produzione Teatrale.

Una stagione che parla di Italia e parla all’Italia, un paese molto narrato, spesso attraverso l’ambivalente retorica del luogo di sogno – ricco di memoria, tradizione e bellezze – e della terra da cui fuggire, per cercare un futuro professionale ed esistenziale non conservato “sotto naftalina”. Come mai ha voluto partire da questo racconto del nostro paese per costruire la proposta della nuova stagione?
Parlare d’Italia oggi significa misurarsi con una narrazione ossessiva e ambivalente. Da un lato il mito edulcorato della “grande bellezza”, confezionato come prodotto da consumo turistico; dall’altro la percezione di un paese che trattiene, che immobilizza, che costringe i suoi talenti a cercare altrove un futuro non mummificato. Con Welcome to Italy ho scelto di partire da questa frattura. Non mi interessa l’Italia da cartolina, ma l’Italia reale: stratificata, ferita, contraddittoria. Ho immaginato la stagione come un taglio di Fontana sulla tela, capace di oltrepassare la superficie per mostrarne le viscere. Il teatro, in questo senso, diventa uno strumento critico: non un luogo di rassicurazione, ma uno spazio in cui destabilizzare lo sguardo, incrinare la retorica e restituire complessità a ciò che rischia di essere banalizzato.
Un paese, tante chiavi di lettura. Nel calendario risaltano titoli di forte impegno civile, scorci antichi della tradizione orale regionale, racconti inchiesta dal passato prossimo, intime riflessioni su relazioni, sentimenti, identità individuali e collettive. Sicuramente la proposta si rivolge a un pubblico curioso, capace di spaziare. Quali sono gli elementi più identitari del teatro e quali quelli più innovativi, di sfida per il pubblico del Fontana?
La sfida è tenere insieme radici e fratture. Gli elementi identitari del Teatro Fontana sono legati a una vocazione precisa: abitare la tradizione non come reliquia, ma come materiale vivo da interrogare. Da qui l’attenzione alle narrazioni popolari, alla memoria collettiva, ai classici che tornano a vibrare dentro le contraddizioni del presente. Sul versante opposto, ciò che spinge verso l’innovazione è la volontà di incrinare continuamente le abitudini percettive del pubblico. Penso ai dispositivi tecnologici – robot, ologrammi, esperienze multisensoriali – ma anche alla capacità di trasformare il teatro in un laboratorio politico, in cui cronaca e inchiesta entrano in scena senza filtri, costringendo lo spettatore a una postura scomoda. Il pubblico del Fontana è già abituato a spingersi oltre la superficie: a lui chiediamo di non accontentarsi di riconoscere, ma di lasciarsi destabilizzare, contaminare, persino contraddire. L’identità del teatro non sta nel ripetere ciò che è già noto, ma nel generare continuamente nuove domande.
Le ospitalità in particolare sembrano percorrere il sentiero delle domande del presente – sull’Europa e la sua identità ad esempio – ma a partire dalla nostra storia italia, dai suoi personaggi iconici e da storie che rappresentano, in modo emblematico, periodi storici, contesti politici. Come avete costruito questa ricerca e queste relazioni con le compagnie ospiti?
Il lavoro sulle ospitalità è stato innanzitutto un esercizio di geografia critica. Abbiamo voluto guardare all’Europa non come a un’entità astratta, ma come a un corpo in tensione, segnato da memorie, conflitti e identità plurali. L’Italia, in questo orizzonte, diventa una lente privilegiata: i suoi personaggi iconici, le sue tragedie civili, le sue contraddizioni politiche sono il modo con cui raccontiamo, in piccolo, dinamiche che riguardano l’intero continente. La costruzione della rete con le compagnie ospiti è passata attraverso un principio di risonanza: cercare artisti che, con linguaggi diversi – dal teatro d’inchiesta al dispositivo tecnologico, dalla performance sensoriale alla drammaturgia radicale – condividessero la stessa urgenza di interrogare il presente. Non è un calendario di ospiti, ma una costellazione di complicità intellettuali e politiche. Così la stagione non si limita a importare spettacoli, ma si configura come un dialogo militante: un confronto serrato tra storie italiane e prospettive europee, nella convinzione che il teatro non sia solo estetica, ma un atto di cittadinanza.
Anche la tecnologia acquista un importante ruolo in scena, mescolandosi con musica e danza. Ci vuole parlare un momento della commistione di linguaggi che caratterizza la stagione?
La tecnologia in scena non è mai decorazione, né puro intrattenimento visivo. È uno strumento che, se usato criticamente, ci obbliga a riconsiderare la natura stessa del teatro: cosa significa essere corpo vivo davanti a un pubblico quando accanto ci sono ologrammi, intelligenze artificiali, robot? Che tipo di “presenza” abitiamo, e quanto siamo disposti a lasciarci contaminare dal non umano? In questa stagione ho cercato di intrecciare la tecnologia con altri linguaggi – musica, danza, performance sensoriale – per mettere in crisi le gerarchie dei codici. È una commistione che apre domande politiche oltre che estetiche: fino a che punto siamo ancora spettatori, e quando diventiamo parte di un dispositivo più grande di noi? La commistione dei linguaggi, per me, è un atto politico oltre che estetico. Il teatro che immagino non si accontenta di essere “puro”, perché la purezza è sempre una forma di conservazione. Al contrario, accoglie contaminazioni e frizioni, convinto che solo nell’ibridazione si possa restituire la complessità del presente. La tecnologia, la musica, la danza, i linguaggi popolari e quelli più sperimentali convivono per incrinare le certezze dello spettatore, spostarne lo sguardo, costringerlo a stare in bilico. In questa stagione, le esperienze ibride sono numerose e diversissime. In La città dei vivi, che firmo in regia, attori reali e personaggi semiolografici condividono lo spazio, generando una vertigine tra realtà e simulacro. In iGirl di Federica Rosellini, corpo e parola si intrecciano con installazioni video ed elettronica; Replika mette in scena un attore e i suoi doppi: un robot e un ologramma di se stesso; Dieci modi per morire felici si struttura come un dispositivo interattivo che chiede al pubblico di farsi parte attiva dell’opera. Lo stesso avviene nei Chiostri Suite, col teatro espanso di Sottosuolo o l’esperimento olfattivo di Odorama, che trasformano un Chiostro rinascimentale in un laboratorio percettivo. E ancora, i musical contemporanei La diva del Bataclan e La Substance raccontano con ironia e crudeltà il culto del corpo e dei social; le drammaturgie dei giovanissimi Eliana Rodella e Mattia Favaro portano in scena nuove urgenze generazionali; Domenico Ingenito incrocia Koltès con il napoletano, i giovanissimi artisti de La Bottega amletica testoriana, esperimento di Antonio Latella, lavorano su classici di Testori con una libertà radicale, che è insieme omaggio e tradimento creativo. Queste traiettorie non sono episodi isolati, ma tasselli di una visione: un teatro che non teme di contaminarsi, perché sa che la vitalità nasce proprio dallo scontro tra codici, dall’attrito tra tradizione e sperimentazione. È in quell’attrito che si forma uno spettatore più vigile, meno rassicurato, più disposto a farsi interrogare.
Una domanda aperta e un po’ politica, forse, sul finale. L’Italia che paese è – oggi – per il teatro?
L’Italia oggi è un paese che chiede al teatro di resistere. Resistere alla marginalità a cui spesso viene relegato, resistere alla riduzione a intrattenimento, resistere all’idea che la cultura sia un lusso e non un diritto. È anche un paese pieno di contraddizioni: da un lato produce una straordinaria vitalità artistica, dall’altro non sa garantirle un terreno fertile, stabile, dignitoso. Per me il teatro in Italia non è mai stato specchio, ma sismografo: non riflette semplicemente ciò che accade, registra le scosse profonde, quelle che la politica, l’informazione o la retorica nazionale tendono a silenziare. Oggi il compito è ancora più urgente: fare del palcoscenico uno spazio critico, in cui la bellezza non sia evasione ma strumento per vedere più a fondo, e l’arte non sia consolazione ma un atto di cittadinanza. In questo senso l’Italia è un campo di battaglia, fragile e insieme necessario: un luogo dove il teatro può ancora – e deve – disturbare, incrinare, riaprire domande.
Per tutte le informazioni sul cartellone e i singoli spettacoli: Teatro Fontana.

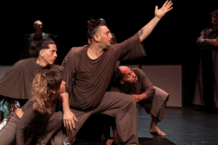
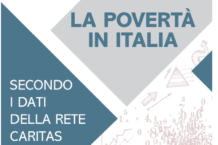

Devi fare login per commentare
Accedi