
Economia
Il lavoro che non c’è: globalizzazione e salari al ribasso
La globalizzazione trasforma il lavoro: delocalizzazioni e salari al ribasso creano precarietà, disuguaglianze e tensioni sociali. Il caso Stellantis in Serbia mostra come la competizione globale penalizzi i lavoratori locali e stranieri.
Negli ultimi decenni, la globalizzazione ha trasformato profondamente il mercato del lavoro. La possibilità di spostare capitali, merci e manodopera tra Paesi diversi ha ridisegnato le economie nazionali. Per alcune imprese, ciò ha rappresentato nuove opportunità di crescita, mentre per molti lavoratori ha generato precarietà e insicurezza.
Uno degli effetti più controversi della globalizzazione è la delocalizzazione: lo spostamento di produzioni e stabilimenti in Paesi con costi del lavoro più bassi. Le aziende multinazionali cercano continuamente di ridurre i costi operativi, massimizzando i profitti. Questo comportamento, tuttavia, spesso riduce l’occupazione nei Paesi d’origine e degrada le condizioni lavorative nei Paesi destinatari.
Le disparità salariali tra Paesi sviluppati ed emergenti sono evidenti. Secondo i dati disponibili, nel 2024 il salario medio annuo in Italia era di circa 35.616 €, mentre in Serbia era di 3.753 USD (circa 3.400 €) . In Nepal, il reddito medio annuo era notevolmente inferiore, attestandosi a circa 1.000 USD (circa 900 €) .
Queste differenze salariali evidenziano il divario tra Paesi ad alto reddito e quelli in via di sviluppo, con impatti significativi sulle dinamiche del mercato del lavoro globale.
Un esempio recente riguarda Stellantis, che ha aperto stabilimenti in Serbia impiegando lavoratori nepalesi e marocchini. Questi operai sono assunti con contratti temporanei e salari molto più bassi rispetto ai colleghi italiani o europei . In Serbia, un operaio può guadagnare circa 70.000 dinari al mese (circa 600 euro), una cifra insufficiente per una vita dignitosa. In risposta, l’azienda ha deciso di assumere 800 lavoratori provenienti da Nepal e Marocco, dove i salari medi sono significativamente inferiori. Questo fenomeno evidenzia come la globalizzazione possa portare a una competizione al ribasso tra lavoratori di diverse nazionalità.
Le delocalizzazioni non sono un fenomeno recente. Già negli anni Ottanta e Novanta, molte imprese europee e nordamericane spostarono parte della produzione verso Paesi emergenti dell’Asia e dell’America Latina. Le motivazioni erano sempre le stesse: salari più bassi e regolamentazioni meno rigide.
Settori come il tessile, l’elettronico e l’automobilistico hanno visto migliaia di posti di lavoro persi in Italia e in altri Paesi occidentali. Oggi, Paesi come la Serbia, la Polonia e la Romania sono mete privilegiate per nuovi stabilimenti industriali grazie a incentivi fiscali e manodopera a basso costo.
Uno degli effetti principali delle delocalizzazioni è la pressione al ribasso sui salari. Non solo nei Paesi che ospitano le fabbriche, ma anche nei Paesi d’origine. In Italia, molte aziende che non hanno delocalizzato completamente la produzione hanno comunque esternalizzato parti del processo produttivo o adottato contratti flessibili e part-time. Il risultato è chiaro: salari stagnanti, maggiore precarietà e minori tutele. La disuguaglianza economica aumenta, mentre il senso di insicurezza tra i lavoratori cresce. La globalizzazione ha quindi creato un mercato in cui il capitale si muove liberamente, ma il lavoro rimane vincolato a condizioni sempre più difficili.
La pressione sui salari spesso si accompagna a condizioni lavorative difficili: turni lunghi, sicurezza insufficiente e diritti sindacali limitati. Nel caso di Stellantis in Serbia, i lavoratori nepalesi operano in contesti dove la contrattazione collettiva è debole o assente. Questa disparità crea un divario evidente tra lavoratori locali e stranieri. I salari bassi e la scarsa protezione sindacale trasformano il lavoro in una risorsa sacrificabile per massimizzare i profitti. La dignità dei lavoratori diventa subordinata alle logiche di mercato.
Le delocalizzazioni generano un effetto domino anche sui mercati del lavoro locali. La concorrenza tra lavoratori stranieri e locali può deprimere i salari e ridurre le opportunità di carriera. In Serbia, ad esempio, la presenza di manodopera straniera a basso costo attrae investimenti, ma alimenta risentimento tra la popolazione locale. Il lavoro diventa quindi non solo un problema economico, ma anche sociale e politico. La competizione al ribasso può provocare tensioni e malcontento, che incidono sulla coesione sociale e sulla stabilità politica.
La risposta a queste problematiche non può essere puramente normativa o repressiva. Servono strategie complesse che tengano conto di competitività, diritti dei lavoratori e sostenibilità sociale.
Alcuni Paesi hanno introdotto incentivi fiscali per chi mantiene la produzione sul territorio nazionale. Altri promuovono la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali, oppure investono in formazione e innovazione tecnologica. L’obiettivo è rendere il lavoro locale più qualificato e meno sostituibile da manodopera a basso costo.
Nonostante questi sforzi, la logica globale spinge le aziende verso la massimizzazione dei profitti, spesso ignorando gli impatti sociali. Oltre alle delocalizzazioni, esistono fenomeni di outsourcing, subappalti internazionali e trasferimento di servizi digitali in Paesi con costi inferiori.
Ogni scelta aziendale che sposta produzione o servizi ha conseguenze dirette sui lavoratori. I salari al ribasso e la precarizzazione non sono episodi isolati, ma una tendenza strutturale della globalizzazione.
L’uso di lavoratori stranieri nei Paesi di destinazione solleva anche interrogativi etici. Il caso dei nepalesi impiegati da Stellantis in Serbia evidenzia come la mobilità della manodopera possa diventare uno strumento per comprimere i costi a scapito dei diritti fondamentali.
Le multinazionali, protette da normative più permissive all’estero, possono creare sistemi di lavoro inaccettabili nei Paesi di origine. Questo alimenta una competizione globale al ribasso, dove i diritti dei lavoratori diventano un costo da minimizzare.
Le delocalizzazioni contribuiscono alla crisi della coesione sociale. La perdita di posti di lavoro, la precarizzazione e la concorrenza tra lavoratori stranieri e locali generano malcontento e sfiducia nelle istituzioni. In alcuni casi, possono favorire fenomeni di radicalizzazione politica.
È quindi fondamentale che governi, sindacati e imprese costruiscano modelli di sviluppo sostenibile, che conciliino competitività economica e dignità del lavoro. Solo così il lavoro può essere considerato un valore sociale, non una merce sacrificabile.
Il lavoro che non c’è non è un fenomeno casuale. È il risultato di scelte economiche e politiche legate alla globalizzazione. Delocalizzazioni, salari bassi e precarietà rappresentano una logica che privilegia il profitto immediato a scapito dei lavoratori.
Affrontare il problema significa ripensare il modello economico globale, tutelare il lavoro come valore sociale e garantire che la crescita non avvenga a spese della dignità dei lavoratori. Solo così sarà possibile creare un mercato del lavoro equo, dove la globalizzazione non diventa sinonimo di sfruttamento, ma un’opportunità reale per tutti.


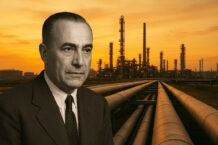
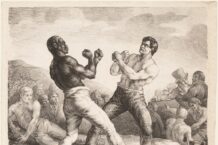

Devi fare login per commentare
Accedi