
Medio Oriente
La Gaza di Trump chiude l’epoca del diritto internazionale e apre quella degli Accordi di Abramo
Nel cuore della notte europea e mediorientale, quando negli Stati Uniti si faceva sera, Trump ha annuncia per primo – atto e tempistica erano egualmente obiettivi prioritari del Presidente USA – l’accordo tra Israele e Hamas sulla “prima parte” del piano di pace per Gaza, incentratata sul rilascio dei venti ostaggi ancora vivi dopo due anni e un giorno. Negli Stati Uniti è ancora l’8 Ottobre, in Europa e Medioriente è appena iniziato il 9. A due anni dall’inizio di uno dei più sanguinosi conflitti di questo inizio secolo, che sicuramente è stato il più seguito e mobilitante per le opinioni pubbliche del mondo intero, dopo decine di migliaia di morti nella Striscia di Gaza, si apre uno spiraglio di pace e, quandomeno, una tregua nel lungo percorso di distruzione e morte che sembrava non avere fine. Chi salva una vita salva il mondo intero, recita una delle più famose massime della tradizione talmudica: questa tregua di vite, dopo tanta dissipazione, ne salva molte di più, e non può che essere quindi una buona notizia.
Poi, prima e dopo, ci sono la politica del mondo e quella del Medioriente, e tanti pezzi da ricostruire, tasselli da mettere al loro posto, in un quadro che è nebuloso al presente, e pieno di incognite sul futuro. La certezza, il cardine dell’annuncio di Trump, è l’accordo su gli ostaggi, su quei venti che sono ancora vivi, sui cadaveri degli altri da restituire alle famiglie. In cambio Hamas e i palestinesi vedranno liberati circa 2000 prigioneri, 250 dei quali condannati all’ergastolo, e 1700 gazawi arrestati dopo il 7 Ottobre. Non saranno rilasciati, almeno per ora, i prigionieri più importanti nelle mani di Israele, Marwan Barghouti, Ahmad Sa’adat, Hassan Salameh, e Abbas al-Sayed, nè quanti sono nelle prigioni israeliane con l’accusa di aver progettato e guidato l’attacco del 7 ottobre. Lo scambio dovrebbe avvenire a giorni, probabilmente entro lunedì. Contestualmente, Israele si ritirerà parzialmente dalla Striscia e da entrambe le parti c’è un impegno a non effettuare operazioni militari. È un punto di equilibrio minimale e per definizione fragile, ma è la base minima per parlare del dopo, del resto, dove si annidano tutte le principali complessità e i rischi.
Il disarmo di Hamas e l’effettiva fine delle ostilità e delle operazioni di Israele sono, evidentemente, la parte più delicata della vicenda. E infatti sono sostanzialmente demandate a un nuovo, prossimo round di negoziati che si aprirà dopo lo scambio di prigionieri. Dal lato palestinese, infatti, la scia di distruzione e morte lascerà sicuramente sul terreno, assieme allo sfinimento, alla carestia, al lutto, la rabbia di un popolo zeppo di orfani, vedove e mutilati, ma anche una situazione di vuoto di potere nelle quali vecchie e nuove faide sono pronte a generare violenza interna e tentativi di violenza verso il nemico. Nel tempo di mezzo che separa il presente da un futuro “protettorato” possono succedere molte cose, nessuna di esse davvero prevedibile o controllabile.
Nel campo israeliano, la situazione è tutta diversa, ma in fondo non molto più ordinata. Netanyahu puntava sul prolungamento della guerra per aver garantita la stabilità del suo governo fino alla fine della legislatura, prevista tra un anno esatto. Solo la guerra, gli ostaggi ancora nelle mani del nemico, migliaia di giovani israeliani impegnati direttamente al fronte avrebbero garantito una stabilità alla sua coalizione di governo, composita e costantemente ricattata dall’estrema destra di Smotrich e Ben Gvir, ma anche dai partiti etnico-religiosi, ma anche messa sotto scacco dalle piazze che ricominciavano a ribollere, ma anche minacciata da azioni giudiziarie contro di lui sempre congelate in nome della difesa nazionale. Ma quando Trump ha deciso la sua offensiva perfino a Netanyahu non è restata altra possibilità che la resa. Che ovviamente promette di far emergere di nuovo, potenti, le faglie di conflitto interne alla società e alla politica israeliana, e una corsa a occupare lo spazio libero più a destra. Smotrich e Ben Gvir già si preparano a una campagna elettorale contro questa pace, che racconteranno non come una resa di Hamas, ma di Israele ad Hamas, promettendo che, se vinceranno loro, torneranno ad occupare Gaza. Che vincano è impossibile, ma gli equilibri del prossimo parlamento saranno ovviamente decisivi, e la battaglia politica inizia ora che (forse, speriamo) finisce la guerra. Tuttavia, una cosa va notata: qualcuno voleva Netanyahu alla sbarra della giustizia penale internazionale, mentre il suo unico problema possibile sarà, dopotutto, restare o tornare al governo.
Nella nebbia che avvolge il futuro, sembrano cristallizzarsi in modo chiaro invece alcuni equilibri internazionali di lungo periodo. Distrutti da Israele gli Hezbollah, e dimostrato agli Ayatollah iraniani che tra Gerusalemme e Washington nessuno ha davvero paura di fare loro la guerra, il perimetro del campo da gioco disegnato da Trump è in fondo sempre lo stesso, il suo preferito: un rapporto preferenziale, fondato su relazioni bilaterali, con le monarchie assolute e le dittature di vario tipo dell’area, fondato su rapporti di forza che giocano tra i tiranti del petrolio, delle armi, della difesa. Vale nel rapporto con l’Egitto di Al Sisi, che tutto voleva fuorchè di accogliere i profughi di Gaza in massa, e certo non poteva permettersi di perdere il rapporto preferenziale, in termini di business e relazioni, con gli USA. Vale per il Qatar che, incerdibilmente, dopo aver foraggiato e sostenuto Hamas per anni e anni, dopo aver ospitato i suoi capi fino al blitz nel quale Israele li ha uccisi, esce dalle secche di “stato canaglia”, di regno terrorista, con il nuovo status di alleato affidabile e ultra protetto proprio dagli USA di Trump, con tanto di accordo sulla difesa americana in caso di attacco. Che è come a dire che nessuno, neppure Israele, potrà più permettersi di toccare questo strano regno lillipuziano, grande come un piccola regione italiana, ma sconfinatamente ricco. Ovviamente, i regnanti qatarini sanno che d’ora in poi la politica estera degli USA nell’area coincide con la loro. Un discreto cambio di prospettiva.
E in qualche modo, ferme restando tutte le incognite che dicevamo prima sul futuro, è come se due anni dopo, 70 mila morti dopo, si stesse tornando con prospettive diverse alla casella di partenza. Sulle ceneri di Gaza ci sia avvia a riscrivere la storia degli Accordi di Abramo, il patto tutto fondato sugli affari e la pace tra gli Stati, che proprio il 7 ottobre fece saltare quando sembravano ormai cosa quasi fatta. Un patto nel quale non rientra la sovranità dei palestinesi secondo regole condivise nella cornice del diritto internazionale. Un patto che sancisce non solo la supremazia, ma l’autossufficienza assoluta dei rapporti di forza rispetto alle regole che servirebbero, in teoria, per limitare il predominio della forza sulla giustizia. Il processo di questa distruzione è iniziato da ben prima del 7 ottobre, del massacro di Gaza, della seconda ascesa di Trump, e anche della prima. Oggi, però, inizia probabilmente un nuovo mondo, nel quale tutto è chiaro: a una pace ingiusta non c’è alternativa nella realtà, se non quella della guerra infinita, il costo della quale da sempre e per sempre lo pagano gli ultimi. E questa, a ben guardare, non è proprio una novità.




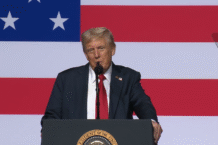
Devi fare login per commentare
Accedi