
Partiti e politici
Cosa resterà delle emozioni politiche che hanno riempito le piazze italiane per Gaza
È una forza tranquilla, in massima parte composta e pacifica, commossa e partecipe, quella delle manifestazioni italiane di queste settimane, che hanno riempito le strade per chiedere la fine della strage di Gaza. Per pura coincidenza, per innegabile assonanza, le masse di Roma, di Milano, di Napoli, di Bologna, e anche dei centri minori italiani, hanno scioperato e manifestato poche ore prima che Hamas desse una parziale ma simbolicamente fondamentale apertura al piano Trump, progettato come una resa senza condizioni per chi ha perduto definitivamente la sua guerra impossibile e metafisica contro un nemico infinitamente più forte, e non meno spietato, seppur protetto da quel che resta – in Israele soprattutto, ma forse non solo – della definizione di “democrazia”. Ci ritorneremo, perchè la storia, nella forma della tragedia, che ridisegna i confini di cosa possiamo chiamare pace, si fa ovviamente laggiù: tra le spiagge insanguinate di Gaza e una narrazione nazionale d’Israele ancora fondata dal 7 ottobre di due anni fa.
Quassù, intanto, un un paese che pare ormai indifferente a tutto, che non si mobilita per i suoi diritti erosi, che non si mobilità quando in nome della propria sicurezza è lui stesso a uccidere in mare donne e bambini trasportati dai “trafficanti di morte”, che non si mobilita per l’erosione dei salari, dei diritti a una sanità e a una scuola pubblica dignitose, la strage di Gaza è stato un enorme catalizzatore di indignazione e protesta. Lo è stato prima e di più che da noi, nei college americani e per le strade delle capitali europee, seguendo una traiettoria non nuova ai movimenti di protesta. Il fuoco italiano delle proteste per Gaza è divampato forse dopo, ma sembra arrivare più in profondità: o forse è solo più duraturo. L’orrore per quel che è stato fatto a Gaza da Israele, infatti, è penetrato anche nell’elettorato che ha permesso a Giorgia Meloni di arrivare a Palazzo Chigi. Lo si percepisce nelle voci dei bar di periferia, lo confermano i sondaggi, e le due cose insieme spiegano anche perchè la premier ha dichiarato, pochi giorni fa, che Israele “ha passato il segno”.
Se sembrano logiche dal passo asfittico, che portano la tragedia del mondo sul tavolo della piccola politica nazionale, bene, forse lo sono, ma non riguardano solo chi governa: tra i contraenti di maggioranza del Campo Largo, infatti, il rifiuto dell’orrore di Gaza è tra le poche cose che uniscono neppure tutto, ma almeno una parte importante della coalizione che tiene insieme (quasi) tutti gli anti-Meloni. Che il nostro governo sia il più trumpiano d’Europa è indubbio, che qualche ministro non competente per materia (di politica estera) si faccia addirittura selfie con Netanyahu è certo, quanto patetico. Che un riconoscimento italiano della Palestina, o un intervento governativo per fermare le residuali esportazioni belliche verso Israele, cambierebbero di un centimetro la storia, questo invece non è proprio credibile. Che un altro governo, di altro colore, avrebbe usato altri toni – tra mille distinguo – è sicuro: che una sola vita innocente sarebbe stata salvata, è difficile da credere.
E per non fare torto a nessuno, anche dalle parti dei sindacati non sembrano mancare le contraddizioni, con la CGIL, il primo sindacato italiano, che è sembrato inseguire il sindacalismo di base dell’USB, come fanno i giornali quando prendono il “buco”, e il giorno dopo copiano la notizia data ieri da qualcun altro.
Queste dinamiche di potere politico e mediatico, ovviamente, non tolgono nulla alla veracità del sentimento di protesta sincero e popolare espresso dalle piazze. Anzi, a dirla tutta la confermano, perché mostrano oltre ogni dubbio che le rappresentanze istituzionalizzate si mettono di fatto in coda a ciò che ha smosso il corpo grosso della società. Una volta, quando Landini era giovane ed Elly Schlein non era ancora nata, sarebbero stati alla testa, geografica e politica, di questi cortei, oggi no, ed è un dato significativo in vari modi, su vari fronti.
Il primo, il principale, è che la mobilitazione popolare è avvenuta in maniera largamente spontanea, sincera, non affiliata. Le immagini del massacro, il senso di impotenza e infinita debolezza del popolo di Gaza, l’assenza di ogni possibile speranza per la fine di questo orrore hanno smosso le coscienze di centinaia di migliaia di nostri concittadini, che sono scesi in piazza, ed è un dato straordinario. Lo si capiva guardando l’eterogeneità di quella piazza: i centri-sociali che volevano una Palestina libera “dal fiume al mare” – slogan uguale e contrario a quello dell’estrema destra israeliana che sogna un grande Israele senza nessuna Palestina – e tante famiglie e persone comuni che non avevano nessun massimalismo, sottobraccio, se non quello dell’indignazione per l’umanità violata.
Il secondo nasce ai margini del corteo di Milano, dove abbiamo visto e notato, in molti, una grande partecipazione di persone di origine araba. Alcune erano sicuramente prime generazioni, immigrati non più giovani probabilmente arrivate con le prime ondate del tardo Novecento. Altre erano visibilmente giovani, chissà se nate qui, chissà se già cittadine italiane. Difficile capire da dove vengano queste persone, ci soccorrono le statistiche: gli arabi di Milano vengono in molti dall’Egitto, vicino alla Palestina quando basta per avere un ruolo fondamentale nel futuro del Piano Trump, e in moltissimi dal Marocco, lontano per geografia e storia da essere da sempre ai margini degli equilibri che contano, in Medioriente. Nella città italiana con la più alta percentuale di stranieri residenti, ma sicuramente non solo qui, questo movimento popolare di solidarietà a Gaza è stata forse la prima occasione di partecipazione politica e di opinione diretta numericamente rilevante della cittadinanza figlia dell’immigrazione.
Le due questioni delineate ora ci portano a una terza, cruciale, che emerge guardando avanti. Queste piazze non ci ricordano solo, doverosamente, il dovere di continuare a guardare con attenzione, apprensione, speranza (per chi riesce a coltivarla) per il futuro di Gaza. Non ci ricordano solo che quando arriverà la “pace” sarà anche al costo intollerabile – eppure non certo nuovo, per l’umanità – di rimuovere da un discorso pubblico di giustizia molte delle colpe e dei crimini, e dei nomi di chi li ha commessi. Queste piazze ci ricordano qualcosa che è perfino più grande della storia contingente e disperante di questi due anni, perché ci dicono che a certe condizioni, per certe ragioni, contando sul senso di giustizia, l’ingenuità, attraversando le opposte propagande, non senza contaminarsi col conformismo che da sempre ingrossa le fila delle proteste, anche le più difficili e minoritarie, c’è un momento nel quale la società vuole partecipare e dire la sua. Vuole incidere sulla storia. Le piazze italiane provano a farlo su una questione apparentemente lontana eppure davvero vitale, e su un tavolo – quella della politica internazionale, e del quadrante mediorientale – nel quale lo spazio per agire e incidere è ragionevolmente ai minimi storici. In questo paradosso non c’è solo il dovere di guardare responsabilmente, criticamente, all’Europa – cioè all’unica prospettiva politica che potrebbe, semmai, in futuro, rendere la protesta capace di produrre politica – ma anche una profonda domanda di senso su che valore abbia la capacità di governo dei paesi democratici, e su cosa significhi, in definitiva, vivere in una democrazia. È la domanda che dovrebbe perseguitare l’Israele di Netanyahu, ma un certo tormento dovrebbe darlo anche a noi.




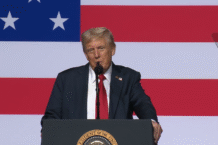
Devi fare login per commentare
Accedi