Palermo
Appunto sulla Palermo araba
La Palermo delle 300 mosche, realtà multiculturale tollerante della dominazione araba è solo un’invenzione letteraria
Quando, nell’831 d.c., gli Arabi entrarono a Palermo, città di circa trentamila abitanti, la trovarono pressoché vuota. Secondo ibn-al-Athir , storico curdo autore di una famosa storia del mondo, il numero dei superstiti degli abitanti originari non superava le tremila unità. La sorte di quanti erano riusciti a salvare la pelle, fu segnata dalla tragica sottomissione al vincitore. Molti furono ridotti in schiavitù mentre quanti scamparono alla sorte servile pagando l’esoso prezzo della libertà dovettero accettare la condizione di dhimmi, cioè a sudditi con uno statuto particolare che ne annullava quasi ogni diritto e ne estendeva a dismisura doveri e divieti.
La lettura attenta delle cifre che abbiamo riportato ci fanno capire perché, con buona pace di chi non si rassegna alla favoletta della profonda impronta araba, ci si riferisce soprattutto alle architetture islamiche, che la segnerebbe, tracce di quella presenza ci sia poco o nulla. I nuovi padroni non avevano infatti bisogno di edificare alcunché visto che potevano approfittare di un consistente patrimonio edilizio per tutte le loro esigenze. Le numerose chiese già presenti dentro le mura urbane, ivi compresa la cattedrale, furono infatti trasformate in moschee e gli edifici pubblici della città bizantina, con il complesso del palazzo reale, salvo qualche limitata modifica, divennero le sedi dell’amministrazione islamica.
Di nuova edificazione ci fu solamente la Kalsa dove, per ragioni di sicurezza, da un certo momento in poi, durante il periodo Kalbita, risiedette l’emiro.
Sono inoltre da prendere con le pinze molte ricostruzioni letterarie che riguardano poi la presunta opulenza della città nel periodo arabo come la favoletta delle 300 moschee. Se, infatti, qualche opulenza c’è stata, essa sarebbe derivata dalle attività non certo nobili legate al suo porto.
Lo scalo della Balarm araba era, infatti, soprattutto un porto militare dove si concentravano le flottiglie impiegate per le incursioni piratesche che i saraceni periodicamente conducevano sulle coste della penisola. Da Palermo, ad esempio, partirono molte delle imbarcazioni da battaglia che, nell’846, si avventarono su Roma, portando nell’agro romano distruzione e morte.
L’incursione su Roma, in parte fallita per la resistenza degli assediati, aveva infatti come scopo non tanto la conquista ma il saccheggio del territorio. Quella spedizione, come riferiscono le cronache, realizzò un enorme bottino come esito delle razzie di uomini e cose nelle campagne circostanti la città, furono peraltro spogliate le basiliche vaticane di San Pietro di San Paolo, allora ubicate fuori le mura cittadine.
Di quel bottino, con il relativo carico di schiavi, i saccheggiatori tuttavia non ne poterono godere, a causa di una tempesta che fece colare a picco gran parte dei vascelli sui quali era stato stivato.
Tornando all’opulenza di Palermo non bisogna trascurare, infine, un’altra attività particolarmente redditizia che, con gli occhi del presente, considereremmo poco apprezzabili. Mi riferisco al commercio degli schiavi frutto appunto delle spedizioni piratesche condotte nei territori bizantini e longobardi. Palermo era, infatti, divenuta uno dei più grandi mercati degli schiavi del Mediterraneo e, si potrebbe dire che, in quel periodo, svolgesse la stessa funzione che avrebbe fino alla fine del Settecento svolto la città di Algeri.

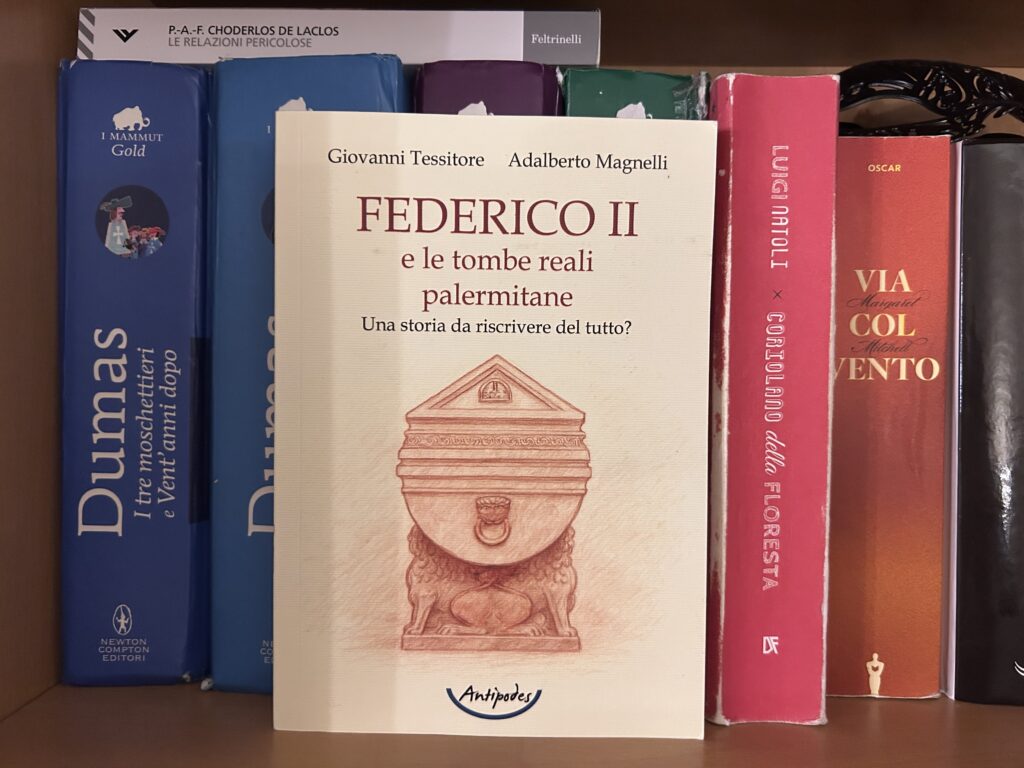


Devi fare login per commentare
Accedi