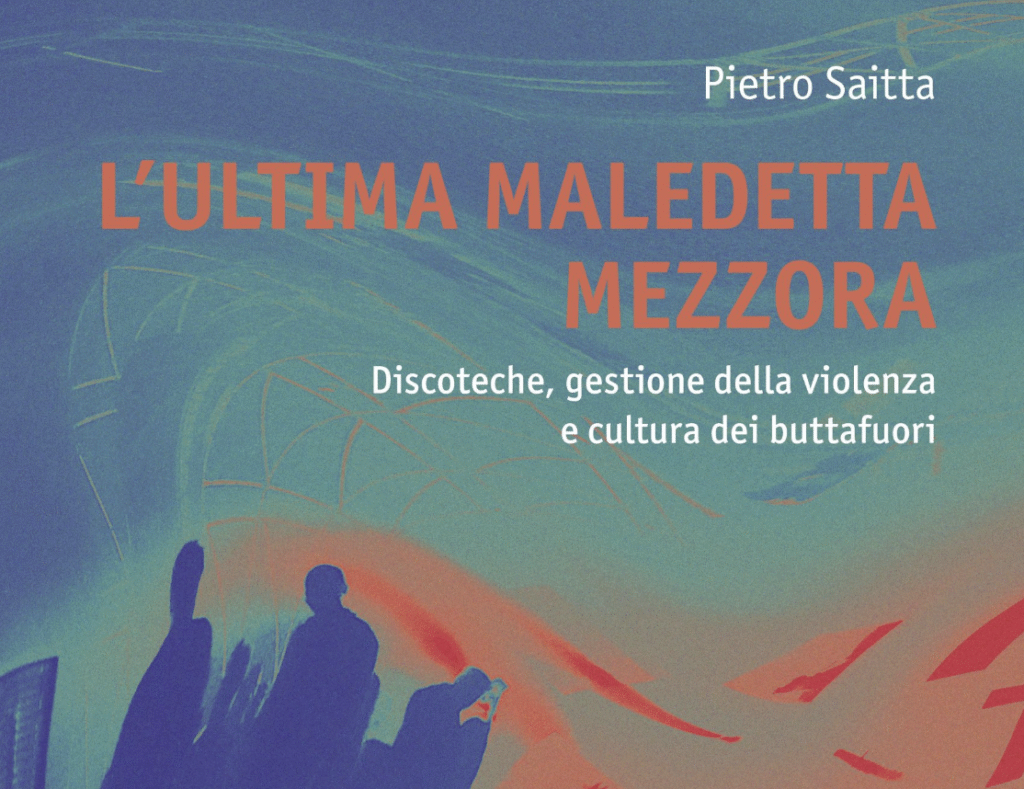
Lifestyle
L’ultima maledetta mezz’ora, discoteche e buttafuori nel nuovo libro di Pietro Saitta
Il 19 settembre, per i tipi della casa editrice Ombre Corte, esce L’ultima maledetta mezz’ora. Discoteche, gestione della violenza e cultura dei buttafuori, il nuovo libro del sociologo Pietro Saitta. Si tratta di una ricerca svolta con metodologia partecipativa che impiega la discoteca come punto di osservazione per lo studio di dinamiche che, oltre che l’economia della notte, riguardano la città, le relazioni e la violenza che spesso la attraversano. La discoteca è infatti uno spazio in cui confluiscono masse di persone, mode ed edonismo, così come avversioni e dibattiti della contemporaneità (per esempio la violenza di genere), paure sociali (i “maranza”) e svariate tecnologie (da quelle per la comunicazione a quelle per il controllo). In ragione dei criteri impiegati per la selezione all’ingresso, alcune discoteche appaiono inoltre come esempi di frontiera interna alla vita urbana. In questo estratto a essere analizzate sono alcune caratteristiche di una categoria di operatori della notte che spesso affascina e turba il pubblico: quella dei “buttafuori”.
Classe, maschilità e relazioni di gruppo
[…] Poco sopra è stato osservato che il “lavoro alla porta” riproduce molti valori mascolini e tipi di capitale corporeo che erano dominanti nei reparti produttivi della fabbrica e che caratterizzano ancora la cultura operaia in genere. Durezza, disponibilità allo scontro e propensione al lavoro sono alcuni di essi. Tuttavia mentre in fabbrica i lavoratori plasmano oggetti e la relazione è apertamente di subordinazione, nei lavori incentrati sulla sicurezza e la rappresentanza – come quelli che hanno luogo dinanzi agli ingressi dei locali – a essere forgiati sono i comportamenti di altri individui, ossia i clienti (Søgaard and Krause-Jensen 2020, p. 32). Il lavoro di “buttafuori”, insomma, illude chi lo svolge di potere invertire il normale flusso del potere e delle relazioni sociali, dando alla classe operaia la possibilità di dominare un mondo sociale vario, che, certamente, include persone che attraverso il consumo non accedono soltanto a un divertimento, ma mettono in mostra la propria appartenenza a uno stile di vita patinato.
Quest’ultima cosa, dopo tutto, appare particolarmente evidente quando si pensa che molti clienti trasformeranno il loro passaggio in un locale in un post per i social network. Qualcosa che parteciperà dunque a produrre un’illusione speculare a quella dei buttafuori: quella da parte degli avventori di potere essere ammirati, invidiati o di produrre un qualsiasi altro sentimento a cui essi aspirano, dando in visione al loro pubblico momenti e luoghi ritenuti idonei a suscitare queste impressioni. Dentro questo rapporto, il buttafuori è colui che può consentire, rifiutare oppure interrompere l’accesso a quelli che sono contemporaneamente spazi edonistici e di affermazione della presenza individuale. Luoghi cioè imprescindibili ai fini della produzione di quelle messe in scena individuali che un gran numero di persone persegue recandosi proprio nei locali notturni.
Tuttavia l’illusione di potere che in alcune circostanze i buttafuori derivano dall’esercizio del ruolo e dalla visibilità è anche effimera. Questa illusione, cioè, si rinnova ogni volta per eclissarsi rapidamente nel corso della medesima sera. Inoltre, una volta che tali sensazioni siano state avvertite a lungo, è probabile che a subentrare siano noia e prevedibilità. La stessa prevedibilità, in fondo, costituita dai volti dei clienti abituali di un locale; coloro che saranno visti, e che vedranno i buttafuori, decine di volte nel corso di una stagione. In questi inevitabili casi vi è dunque bisogno di motivazioni più solide per continuare a lavorare. Specie se si considera che il buttafuori è frequentemente un doppio o triplo-lavorista.
In rapporto a quale sia il livello di integrazione di un addetto in una squadra, ovvero della lunghezza della sua appartenenza a essa, a fornire tali motivazioni può essere la costituzione di uno spirito di corpo, ovvero una camaraderie. Ossia l’emersione di un sentimento di appartenenza e connessione tra addetti, i cui effetti sul lavoro, i clienti e il servizio possono risultare sia positivi sia negativi. Creando di volta in volta cooperazione e sostegno oppure complicità, copertura delle violazioni alle regole e sentimenti di contrapposizione tra i lavoratori e altri tipi di attori, che si tratti, per citarne solo alcuni, della direzione dei locali oppure dei clienti (Burhan e Malik 2024).
In realtà il lavoro di controllo implica lunghi momenti di solitudine trascorsi in una posizione a scrutare il pubblico o a sorvegliare un’uscita di sicurezza. Oppure, se va bene, all’ingresso di un privé dove le interazioni sono sì continue, ma limitate per lo più a verificare che chi intende passare disponga di un bracciale di carta al polso o di qualunque altra marcatura atta a verificarne il titolo a oltrepassare la soglia. Tuttavia altri compiti sono invece maggiormente sociali. È questo il caso di quando si sta alla porta o alle transenne in attesa di nuove ondate di clienti che, però, arrivano gradualmente sempre più diluite nell’arco della serata. In questi momenti le parole – ossia i ricordi, le confessioni, lo scherzo triviale, la critica delle persone e i pettegolezzi – diventano centrali per la costituzione di uno spazio intimo, imperniato sulla comunanza della condizione. È questo uno spazio che prende a ruotare altresì intorno alla classe, al lavoro e al corpo.
A quest’ultimo riguardo, il corpo del buttafuori è un corpo che soffre perché è abusato. È un fisico frequentemente traumatizzato dal lavoro. Per restare ai casi studiati, possono caratterizzarlo delle “fratture del pugile”, come segnalato magari da un tutore alla mano. Una conseguenza, magari, di un intervento duro. Per esempio quello rivolto contro un “giunco di 120 kg che faceva MMA”. O, analogamente, reso evidente da nocche vistosamente rotte, frutto di una lotta ugualmente difficile contro un avventore agguerrito. Ma non si dovrebbero dimenticare le coliche renali, che lasciano spazi a disquisizioni informatissime sulle acque migliori e con più bassi livelli di sodio e calcio. È possibile, persino, trovare chi si sottoponga a frequenti sedute di dialisi e si ostini ciò nonostante a mantenere il proprio posto ogni sera, godendo come unico privilegio della possibilità di stare seduto su uno sgabello. Ma non si dovrebbe dimenticare neanche la frustrazione per quei corpi che si intendevano preparare per una gara di bodybuilding e che risultano invece acquosi e perciò poco competitivi come effetto del cortisolo che la fa da sovrano in ragione delle notti insonni. Corpi, comunque, che non rinunciano agli steroidi, agli anabolizzanti o alla Terapia sostitutiva con testosterone nel disperato tentativo di riempire una “bottiglia svuotata che va riempita”. Ossia per sostenere un corpo che invecchia e che vede dunque crollare i livelli di quell’ormone steroideo così importante per la prestazione fisica e psicologica. Un corpo, inoltre, che si macchia di psoriasi o disturbi simili come effetto di un indebolimento del sistema immunitario, anch’esso conseguenza di un riposo pressoché inesistente.
In questa dinamica colloquiale, a contare molto è la natura del gruppo. Ossia se questo è di antica o recente costituzione; se formato da persone divenute amiche negli anni, oppure da individui che si ritrovano a condividere unicamente una stagione o qualche serata di lavoro. Tuttavia è comunque probabile che nel tempo questi lunghi momenti di attesa diventino l’occasione per condividere storie personali e collettive. Infatti mentre gli scambi di informazioni e gli avvertimenti su chi stia dentro e cosa aspettarsi costituiscono la base primaria delle comunicazioni, nel trascorrere del tempo sono il quotidiano e il passato a diventare egemoni nelle conversazioni. Si ascolteranno dunque rievocazioni della violenza praticata o testimoniata nel corso del lavoro oppure in strada. Il richiamo di risse passate sarà frequentissimo così come quello di personaggi a proprio modo pittoreschi che hanno marcato il mondo dei locali così come dei quartieri.
Il ricordo di nomi e di situazioni alimenta discussioni infinite su ruoli giocati da qualcuno dei presenti in un evento rimasto nella memoria della strada oppure poco conosciuto, ma ugualmente degno di essere menzionato. A partire da ciascun racconto si apriranno così finestre su mondi e situazioni personali apparentemente sconnesse: gli anni del carcere di alcuni; i soldi dovuti da qualcuno e mai restituiti; i torti subiti e riparati in una qualche occasione; un cattivo padrone e il criminale che lo aveva terrorizzato; le macchine e le moto possedute; i regali costosissimi fatti ai genitori per ricambiarne l’amore. E poi le miserie del lavoro di giorno; la mancanza del figlio che questa sera piangeva a vedere il padre andare via nuovamente; una separazione impendente etc. Una lista infinita, impossibile e forse anche inutile da riportare per intero che, spezzone dopo spezzone, mette in luce il peso di un mondo insieme individuale e plurale accomunato da un unico senso complessivo, fatto di tratti biografici, condizioni, responsabilità ed esposizione alle incertezze.
Si tratta dunque di una comunità di uomini che nel corso di notti come quelle descritte prima trova, oltre che un reddito, l’occasione per produrre insieme ad altri degli scambi che rendono questo lavoro diverso da altre occupazioni per loro tipiche. Per esempio quella di operaio, che si svolge tra poche parole e sospeso su un’impalcatura; oppure in solitudine, nella cabina di un furgone o di un camion. O, magari, tra le fila di scaffali di un supermercato.
Inoltre il buttafuori è esposto a stimoli ottici, a stili e a stranezze di ogni genere. Da questa condizione tipica del lavoro ciò che ne deriva è che egli finisce con lo sperimentare forme di socialità che non sono affatto ovvie se si guarda alla maggior parte dei lavori operai contemporanei e persino alle forme complessive della vita quotidiana. Si tratta di quello che conferisce a questo tempo – ossia a quel fondamentale elemento di misura della vita che costituisce la base dello scambio economico in atto tra lavoratore e proprietari – un carattere specifico.
Restando nell’ambito della discoteca, la condizione del buttafuori è per esempio diversa da quella tipica di chi lavora alla cassa – frequentemente una donna – costretta a stare concentrata sul denaro e con una possibilità di interazioni limitate […] Ciò fa sì che per un buttafuori una serata di lavoro sia anche una serata di relazioni intense. Relazioni, cioè, che determinano tanto la possibilità di scambi profondi tra pari nei momenti di bassa tensione, quanto la capacità di operare collettivamente e secondo un ritmo coordinato nel corso di altre fasi, prescindendo dall’impiego di parole. Per esempio queste sono le fasi convulse di una lite, per arginare la quale occorre intervenire confluendo rapidamente da più lati insieme ai colleghi; ma anche quella della gestione di una fila costituita da centinaia di persone che premono alle transenne e che hanno esigenze differenti (l’accesso al tavolo anziché un ingresso semplice, per citare i due casi più comuni), che richiedono trattamenti particolari (per esempio il potere parlare con un particolare organizzatore), che pongono questioni di giustizia e uguaglianza nel trattamento loro riservato, oppure che rifiutano di essere respinti (magari perché non rientrano nel target della serata o appaiono malvestiti).
Nella frenesia di questi momenti un gruppo collaudato segue, come si diceva, un ritmo (Lefebvre 1992). Ossia un gioco col tempo, scandito secondo una logica interna, fatta di ripetizioni e di differenze, che non ha per lo più bisogno di ricorrere alla parola e che fa sì che alcuni “spingano” le persone con biglietto dentro, che altri aprano o chiudano le transenne a seconda dell’andamento della fila, che altri ancora prestino attenzione ai movimenti sospetti di un gruppo etc.
Ma sono gli interventi nei momenti di tensione tra i clienti a mostrare – quando esso esista e le cose scorrono al meglio – il carattere realmente profondo e “organico” delle relazioni che hanno luogo in un ambito professionale di questo tipo. Per esempio, a seconda delle circostanze, gli interventi in sala possono implicare pericolose asimmetrie. Un singolo addetto può notare una situazione che lo vede costretto a intervenire, malgrado il rapporto tra lui e le persone giunte alle mani versi spropositatamente a proprio svantaggio. Se egli lo può fare non è solo in ragione del proprio coraggio o della propria forza fisica, ma perché sa che nell’arco di pochi secondi altri colleghi arriveranno sgomitando tra la folla e riequilibrando la situazione.
Quest’aspettativa è un elemento che accomuna l’esperienza della sicurezza a quella dei corpi armati dell’esercito o della polizia. È la base, cioè, per l’emersione di particolari tipi di legami personali che eccedono quelli di altri mestieri e professioni civili (Medeiros 2024). Restando così sul piano collettivo, la condivisione protratta di rischi fisici e la formazione nel tempo di una storia comune – ossia di una successione di storie slegate, ma unite tra loro dal filo rosso del rischio – crea il presupposto per tipi di legami che giocano un ruolo fondamentale nel motivare gli individui a continuare a svolgere un’attività del genere – ossia poco remunerativa, rischiosa e usurante – per molto tempo. Lì ove è proprio il tempo, come abbiamo visto, un elemento fondamentale per la definizione di una passione, ossia di un’affezione posta al di là della ragione razionalizzabile.

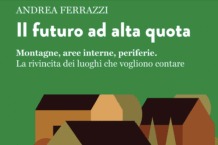


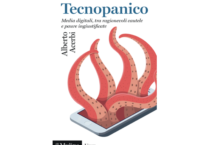
Devi fare login per commentare
Accedi