
Tennis
La piramide del tennis mondiale: pochi salvati, molti sommersi
Mentre Jannik Sinner domina le ATP Finals, lontano dai riflettori centinaia di professionisti faticano a sopravvivere tra voli low cost, disagio psichico e solitudine
All’origine, tutti gli sport erano elitari. Inventati nella Gran Bretagna vittoriana, furono a lungo praticati soltanto dagli aristocratici e dai borghesi arricchiti dalla Rivoluzione industriale. Erano tutti amateur, perché non avevano bisogno di guadagnare e potevano dedicare il proprio tempo a impieghi non utilitaristici. Perciò il dilettantismo rappresentava un dogma indiscutibile, al pari del fair-play che sempre distingueva tali contese fra gentlemen e poche ladies. Nel tennis, il fair-play è ancora una regola non scritta seguita quasi universalmente, mentre il dilettantismo (spesso di mera facciata) ha governato il sistema fino al 1968, quando il circuito divenne open, ossia aperto anche ai professionisti, che fino ad allora erano esclusi dagli Slam, i prestigiosi tornei di Melbourne, Parigi, Londra e New York, che per questo stavano però diventando sempre meno prestigiosi.
Anche il carattere elitario è sopravvissuto. Tuttavia, il tennis non è oggi esclusivo per patrimonio familiare o per quarti di nobiltà, ma per rendimento e premi. Le ATP Finals, che ieri Jannik Sinner si è aggiudicato per la seconda volta consecutiva, intascando la cifra stratosferica di 5.071.000 dollari, sono la summa di questa crema tennistica mondiale. I migliori otto giocatori del ranking, otto uomini-azienda, otto capitali tecnici e monetari si fronteggiano per distillare il più forte di loro in un mini-torneo fatto di scontri al vertice, cui per la prima volta nella storia hanno partecipato due azzurri: il tetragono e imperturbabile dominatore altoatesino e il sanguigno e raffaellesco Lorenzo Musetti da Carrara, che invece non ha superato lo scoglio del gironcino di qualificazione, pur riportando contro l’australiano Alex De Minaur una memorabile vittoria, che potrebbe costituire una pietra miliare in un percorso agonistico ancora non risolto.
Hanno calamitato l’attenzione di tutti gli appassionati del pianeta, ma con ogni probabilità non hanno avuto addosso gli occhi dei loro colleghi meno fortunati e meno capaci, quelli che sgomitano ben oltre la centesima posizione in classifica e che si dibattono fra il sogno e la sopravvivenza. Costoro erano verosimilmente impegnati a prenotare un volo low cost o a dividere un albergo di seconda categoria con qualche collega-rivale, a negoziare il compenso di un allenatore o di un preparatore atletico, magari in vista di una partita serrata sul campo scalcinato di qualche repubblica centrafricana, di fronte a spalti semivuoti.

Qualche settimana fa, ha destato un certo scalpore Valentin Vacherot, che da n. 204 del mondo ha vinto il Master 1000 di Shanghai, che per importanza appartiene alla categoria subito dietro i quattro tornei dello Slam. Con quel successo ha più che triplicato il montepremi guadagnato nei precedenti cinque anni di carriera, è diventato il primo giocatore del Principato di Monaco a conquistare un titolo del circuito maggiore e il più basso in classifica a farlo, svelando che fra i top-player osannati dai fan e i peones che si barcamenano nelle retrovie del circuito non esiste tutto il divario che la squilibrata attenzione dei media lascerebbe intendere. Il tennista monegasco ha inoltre compiuto una traiettoria evolutiva particolare, perché finita l’adolescenza ha usufruito di una borsa di studio dalla Texas A&M University e lì ha completato la formazione sportiva e educativa, rinunciando a qualche anno di professionismo (e ai potenziali guadagni), ma beneficiando delle strutture, dei servizi e dell’appoggio garantitogli dall’università nelle ardue fasi d’avvio della carriera. Il tennis universitario è una via sempre più battuta per raggiungere il circuito professionistico, ma questa opportunità potrebbe essere preclusa in futuro agli atleti non statunitensi, considerato che la nuova politica anti-immigrazione della Casa Bianca, con la sospensione dei colloqui per i visti di studio, la revoca dello status legale di molti studenti e l’aumento dei controlli a fini repressivi impedisce e impedirà a moltissimi studenti internazionali di proseguire o cominciare il college negli Stati Uniti.
Il limbo fra gli ultimi anni delle competizioni giovanili e il salto nel professionismo costringe le famiglie dei giovanotti abbastanza bravi da sperare razionalmente di progredire, ma non così tanto da attirare il denaro degli sponsor, a svenarsi in spese esorbitanti: somme considerevoli se ne vanno per allenatori, tasse d’iscrizione e fisioterapista, per viaggi, vitto e alloggio, per abbigliamento e attrezzatura. Le stime sono variabili e voci diverse possono concorrere a determinare una spesa totale, ma la conquista dell’agognato primo punto nella classifica mondiale, qualcosa che ti ammette fra i primi duemila giocatori del pianeta, può costare una cifra intorno ai 300.000 dollari e frequentare un’accademia tennistica anche molto di più. La posizione in classifica è tutto per un tennista, stabilisce contro chi e dove giochi, a quale livello e quanti soldi puoi sperare di guadagnare: Stefano Travaglia, n. 60 del ranking mondiale nel 2021 e oggi oltre la duecentesima posizione, ha raccontato di aver messo insieme un “reddito” annuo di 30.000 euro, grazie soprattutto agli sponsor che gli sono rimasti fedeli dai tempi belli. Proventi neanche lontanamente paragonabili ai 65 milioni incassati da Sinner l’anno passato fra montepremi, esibizioni e introiti commerciali. Il divario in premi fra i migliori e chi rema nelle retrovie è più che mai evidente nel grafico elaborato da Emanuele Ricciardi, autore del competente e prezioso podcast Slice: se è vero che il binomio Sincaraz ha aperto una voragine pure con il resto della concorrenza più qualificata, risulta innegabile che la distribuzione del prize money è clamorosamente sbilanciata verso l’alto, svelando con la spietatezza dei numeri che la stragrande maggioranza di chi impugna professionalmente una racchetta ha molte probabilità di sopravvivere stentatamente.
D’altra parte, se giocare per l’università riduce quasi a zero i costi iniziali sopra elencati, non ti mette al riparo dalle crudeli leggi del tennis professionistico, come dimostra la parabola di Noah Rubin, stella della Wake Forest University e prima ancora talento cristallino alla scuola di John McEnroe, che lo definì, quando aveva solo quindici anni, la più grande promessa americana. Promessa mai mantenuta, poiché dopo un folgorante inizio da juniores e un paio di infortuni, Rubin è rimasto impelagato in un anonimato doloroso, tra ristrettezze economiche e crisi nervose. «Questo sport ha il potere di precipitarti nell’irrilevanza e al contempo di farti sentire come se tutto ti fosse dovuto», ha detto una volta, dimostrando che il tennis vive una netta disconnessione fra l’immagine dorata di chi trionfa al Roland Garros e a Wimbledon e la realtà vissuta da schiere di professionisti preparatissimi ma invisibili, costretti a fare i conti con precarietà economica e depressione psicologica. Prima di prendersi un break a tempo indeterminato, che si è poi trasformato nel ritiro dall’agonismo a soli 26 anni, Rubin ha lanciato il podcast “Behind the racket”, nel quale centinaia di colleghi e colleghe hanno rotto il silenzio sui loro problemi di salute mentale, una pena che non risparmia neanche le star, come testimoniato dai crolli nervosi di Mardy Fish, Naomi Osaka o Paula Badosa. Sulla stessa falsariga, un asciutto ma sofferto articolo di Conor Niland, ex n. 1 d’Irlanda, ha messo il dito nella piaga del disagio psichico causato dalla condizione di solitudine abitualmente sperimentata dai giocatori e dalle giocatrici che gravitano lontano dalle luci della ribalta.
L’Association of Tennis Professionals (ATP) negli ultimi anni ha incrementato i premi per i tornei minori e per i primi turni, e varato un piano pensionistico collettivo cui potranno accedere i giocatori a partire dall’età di 50 anni. Secondo alcuni, si tratta però di misure non sufficienti a garantire che in futuro ci saranno ancora giovani desiderosi di intraprendere la carriera tennistica anche senza genitori danarosi alle spalle. D’altra parte, il tennis è uno sport eminentemente individuale e finora i giocatori non sono riusciti a parlare con una sola voce per far valere le ragioni del 90% di loro, ma se il movimento vuole davvero assicurarsi un domani, dovrà imparare a proteggere i tanti giocatori senza volto che lo tengono vivo ogni settimana: è qui che si gioca la partita più importante.



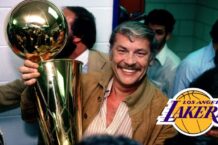

Articolo quanto mai necessario a tutti i tifosi, me compreso, delle stars del tennis. Il problema di fondo è centrato perfettamente e fa apparire il tennis come un eden per alcuni, davvero pochissimi, e un calvario per tanti altri. La sproporzione fra i compensi dei primi e la massa che li segue e affronta fior di sacrifici per sopravvivere è allucinante.