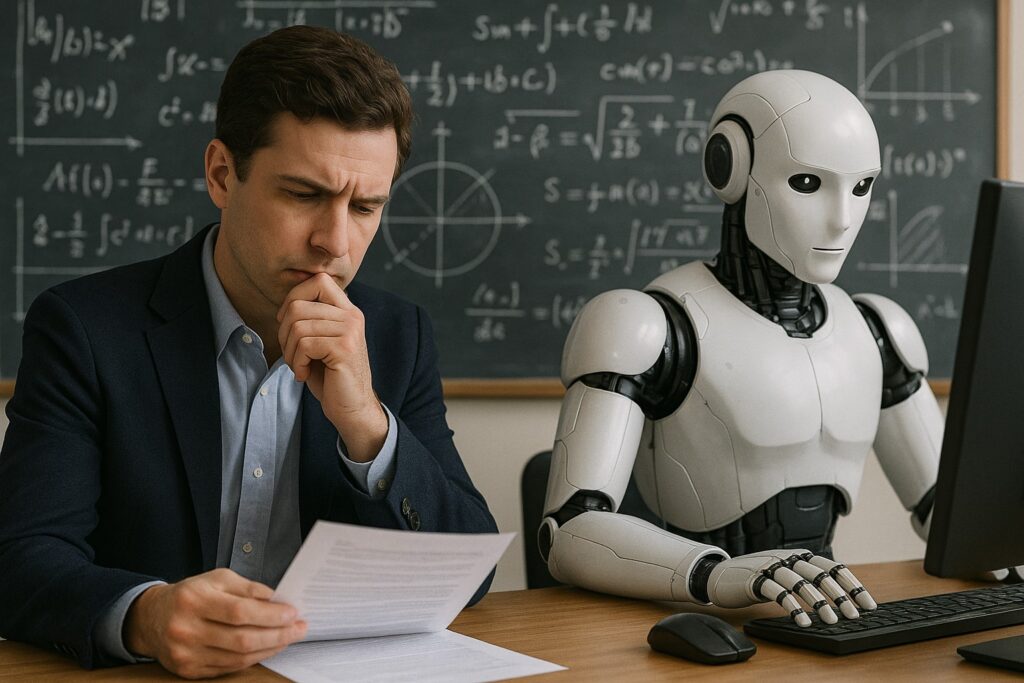
A.I.
Con l’AI, cosa resta da fare
Tra slow work e bullshit jobs, imparare a usare la tecnologia per sottrarre, non per aggiungere
Ricordo che all’esame di maturità mi trovai stupito nel riuscire a collegare due argomenti apparentemente diversi tra loro, insegnati in due materie distinte. “La cultura funziona così”, mi disse uno dei professori. Evidentemente per lui era la norma, per me un fortuito inciampo di percorso.
Ne ho discusso con l’IA, e siamo arrivati a concludere che: “la cultura è la capacità di intrecciare conoscenze e esperienze, riconoscendo schemi e discontinuità, nel tempo e nello spazio, per attribuire loro significato e trasmetterlo agli altri.” Quindi anche le materie STEM, anche se in Italia talvota sembra strano.
Detto questo, qualcosa come l’epifania di Maturità è accaduta qualche giorno fa: leggendo un libro su tutt’altro argomento [“How to Change Your Mind”, di Michael Pollan] ho scoperto un naturalista, esploratore, geografo e botanico tedesco (queste sì che erano professioni invidiabili) vissuto tra fine ‘700 e inizio ‘800: Alexander von Humboldt. Il Dott. von Humboldt, grazie anche un altrettanto invidiabile frequentazione con Goethe, aveva una mente ampia e curiosa: smise di guardare il mondo come un catalogo di oggetti e sentenziò che “tutto è interazione e reciprocità”. E si alzò da tavola.
Allo stesso modo, la trasformazione digitale fallisce quando la trattiamo come un elenco della spesa — un ERP, un po’ di cloud, una spruzzata d’AI — e improvvisamente riesce quando la pensiamo come un processo in continuo divenire, multifattoriale e interdipendente tra diversi elementi.
Questo rende tutto più faticoso, ma sfortunatamente è la logica dei sistemi complessi: l’insieme fa cose che le singole parti non possono fare. Negli ultimi anni, una parte della letteratura manageriale ha provato a dirlo con altre parole: serve un digital mindset. Significa allenare persone e organizzazioni a vedere come dati e algoritmi aprono possibilità, a riconoscere pattern e dipendenze, a immaginare processi diversi prima ancora di installare l’ennesima piattaforma. Non basta “saper usare” un software: bisogna capire come quel software cambia il modo in cui prendiamo decisioni, collaboriamo, misuriamo.
Questo cambio di prospettiva si porta dietro un fatto spesso sottovalutato: tecnologie e competenze co-evolvono. Le prime chiedono skill nuove; le seconde abilitano combinazioni tecnologiche che ieri non erano possibili.
La ricerca empirica degli ultimi anni conferma l’intuizione. Le imprese che riescono davvero a introdurre robotica, IoT, analisi avanzata dei dati, non sono quelle che comprano più giocattoli digitali, ma quelle che li accoppiano con le competenze giuste. Le cosiddette tecnologie abilitanti — gestionali integrati, infrastrutture cloud, sicurezza, piattaforme dati — producono il massimo effetto quando camminano insieme a data engineering, analytics, integrazione applicativa, MLOps[1], e a quella che chiamavamo “vecchia” competenza di dominio: banalmente, sapere come funziona un’officina, una catena del valore, un reparto acquisti.
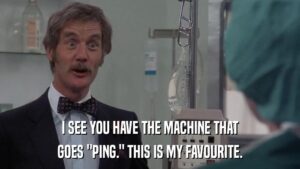
Che altro aggiungere. Da loro deriva pure il nome Phyton per il linguaggio di programmazione.
La leva, dunque, è nella reciprocità. Oppure, a voler essere di moda: “ecosistema”.
Una parola spremuta fino all’ultima sillaba, abusata come un concetto usa e getta, presa in prestito senza mai essere restituita, sequestrata e costretta a fare il lavoro sporco di qualsiasi discorso. Una parola che, se fosse capitata sotto lo sguardo di Umberto Eco, non avrebbe potuto che ricordare:
“Evitate le parole troppo generiche. Più una parola è astratta, più è facile che venga usata a sproposito.”
Ma che cosa intendiamo davvero con “ecosistema”? Un po’ di tutto, ma soprattutto un campo di forze in coevoluzione: università e centri di ricerca generano conoscenza e formano talenti, le imprese la trasformano in soluzioni, le istituzioni tracciano regole e incentivi, mentre cittadini e utenti contribuiscono con bisogni, dati e pratiche d’uso alla creazione di valore.
È la cosiddetta quadrupla elica dell’innovazione: un modello elegante sulla carta, che però segmenta eccessivamente i ruoli. In realtà le imprese producono a loro volta conoscenza, università e centri di ricerca non si fermano ai primi livelli di maturità tecnologica, le istituzioni sconfinano e i cittadini non sono solo consumatori ma anche produttori attivi di valore.
Tornando al tema e rimanendo sui prestiti a fondo perduto, prima di ecosistema si era fatta strada, negli anni 70-80[2], la nozione di “ecologia organizzativa”. In sintesi, nessun uomo è un’isola e neanche nessuna organizzazione.
Il punto è quindi far dialogare ciò che già esiste, ricreare una logica di scambio anche a livello intra aziendale. Mettere ordine nei sistemi operativi, costruire basi dati solide, dare strumenti alle persone, e soprattutto coltivare una mentalità digitale che permetta di usare i dati in modo consapevole.
Ciò da cui dobbiamo allontanarci è infatti la dispersione digitale. Troppi sistemi, troppi silos. Secondo Salesforce una grande organizzazione usa in media più di 900 applicazioni, ma meno di un terzo dialoga tra loro. Una frammentazione che rende difficile ogni trasformazione reale. Nel management è tutto un KPI: ci affanniamo a raggiungerli ma discutiamo poco su come definirli.
È un po’ come ricorda l’Oracolo in Matrix: non è la risposta che conta, ma la domanda.
Se la domanda è “quanti software abbiamo installato?”, la risposta serve a poco. Se invece chiediamo “quanto tempo ci mettiamo a portare in produzione una nuova funzione?”, allora i numeri iniziano ad avere senso.
Ecco gli indicatori che valgono: quante integrazioni stabili esistono tra sistemi, quanto riuso facciamo di dati e componenti, quanto tempo serve per rendere operativa una nuova funzione, quante persone fuori dall’IT hanno competenze digitali certificate e le applicano davvero, quanti progetti attraversano confini interni ed esterni alla filiera.
E qui il discorso torna al lavoro, che è poi il terreno dove tutte queste trasformazioni si depositano. Recentemente due libri hanno arricchito il dibattito sul lavoro e sulla produttività: Slow Productivity di Cal Newport e Bullshit Jobs di David Graeber. Diversissimi per stile e formazione — il primo informatico e divulgatore, il secondo antropologo — partono entrambi da una constatazione semplice: gran parte del lavoro contemporaneo è diventato disfunzionale rispetto allo scopo che dichiara di avere.
Newport invita a ricalibrare il concetto stesso di produttività. Dopo anni di culto dell’efficienza e dell’ottimizzazione continua, propone di rallentare non per fare meno, ma per fare meglio. “Slow” non è sinonimo di pigro: è un modo per riconnettere il tempo, l’attenzione e la qualità del risultato. In sostanza, suggerisce di misurare il valore del lavoro non dal numero di task completati, ma dal peso cognitivo e creativo delle attività che scegliamo di portare avanti.
Davanti all’avanzata dell’intelligenza artificiale, questo punto diventa cruciale. La domanda non è più quanto possiamo produrre, ma che cosa ha ancora senso fare noi. Ciò che l’IA esegue più rapidamente non va difeso per orgoglio, ma liberato per intelligenza: sono spazi da restituire al pensiero umano, non da proteggere con trincee burocratiche. La vera competenza — digitale e non solo — è la capacità di distinguere ciò che va automatizzato da ciò che merita il nostro tempo.
Qui entra in gioco anche Graeber. Nel suo Bullshit Jobs, basato su migliaia di testimonianze, descrive quella che chiama la “psicopatia morale del lavoro moderno”: professioni e attività che non servono a nulla, se non a mantenere l’illusione di essere occupati. Mansioni di controllo, reporting, riunioni senza scopo, catene di email che si alimentano da sole: un gigantesco spreco di energia cognitiva e relazionale.
Se incrociamo Newport e Graeber, ne viene fuori un messaggio utile anche per la trasformazione digitale. Le competenze digitali non servono solo a usare nuovi strumenti, ma a rileggere criticamente il lavoro. Sono ciò che ci permette di capire cosa tenere e cosa automatizzare, dove l’intervento umano è insostituibile e dove invece la macchina può amplificare il risultato. È un cambio di postura: dalla difesa del ruolo alla progettazione del senso.
In un’organizzazione matura, questo significa saper distinguere i “compiti vivi” da quelli “morti”. I primi generano conoscenza, relazione, valore. I secondi sono residui: si ripetono per inerzia, solo perché “si è sempre fatto così”. L’intelligenza artificiale, in questo quadro, non è un pericolo ma uno specchio: ci costringe a chiederci perché facciamo ciò che facciamo.
E non è un caso se anche l’OCSE sembra andare nella stessa direzione, come emerge da recente paper “Advancing the measurement of investments in artificial intelligence“. Una delle novità più interessanti del nuovo quadro è che le competenze vengono considerate un investimento, non più una semplice voce di spesa. Con la revisione dei conti nazionali (System of National Accounts 2025), l’intelligenza artificiale è riconosciuta come un vero e proprio bene produttivo immateriale: non conta solo il software o la potenza di calcolo, ma anche il sapere delle persone che li progettano, li gestiscono e li applicano. In questa prospettiva, la formazione – accademica, professionale o aziendale – entra a pieno titolo nel perimetro degli investimenti in IA.
L’OCSE e la Commissione europea hanno da qui definito una metodologia che quantifica il valore economico della conoscenza legata all’intelligenza artificiale, combinando tre componenti principali: docenza e ricerca universitaria, specialisti ICT e formazione aziendale, ognuna pesata da un coefficiente di intensità IA. Nel vecchio sistema (SNA 2008) queste voci erano considerate spesa corrente. Oggi, invece, vengono riconosciute come capitale produttivo, al pari dei software o dei macchinari.
In termini assoluti, l’investimento complessivo del Paese è stimato tra 13 e 15 miliardi di euro, di cui oltre i due terzi provenienti dal settore privato. È una strategia ancora in transizione, ma che punta con decisione sul capitale umano come leva per la diffusione dell’IA nella manifattura, nella sanità digitale e nella formazione finanziata. Nel caso italiano, questo aspetto è particolarmente evidente, ma non è tutto oro quello che luccica. Secondo le stime OCSE, circa il 40% degli investimenti legati all’IA nel nostro Paese riguarda le competenze, più della quota destinata alla ricerca e sviluppo. Potremmo concludere che l’Italia sta investendo soprattutto nelle persone, nel tentativo di colmare un divario storico tra capacità tecnologiche e uso effettivo delle tecnologie, ma forse le percentuali ci raccontano anche un’altra realtà: non è l’investimento in capitale umano a essere alto, è quello nelle altre voci considerate a non essere ancora sufficiente.
In ogni caso, a livello internazionale si tratta di un passaggio che va ben oltre la contabilità. Misurare il capitale umano come infrastruttura produttiva significa riaffermare che senza competenze diffuse l’innovazione non si propaga. Tecnologia e competenze coevolvono – come avrebbe intuito Humboldt – e la cultura, intesa come capacità di collegare, riconoscere schemi e costruire relazioni, resta la condizione per tornare a creare valore attraverso la qualità, non soltanto la quantità.
È una lezione importante, che ci obbliga a chiederci se stiamo facendo abbastanza per formare chi lavora oggi e chi sta per entrare nel mercato, e che riaccende il dibattito su ciò che davvero incide sulla produttività. Ma, soprattutto, ci impone di ripensare le organizzazioni come in trasloco: da un modello analogico a uno data-driven, supportato dall’intelligenza artificiale.
Un trasloco che richiede di svuotare tutto, mettere sul tavolo processi e abitudini, e scegliere cosa tenere e cosa si è accumulato per inerzia (anche a livello di task). Poi chiedersi cosa genera davvero valore e cosa può essere automatizzato per liberare tempo e creatività. Infine, difendere la parte umana dal rumore di fondo: quella proliferazione di attività accessorie a basso valore aggiunto che riempiono le giornate ma compromettono la qualità.
—————
[1] raccolta e preparazione dei dati; addestramento e validazione dei modelli; messa in produzione del modello; monitoraggio delle prestazioni e aggiornamento continuo
[2] Organizational Ecology di Michael Hannan e John Freeman




Devi fare login per commentare
Accedi