
Italia
Non hanno bisogno di riti. Hanno bisogno di adulti
La crisi dell’adolescenza non è psicologica. È simbolica. E siamo noi a non volerli più chiamare per nome.
C’era un’epoca in cui si diventava grandi. Era scritta nei gesti. Nelle ferite. Si passava da un corpo a un altro, da una casa a un’altra, da un nome all’altro. C’era il servizio militare, il matrimonio, il lavoro. Non perché fossero strumenti perfetti, ma perché erano luoghi in cui il mondo degli adulti chiamava, esigeva, riconosceva. Oggi non più. Oggi ci chiediamo perché i ragazzi non crescano. Ma forse dovremmo chiederci se siamo ancora capaci di accompagnarli davvero. Di reggere il peso di una transizione. Di sostenere una separazione.
La psicologia ha parole eleganti per descrivere il disagio. Parla di crisi dell’identità. Di distacco dai riti. Di carenze strutturali. Ma davvero è questo il punto? Davvero basta indicare la leva militare o l’altare come rimedi mancati? Non è più onesto dire che abbiamo smesso di desiderarli adulti? Che li vogliamo eternamente accompagnabili, eternamente da comprendere, eternamente in divenire? Chi osa più chiedere qualcosa a un adolescente? Chi osa dire: “ora tocca a te”? Chi rischia una parola definitiva?
Forse i riti non sono scomparsi. Forse sono cambiati. Solo che non li sappiamo più vedere. Ci ostiniamo a cercare le vecchie forme, senza accorgerci che si stanno già inventando altri passaggi, altre prove. Ma se non li riconosciamo, se non li onoriamo, quei gesti restano muti. E chi li compie, resta solo. Nessun adulto pronto a custodirli. Nessun volto pronto a nominarli. Nessun racconto che tenga insieme la frattura.
Abbiamo ridotto tutto a supporto. Sostegno. Ascolto. Ma ascoltare non basta. Capire non basta. Un figlio non ha bisogno solo di essere compreso. Ha bisogno di essere convocato. Di essere chiamato per nome. Ha bisogno di adulti che non siano solo rifugi, ma direzione. Che non offrano solo sicurezza, ma anche tensione. Che non coprano l’insicurezza con strategie educative, ma la espongano a un senso più alto del vivere.
Non basta dire che i giovani sono fragili. Sono fragili anche perché nessuno li interroga più davvero. Nessuno pretende da loro una forma. Un tempo. Un destino. Li riempiamo di progetti, di stimoli, di offerte. Ma non li attraversiamo. Non li mettiamo di fronte a un’attesa che li superi. A un rischio che li trasformi.
La psicologia può molto, ma non può tutto. Può accompagnare, ma non può sostituire il gesto simbolico. Può leggere, ma non può decidere chi siamo. E forse proprio qui sta l’inganno più grande: pensare che basti un contesto positivo per crescere. Che basti il benessere per diventare sé stessi. Che basti il consenso per generare un’identità.
Ma chi diventa adulto lo fa anche per mancanza. Anche per ferita. Anche per separazione. Nessuna crescita è indolore. Nessuna identità nasce senza attrito. Per questo servono adulti. Non solo genitori. Non solo educatori. Ma adulti che reggano lo sguardo. Che non si proteggano dietro il rispetto. Che non si scusino per esistere. Che dicano: “Io ci sono. Ma non ti seguirò ovunque. Ti aspetterò oltre.”
È davvero colpa loro se restano fermi? O siamo noi che abbiamo tolto ogni direzione e ogni meta? Siamo ancora capaci di essere riferimento? O siamo diventati solo spettatori gentili del loro smarrimento?


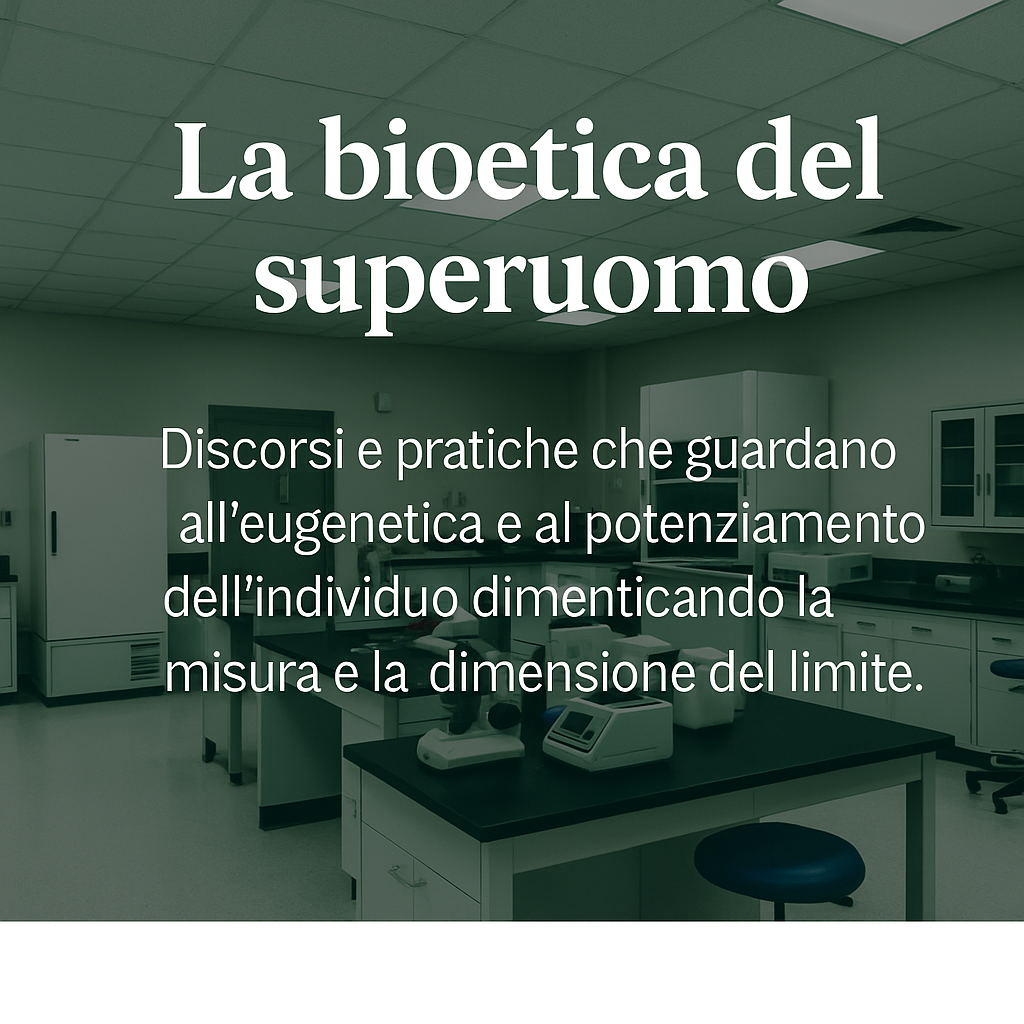


Devi fare login per commentare
Accedi