
Filosofia
Filosofia di coppia sui ruoli di genere
Una conversazione sul femminismo, tenuta cinquant’anni fa tra Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir, che ancora oggi offre stimoli di riflessione.
Un piccolo libro che in Italia ha conosciuto diverse edizioni a partire dal 1976, e ora viene ripreso da Il Saggiatore, questo Simone de Beauvoir interroga Sartre sul femminismo: testo che ancora oggi ha qualcosa da dire, non solo sulla più nota coppia di filosofi francesi, ma anche su quanto è (e non è) cambiato nella percezione dei diversi ruoli sessuali nella società occidentale dal dopoguerra a oggi. All’epoca di questa pubblicazione, i due grandi intellettuali avevano già scritto singolarmente opere di rilevante spessore letterario e filosofico, che li avevano resi famosi a livello mondiale: romanzi, racconti, saggi, pièce teatrali, ma anche numerosi pamphlet di critica sociale e politica, di notevole impatto provocatorio sull’opinione pubblica (Sartre: Abbiamo ragione a rivoltarci, De Beauvoir: Bruciare Sade?, Brigitte Bardot e la sindrome di Lolita).
Per la prima volta decidono nel 1975 di confrontarsi pubblicamente in una conversazione riguardante la condizione della donna, il femminismo, il patriarcato, sviscerando atteggiamenti e convinzioni personali sull’argomento. Ne deriva uno stimolante colloquio, in cui Simone De Beauvoir riassume il proprio percorso di emancipazione da retaggi culturali sedimentati nei secoli, ed elenca le sfide che attendono l’universo femminile per liberarsi da tali vincoli, incalzando il compagno – sodale di studi e conquiste intellettuali -, sulle sue riluttanze rispetto ai cambiamenti ideologici e comportamentali in atto nella società. L’intervista si dipana tra i due (che si danno del “lei”, come sembra facessero anche in privato), manifestando un corretto e obiettivo controllo della reciproca individualità. Beauvoir conferma di esser sempre stata incoraggiata da Sartre nelle sue ricerche e pubblicazioni, ad esempio dopo l’uscita del rivoluzionario “Il secondo sesso”, contestato invece da illuminati pensatori di sinistra, come Camus. Entrambi concordano di aver mantenuto negli anni un rapporto di assoluta parità e uguaglianza.
Con sincerità Sartre ammette di non aver mai preso ufficialmente un’esplicita posizione relativamente all’oppressione esercitata dagli uomini sulle donne, perché cresciuto ed educato in un ambiente femminile, in cui certamente avvertiva la violenza della supremazia patriarcale e la subordinazione del ruolo della donna, ritenendoli tuttavia prodotti da una naturale insensibilità maschile e da una passiva accettazione femminile, tratti più caratteriali che culturali. Non ne era insomma scandalizzato, nella stessa misura in cui invece lo turbava lo sfruttamento padronale e imperialistico nei confronti delle classi subalterne e di etnie diverse. A Sartre, uomo nato a Parigi nel 1905, pareva quindi naturale un certo atteggiamento di superiorità sia verso le donne, sia verso molti uomini ritenuti non al suo livello intellettuale, ma mitigava tale presuntuosa affermazione confessando di sentirsi più a proprio agio e meno competitivo nella conversazione informali con le signore piuttosto che in quelle professionali e competitive con i maschi. Titubante appare comunque la posizione sartriana su come collegare la lotta di classe alla lotta della liberazione delle donne, giustificata dalla convinzione che può esistere complicità tra donne appartenenti a classi differenti, mentre la contrapposizione tra datore di lavoro e subalterno è sempre totale. In una visione prettamente maschilista, Sartre considera la donna borghese solo in quanto sposata con un uomo appartenente alla borghesia, e del tutto disposta ad assumerne i valori, il prestigio e i privilegi economici: “Una borghese non ha mai quel rapporto con la vita economica e sociale che ha l’uomo … è molto di rado in rapporto con il capitale. È legata sessualmente a un uomo che ha questi rapporti”. Considera comunque la lotta di liberazione delle donne come necessaria e primaria, perché esse si possano svincolare dal giogo dell’oppressione maschile, con gli stessi diritti di accedere a posizioni d’élite e dirigenziali nella scala sociale.
Il quesito finale posto dalla De Baeauvoir rimane tutt’oggi non del tutto risolto: “Le donne devono rifiutare interamente l’universo maschile o aprirsi un varco in esso? Devono appropriarsi dello strumento oppure cambiarlo? Intendo la scienza, come il linguaggio, come l’arte. Tutti i valori portano il marchio della mascolinità. Bisogna per questo rifiutarli completamente e tentare di reinventare un’altra cosa, radicalmente, partendo da zero? Oppure bisogna assimilare questi valori, impadronirsene, servirsene, per fini femministi? Cosa ne pensa?” Diplomaticamente, Sartre risponde che l’avanzare delle rivendicazioni femministe, la liberalizzazione dei costumi, il progresso delle conquiste mediche e scientifiche giocheranno in favore delle donne. “L’uomo medio si scontra con delle condizioni esterne che lo rendono propriamente comico… Più facilmente vittima d’inganno e più facilmente comico. La società degli uomini è una società comica… La donna, in quanto oppressa, è in un certo senso quasi più libera dell’uomo. Ha un numero minore di principi che le dettano la sua condotta. È più irriguardosa”. Pronunciate cinquant’anni fa da uno dei maggiori filosofi del ’900, queste parole suonano quasi come un complimento.
DE BEAUVOIR SARTRE, SIMONE DE BEAUVOIR INTERROGA SARTRE SUL FEMMINISMO
IL SAGGIATORE, MILANO 2025
Traduzione di Mara Cantoni e Massimo Gallerani. Pagine 50


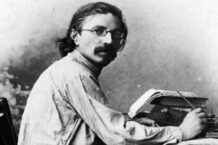

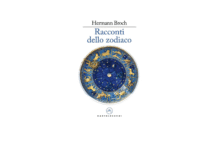
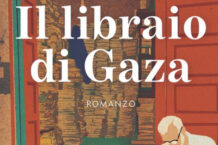
Veramente impressionante l’attualità delle parole di Sartre! Ma più che alla sua lucidità – straordinaria – mi fa pensare all’incapacità della società occidentale (delle altre non ho esperienza, e so quello che leggo) di superare oggi le proprie contraddizioni, se da quasi un secolo non ci siamo riusciti. L’Occidente nei secoli, insieme alla brutalità del dominio ha però sviluppato anche una grande capacità di autoanalisi e di autocritica, che l’ha condotta, sul piano delle relazioni civili, a un indubbio progresso, a una relativa equiparazione delle disuguaglianze. Sui rapporti di genere sembra che non ci riesca. Come se modificare gli attuali rapporti facesse crollare per alcuni, moltissimi, sembra, la solidità e la solidarietà sociale. Perché? Temo che il “maschio” abbia paura di perdere i propri punti di riferimento, lo stesso concetto di giustizia lo sentirebbe stravolto. Peggio per lui, perché se rileggesse, per esempio, la storia della poesia da Saffo a oggi, capirebbe che se mai la differenza tra la visione sociale dell’uomo e quella della donna è che la prima è escludente la seconda inclusiva. Alle donne ciò è sempre apparso chiaro, mi sembra. Perfino a una poetessa bizantina del IX secolo, Cassìa, che in una sua poesia famosa contrappone appunto la propria visione sociale a quella corrente, che naturalmente è maschile: “odio il silenzio quando è il momento di parlare”.