
Energia
Enrico Mattei e l’Italia che non ha mai raggiunto la sovranità energetica
Enrico Mattei, figura centrale dell’Italia del dopoguerra, rappresenta ancora oggi un simbolo di ambizione nazionale e lungimiranza strategica. Nato a Acqualagna nel 1906, attraversò il fascismo e la guerra, per poi emergere come uomo chiave nella ricostruzione italiana. La sua visione era chiara e determinata: garantire all’Italia una vera autonomia energetica, un obiettivo che andava oltre la semplice gestione delle risorse. Mattei voleva che il Paese potesse contare sulle proprie forze e sulle proprie decisioni nella complessa arena geopolitica internazionale.
Quando assunse la guida dell’ENI nel 1953, il settore energetico italiano era frammentato e fortemente dipendente dalle compagnie straniere, in particolare quelle anglo-americane, che detenevano il controllo quasi esclusivo delle forniture di petrolio. La sua intuizione fu radicale: l’Italia doveva smettere di essere un cliente passivo e iniziare a costruire relazioni paritarie con i paesi produttori, sfruttando accordi reciprocamente vantaggiosi e rispettosi della sovranità locale. Mattei non si limitava a importare petrolio; mirava a diventare un interlocutore credibile per i governi dei paesi esportatori, sostenendo progetti di sviluppo locale e garantendo contratti equilibrati.
Questa politica innovativa, conosciuta come “riscatto nazionale delle risorse”, sfidava apertamente le grandi compagnie petrolifere internazionali. Mattei stipulava accordi che assicuravano all’Italia prezzi competitivi, ma soprattutto creavano un rapporto di fiducia con i produttori. L’ENI, sotto la sua guida, investiva in infrastrutture, impianti di raffinazione e prospezione, diventando non solo un importatore di petrolio, ma anche un attore globale in grado di influenzare mercati e strategie energetiche. L’obiettivo era chiaro: non subire le oscillazioni dei prezzi internazionali, ma avere voce in capitolo sulle decisioni che riguardavano la disponibilità di risorse critiche per l’economia italiana.
Mattei ottenne ciò che pochi Paesi europei avevano raggiunto: rapporti diretti e paritari con nazioni ricche di petrolio come l’Algeria, l’Iran e molti stati del Medio Oriente e del Nord Africa. Questi accordi permisero all’Italia di diversificare le fonti di approvvigionamento, riducendo la dipendenza dai tradizionali attori occidentali e consolidando un ruolo internazionale che era fino a quel momento impensabile per un Paese che aveva appena superato le devastazioni della guerra. La strategia non si limitava a un vantaggio economico immediato; era un vero progetto di sovranità energetica, una mossa strategica che puntava a dare all’Italia un margine di manovra nelle scelte politiche ed economiche, sia interne sia internazionali.
Il coraggio di Mattei si manifestava anche nella gestione del rischio politico: affrontava governi instabili e scenari geopolitici complessi pur di garantire approvvigionamenti sicuri. Non temeva di negoziare con Paesi considerati “problematici” dall’Occidente, come dimostra il suo rapporto con l’Algeria durante la guerra d’indipendenza, quando molti stati europei restavano neutrali o guardavano con sospetto le nuove leadership locali. Mattei capiva che la stabilità energetica italiana dipendeva da relazioni solide e lungimiranti, non da un semplice rispetto delle regole del mercato globale.
Inoltre, aveva una chiara visione di lungo periodo: investiva nella ricerca, nella tecnologia e nella formazione del personale, credendo che un’Italia indipendente non potesse basarsi solo sull’acquisto di risorse estere, ma dovesse sviluppare capacità proprie di esplorazione, estrazione e raffinazione. In questo senso, la sua leadership segnò un cambio di paradigma: l’energia non era solo un bene economico, ma uno strumento di politica nazionale e di prestigio internazionale.
L’eredità di Mattei rimane oggi estremamente significativa se si considera il contesto attuale. L’Italia, nonostante la modernizzazione del settore energetico e l’inserimento in reti europee integrate, resta fortemente dipendente dall’estero per oltre il 75% del suo fabbisogno energetico. Gran parte del gas naturale proviene dall’Algeria e dall’Azerbaijan, mentre la Russia continua a influenzare indirettamente il mercato italiano tramite forniture di GNL (gas naturale liquefatto). In altre parole, la visione di autonomia e indipendenza energetica perseguita da Mattei resta in gran parte un obiettivo non raggiunto, ma ancora oggi un riferimento strategico per chi vuole discutere di politica industriale, sicurezza nazionale e geopolitica energetica.
La situazione attuale dimostra quanto sia complesso mantenere la sovranità energetica in un mondo globalizzato. L’Italia importa energia da diverse aree geografiche, ciascuna con proprie criticità politiche e geostrategiche:
- Algeria: principale fornitore di gas naturale, con il quale l’Italia ha stipulato contratti pluriennali di fornitura tramite gasdotti come il Transmed. Nonostante la stabilità relativa negli ultimi anni, tensioni politiche interne o regionali possono avere impatti diretti sulle forniture.
- Azerbaijan: fornitore attraverso il TAP (Trans Adriatic Pipeline), che collega il gas del Mar Caspio ai mercati europei. La pipeline rappresenta un’alternativa strategica rispetto al gas russo, ma il volume rimane limitato rispetto al fabbisogno nazionale.
- Russia: anche se l’Italia ha ridotto drasticamente le importazioni dirette di gas, la dipendenza indiretta persiste. Il GNL importato dai terminali italiani spesso proviene da Paesi che a loro volta dipendono dalla Russia, rendendo la catena delle forniture vulnerabile a crisi geopolitiche e tensioni economiche.
In sostanza, rispetto all’epoca di Mattei, l’Italia non ha più una vera autonomia energetica: non controlla direttamente le fonti né può trattare con pari forza geopolitica con i Paesi produttori.
Oltre alla dipendenza dall’estero, il Paese deve affrontare la transizione energetica. Il Green Deal europeo impone una riduzione rapida delle emissioni e una maggiore quota di fonti rinnovabili, ma queste da sole non bastano a sostituire gas e petrolio, soprattutto nei settori industriali pesanti e nella produzione elettrica durante l’inverno. La questione è complessa: puntare solo sulle rinnovabili senza un adeguato mix energetico rischia di creare instabilità, mentre continuare a importare risorse estere perpetua la dipendenza e la vulnerabilità strategica.
Mattei avrebbe probabilmente guardato a questa situazione con la sua tipica lungimiranza: cercare alternative, investire in infrastrutture e tecnologia, negoziare accordi strategici. Ma la realtà odierna è più complessa: l’Italia è parte di un mercato comune europeo, con vincoli regolatori, obiettivi climatici, e una crescente competizione internazionale per le risorse critiche come litio, nichel e terre rare, fondamentali per la produzione di batterie e impianti rinnovabili.
La dipendenza energetica si traduce in rischi economici e politici. Prezzi elevati del gas o del petrolio non colpiscono solo le famiglie e le imprese, ma influenzano la bilancia commerciale e la stabilità macroeconomica del Paese. Inoltre, la vulnerabilità alle crisi internazionali significa che l’Italia deve spesso conformarsi alle scelte dei grandi fornitori o dell’Unione Europea, limitando la libertà di manovra nella politica estera.
La storia di Mattei insegna che avere autonomia significa avere margini di scelta: potersi sedere al tavolo dei grandi senza subire imposizioni, creare relazioni paritarie con i produttori e investire in capacità proprie. Oggi l’Italia resta spesso spettatrice delle scelte altrui, con pochi strumenti per influenzare direttamente i mercati globali dell’energia.
Raggiungere una reale sovranità energetica oggi non è impossibile, ma richiede scelte coraggiose e lungimiranti, simili a quelle che Mattei seppe incarnare. La diversificazione delle fonti, gli investimenti nelle rinnovabili, l’uso strategico di GNL da paesi affidabili e la costruzione di capacità nazionali di stoccaggio e produzione sono passaggi fondamentali. Parallelamente, l’Italia dovrebbe sviluppare una politica estera energetica coerente, capace di negoziare rapporti bilaterali senza subire il ricatto dei mercati globali. Inoltre, la sovranità energetica non riguarda solo il gas e il petrolio: include anche le risorse minerarie critiche, le tecnologie per la transizione verde e la capacità di innovazione industriale. Un Paese che voglia contare sulla scena internazionale non può permettersi di essere passivo; deve anticipare scenari, investire e costruire infrastrutture resilienti.
Enrico Mattei rimane un simbolo di coraggio, visione e pragmatismo strategico. La sua eredità non è soltanto storica, ma un monito per le politiche energetiche contemporanee: l’Italia può e deve imparare dalla sua visione per ridurre la dipendenza dall’estero e aumentare la propria autonomia. Rileggendo la sua storia, appare evidente quanto l’Italia possa ancora aspirare a una vera sovranità energetica, e quanto questa rimanga un obiettivo ambizioso ma necessario per garantire sicurezza, stabilità e autonomia nazionale. Solo guardando al passato con occhi critici e lungimiranti possiamo capire quali strumenti adottare oggi per costruire un futuro energetico più sicuro, indipendente e strategicamente consapevole


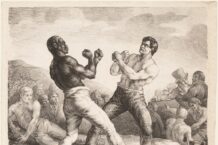


Devi fare login per commentare
Accedi