
Finanza
Generali non può diventare il feudo di due famiglie e di Palazzo Chigi
Caltagirone e Del Vecchio dominano Mps-Mediobanca, spalleggiati dal Tesoro, ma sul primo assicuratore del Paese serve un equilibrio più ampio e un contrappeso istituzionale credibile. Si prospetta un ruolo per Intesa Sanpoaolo?
Otto mesi di scalata e alla fine Banca Monte dei Paschi di Siena e i suoi grandi azionisti si sono presi tutto. Lunedì scorso, ultimo giorno utile per aderire alla seconda e ultima fase dell’offerta, l’istituto senese ha ottenuto l’adesione complessiva dell’88,3% del capitale di Mediobanca. Un trionfo che supera le attese, segna la fine della storica indipendenza di Piazzetta Cuccia, fa emergere nuovi azionisti di riferimento per le Assicurazioni Generali. Per inciso, permette al Governo Meloni di rimettere piede, sia pure per interposta banca, nei sacri palazzi della finanza italiana, dopo le privatizzazioni degli anni ’90.
Dietro la manovra, un fronte compatto: l’imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone, il cui impero ai tempi della crisi Mps appariva in affanno mentre oggi è in splendida forma, la Delfin della famiglia Del Vecchio, che dopo decenni di impegno industriale puro con Luxottica, è ormai una stabile presenza nella grande finanza italiana, Banco Bpm e – in posizione tutt’altro che defilata – il Governo Meloni, appunto. L’obiettivo ultimo non era Mediobanca ma pacchetto del 13% delle Generali che Mediobanca custodisce da oltre mezzo secolo, bastato finora a esercitare un controllo di fatto sulla compagnia triestina, che oggi raccoglie circa 100 miliardi di euro all’anno e gestisce masse per 1.000 miliardi.
Il mito di Mediobanca come salotto buono del capitalismo italiano era svanito da tempo, il suo ruolo di stanza di compensazione di capitali e poteri dissolto. Dopo la liquidazione del gruppo Ligresti e la nascita di UnipolSai, ultima grande operazione di riassetto gestita secondo le regole dell’ancien regime, la banca di Piazzetta Cuccia ha imboccato un lento declino: il patto di sindacato azionario si è assottigliato, l’influenza sulle grandi vicende finanziaria drasticamente si è ridimensionata al cospetto di giganti come Intesa Sanpaolo e Unicredit. La difesa a oltranza della storica posizione nelle Generali, la principale fonte di reddito, e l’impuntatura nel tenere lontani i nuovi arrivati Caltagirone e Del Vecchio si sono ritorte contro.
Sulla gestione del gruppo assicurativo si è consumata la rottura definitiva. Da un lato Alberto Nagel, amministratore delegato e proclamato erede della tradizione di Enrico Cuccia e Vincenzo Maranghi. Dall’altro gli scalatori: Caltagirone e la famiglia Del Vecchio. Entrambi sono azionisti forti di Mps, Mediobanca e Generali. Entrambi decisi a cambiare rotta, in questo spalleggiati dal governo Meloni. Ci aveva provato Fabrizio Palenzona, antico habitué del salotto di Mediobanca e già vicepresidente di Unicredit, a suggerire una pacificazione, utile a preservare l’autonomia dell’istituto, sul modello di quanto fece Maranghi, quando ne 2003 negoziò la pace con i grandi soci offrendo le proprie dimissioni, in cambio di garanzie per l’indipendenza delle Generali, di Mediobanca e del suo management. Uscì senza buonuscita, ma con piene garanzia l’autonomia del management. A beneficiarne furono proprio Nagel e Renato Pagliaro, promossi a vertici, e lì rimasti fino a oggi.
Ma Nagel non ne ha voluto sapere. Coltivava forse nella speranza di ricevere man forte dalla finanza francese che da sempre gira intorno a Generali e Mediobanca. Una scommessa ragionevole in altri momenti storici, ma un azzardo nell’Europa e nell’Italia di oggi. Ha alzato così le barricate, proponendo anche una controfferta alle Generali (il pacchetto azionario in cambio di Banca Generali), ed è finita come sappiamo.
Nella lettera d’addio, a margine delle dimissioni, Nagel ha evocato «la cultura identitaria fatta di competenza, passione, trasparenza e understatement» ricevuta in eredità da Cuccia e Maranghi. Parole commosse che non hanno rincuorato però dei dipendenti e soprattutto i principali banker e manager. A differenza di Maranghi, Nagel se ne va con le tasche piene di soldi ma senza avere negoziato alcuna garanzia per chi resta. Ha incassato finora almeno 53 milioni di euro (e non è tutto), lasciando dietro di sé incertezza e delusione. Dentro le mura di Piazzetta Cuccia molti sentono di essere stati lasciati soli, alla mercé dei nuovi padroni.
Ma la questione non è solo interna né solo finanziaria: è sistemica e politica. Entro il 3 ottobre vanno depositate le liste per il nuovo cda, che sarà votato nell’assemblea del 28. Si attende un nome esterno per la carica di amministratore delegato, ma non si esclude l’attuale direttore generale Francesco Saverio Vinci. I beninformati indicano Vittorio Grilli: ex ministro dell’Economia, oggi in Jp Morgan, che è stata advisor di Mps nella scalata. Ascoltatissimo a Via XX Settembre come tra grandi soci di Mps. Non è detto che sia lui il nuovo presidente di Mediobanca, ma certamente il suo parere pesa, e molto.
Il vero gioco, adesso, si sposta più a valle. A Trieste. Lì, l’amministratore delegato Philippe Donnet – chiamato dai vecchi vertici Mediobanca – dovrà confrontarsi con i nuovi azionisti di riferimento: Mps (13% via Cuccia), Caltagirone (6,2%), Delfin (10%) e una pattuglia di istituzionali con la stessa visione “sovranità” della compagnia. In linea con il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la premier Giorgia Meloni.
Il casus belli è noto: l’alleanza tra Generali e Natixis (appartenente al gruppo francese Bpce) nell’asset management, voluta da Donnet e Nagel, respinta dai nuovi soci e criticata dal governo. Da lì è partita la zampata su Mediobanca, all’inizio di quest’anno.
Ora, però, è tempo di mediazioni. Nicola Namias, amministratore delegato di Bpce, ne è consapevole: «Non firmiamo perché aspettiamo che la catena azionaria di Generali si stabilizzi. Speriamo che il governo comprenda la pertinenza del progetto». Tradotto: a questo punto nulla si decide senza l’ok Palazzo Chigi.
Il problema resta: oggi Generali è appesa a un equilibrio temporaneo. L’esito delle battaglie azionarie hanno creato incertezza strategica. Carlo Messina, a.d. di Intesa Sanpaolo, è stato esplicito: sul mercato si è creata, ha detto nel febbraio scorso, «una dinamica spesso caotica e confusionaria». A maggio, l’aveva ribadito ancora, aggiungendo: «Se Unicredit prova a scalare Generali, chiamo Andrea Orcel (a.d. di Unicredit, ndr) e gli dico di fermarsi».
Da allora, Unicredit ha ridotto la sua quota in Generali dal 6,49% al 2% di qualche giorno. Una curiosa consonanza tra i due massimi banchieri italiani. L’uscita di Unicredit alleggerisce la scena e sgombera il campo dall’ipotesi di un’alleanza tra Unicredit e il Leone, ma priva quest’ultimo di quello che molti vedevano come un contrappeso istituzionale nell’azionariato della compagnia, in grado di bilanciare il fronte composito dietro Mps, fatto di imprenditori e poteri pubblici.
Ed è qui che torna in gioco Intesa Sanpaolo. Prima banca italiana, principale finanziatrice delle scalate di Caltagirone, ha tutte le carte per giocare la funzione di socio finanziario stabile di garanzia a fronte di un piccolo pacchetto azionario. Caltagirone, che ha 82 anni e ha portato a casa una vittoria storica, potrebbe anche decidere di monetizzare parte delle plusvalenze, ridurre l’esposizione, accettare una presenza istituzionale altra da Mps a Trieste. Messina ne avrà voglia?
Uno scenario che, dicono i ben informati, non dispiacerebbe affatto a Meloni. Perché – ripete spesso Palenzona, «l’Italia, diceva Cuccia, può permettersi tutto, ma non di perdere Generali».


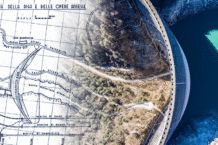

Devi fare login per commentare
Accedi