Letteratura
Azar Nafisi, la letteratura come resistenza
“Da anni vado ripetendo, – scrive Azar Nafisi nelle prime pagine di Leggere pericolosamente – che la struttura della buona narrativa si basa sulla pluralità delle voci, su una democrazia fatta di prospettive diverse in cui perfino il malvagio ha il diritto di parole, mentre la cattiva narrativa riduce tutte le voci a una, quella dello scrittore, che, come un dittatore, ingessa i suoi personaggi per far passare un unico messaggio e obiettivo: il proprio. Le grandi opere letterarie, veramente pericolose, mettono in discussione e smascherano questo impulso tirannico tanto sulla pagina, quanto nella pubblica arena” [p. 19].
Leggere pericolosamente è un dialogo che Azar Nafisi intesse in solitudine con il padre deceduto a cui racconta le sue incertezze, e soprattutto la metamorfosi di questo tempo, in cui il suo paese, l’Iran sprofonda nella crisi e, allo stesso tempo, quello che è il suo paese di adozione, gli Stati Uniti, le appare sempre di più una realtà che sta smarrendo se stessa. Azar Nafisi scrive questo libro nel tempo della Presidenza Trump e nei mesi della pandemia. L’Iran è lontano e in subbuglio. La sua vita quotidiana a Washington è percepita nella incertezza di un sistema politico che le ricorda molto il suo paese natale. Ancora una volta è la letteratura e la saggistica civile a aprire percorsi di riflessione e di risposta alle inquietudini del presente. I versetti satanici di Salman Rushdie, La prossima volta il fuoco di James Baldwin, A un cerbiatto somiglia il mio amore di David Grossman, Di fronte all’estremo, di Tzvetan Todorov, il saggio che con più chiarezza di tutti, a fine millennio ha posto il tema di quale morale dotarsi per affrontare le sfide del XXI secolo. Una morale il cui fine sia resistere per non cedere alle condizioni che i dispotismi stabiliscono per i propri sudditi.
Infatti, sostiene Todorov, se si hanno spazi di scelta allora è possibile dare ipotesi diverse e l’agire sarà in base a una scelta. Questa sarà allora da indagare nelle sue linee direttive. Scrive Todorov:
«Se ogni gesto dell’individuo è determinato dagli ordini dei superiori e dalla necessità di sopravvivere, la sua libertà cessa di esistere ed egli non può esercitare realmente la propria volontà per scegliere un certo comportamento invece di un altro. E dove non c’è scelta, non c’è nemmeno spazio per una qualsiasi vita morale» [p. 36]
Un testo, quello di Todorov, che non a caso è accompagnato da una lettura di sottofondo che accompagna anche il lettore italiano. È Il racconto dell’ancella di Margaret Atwood che Azar Nafisi, periodicamente torna a citare in dialogando immaginariamente con il padre, nello stesso momento in cui quel testo, uscito come libro nel 1985, inizia ad essere un serial di riferimento nel tempo dell’avvio della Presidenza Trump (in un tempo in cui razzismo e misoginia si incontrano). Se scrivere quel testo nel 1985 voleva dire provare a raccontare una scena del proprio tempo, con da un lato l’avvento degli ayatollah in Iran, con tutta la loro virulenta misoginia; e dall’altro l’ascesa della destra evangelica negli Usa, movimento oggi associato soprattutto alle lotte contro l’aborto e i matrimoni gay, proporlo nel 2017 come una storia televisiva (come non ha mancato di indicare Rebecca Mead su “The New Yorker”) probabilmente spiega molte cose non solo appunto di quel serial, ma anche di come e perché quel riferimento sia ricorrente nel testo di Azar Nafisi.
Anche per questo, forse il riferimento alla letteratura e alla pericolosità di leggere, non è né banale né posticcio. Quell’immagine ha, invece, un significato profondo, che forse col tempo avevamo dimenticato e che, invece e giustamente e opportunamente, Nafisi ci rammenta.
Azar Nafisi (ricalcando una osservazione che in condizioni di semiclandestinità aveva coniato Michail Bachtin nel tempo della Russia sovietica) la sfida della letteratura a contrapporsi al totalitarismo e agli autoritarismi è abbandonare la dimensione cdi catechismo e far respirare la parola. Per farlo in letteratura esiste un solo criterio, aprire alla dimensione del dialogo, laddove con questo termine si intenda praticare e proporre non tanto le buone maniere, ma la forza del confronto come pratica verbale che rende edotti sui contenuti e dunque consente di vivere la scelta.
La scelta è possibile solo laddove il conflitto è scoperto, laddove le pratiche che hanno il fascino del totalitarismo e per questo sono attratte da una sola verità – la propria – lasciano spazio al conflitto, arretrano rispetto al proprio progetto di dominio.
Azar Nafisi sa benissimo che quella pratica liberatoria della parola e del confronto nasce dall’avere la consapevolezza che il primo ostacolo da rimuovere e la prima difficoltà da affrontare non consiste nel sopraffare il nemico, ma nel confrontarsi con il proprio autoritarismo, comunque con i propri dogmi, perché, scrive “La mentalità totalitaria, sia in una teocrazia che in una democrazia è nemica della complessità e dell’ambiguità” [p. 152].
In breve, tanto in un regime totalitario, come in una condizione politica che presenta il totalitarismo come attraente o comunque affascinante o auspicabile per una porzione non irrilevante dell’opinione pubblica, è importante “non permettere alla brutalità o alla confisca delle libertà individuali di diventare una routine, una norma” [p. 142].
Ci riguarda?




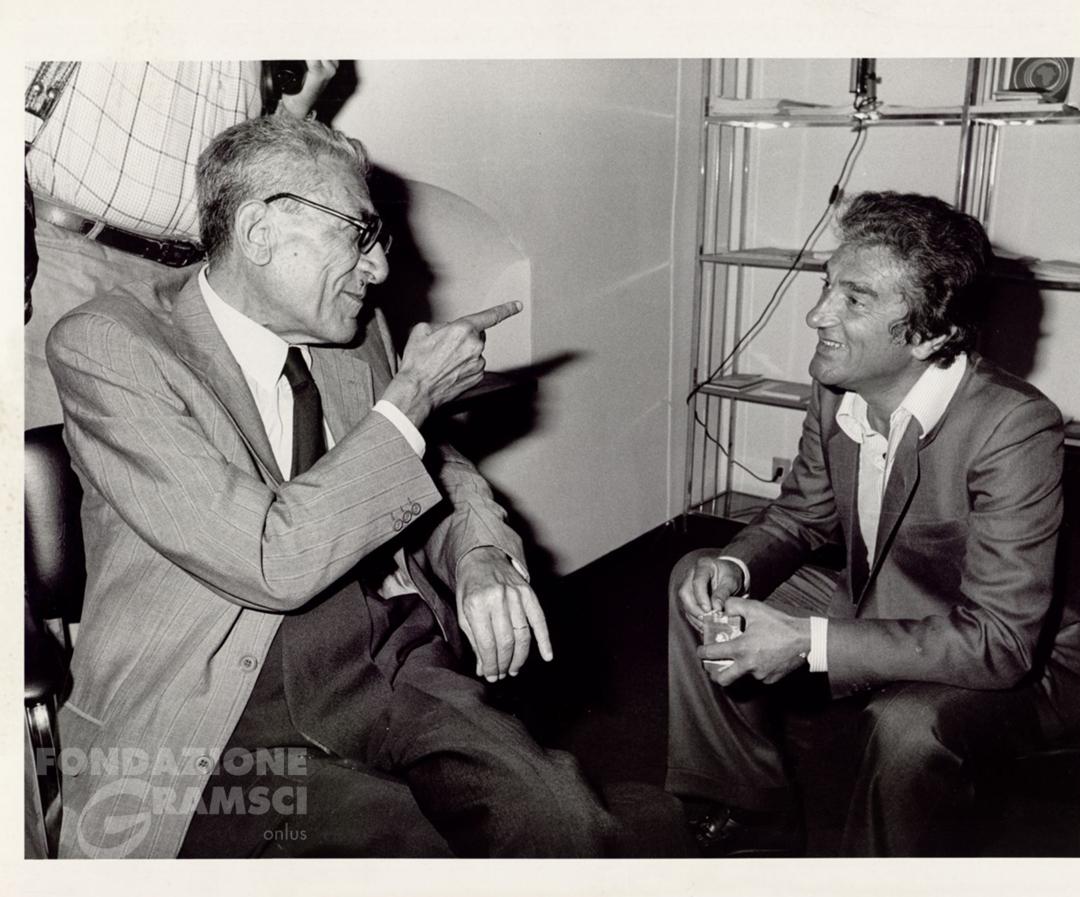
Devi fare login per commentare
Accedi