Moda & Design
La maledizione di Aiazzone: ecco perché Ikea non è italiana
In principio fu Aiazzone. “Provare per credere” furono le prime parole della televisione commerciale. Dieci anni prima che i mobili avessero un nome, in svedese, il tinello delle famiglie italiane era Aiazzone.
Venti anni prima che internet permettesse di comprare dal divano di casa e vendere in tutta Italia con un negozio in periferia, i camion con il marchio del mobilificio di Biella scaricavano in doppia fila nelle strade di Catania come in quelle di Pescara.
Il successo di Aiazzone fu così grande da generare l’ “effetto Aiazzone”: l’eccesso di campagna pubblicitaria produce disaffezione, rifiuto invece che fidelizzazione. Un messaggio troppo a lungo ripetuto non contribuisce a costruire l’identità, che in qualche modo deve essere lasciata libera di evolvere, ma finisce per sclerotizzare l’immagine di ciò che si vuol pubblicizzare, portando alla morte simbolica del marchio.
A cui si segui una morte reale. Il successo si infranse il 6 luglio 1986, quando Giorgio Aiazzone morì in un incidente aereo. L’azienda, orfana del suo fondatore, iniziò un lento declino. Altre aziende italiane hanno cercato di raccogliere l’eredità di Aiazzone, con risultati disastrosi. Emmelunga ha visto i clienti abbattere le porte dei negozi per impossessarsi dei mobili che avevano pagato prima che il dichiarato fallimento li rendesse indisponbili.
Mercatone Uno ha anche provato a ribellarsi ad un destino che sembrava scritto e nel 2013 aveva nominato Ceo, Luigi Bernasconi, che aveva fondato Mediaworld in Italia e l’aveva diretta per 20 anni.
Made.com, fondato da 3 francesi in Inghilterra ma di proprietà di RCS, che vende mobili di ispirazione scandinava (vedi sotto), sebbene colonizzi pagine internet e riviste di moda e di design, vende meno della merceria sotto casa mia.
Il primo pensiero è che la morte di Aiazzone abbia gettato una maledizione verso qualunque azienda italiana cerchi di ripeterne e superarne il successo. Non si spiega altrimenti il fatto che nessun distributore italiano riesca a capitalizzare uno dei maggiori componenti del Made in Italy: l’arredo e il design. La Lombardia e l’Italia sono state nella seconda metà del 900 per il Design mondiale ciò che la Toscana e l’Italia sono state per l’Arte a cavallo tra 400 e 500 del precedente millennio.
Qualcuno potrebbe storcere il naso e dire che il design italiano è caro. Certo il design può essere costoso, però un divano Coronado di 35 anni è comodo come il primo mese, un divano di certe catene dopo poche settimane invita a riscoprire il piacere arcaico di sedersi per terra. Ma può essere molto competitivo, come la Parentesi Flos.
Inoltre, bisogna considerare che l’Italia è ancora oggi uno dei maggiori produttori di mobili al mondo. Al punto da essere il terzo fornitore di mobili di Ikea, addirittura primo per le sue cucine. Se i mobilieri italiani possono produrre per Ikea e alimentarne il successo, perché altri siano falliti diventa ancora più misterioso.
Se c’è una cosa che accomuna la pretenziosa Emmelunga, l’economica Mercatone Uno e la nordica Made.com è l’aver ignorato quella tradizione di design che Ikea cerca di valorizzare, anche se maldestramente.
Il caso made.com è emblematico. RCS è riuscita a finanziare un e-commerce che vende mobili che scimmiottano la tradizione scandinava, quella dei primi mobili Ikea, tradizione da cui Ikea ha sempre cercato di affrancarsi, scimmiottando il design italiano per essere più internazionale. A spiegare il fatto che non ci sia un’Ikea italiana forse non è necessario ricorrere ad un maleficio ma a qualcosa di molto più italico: tafazzi.

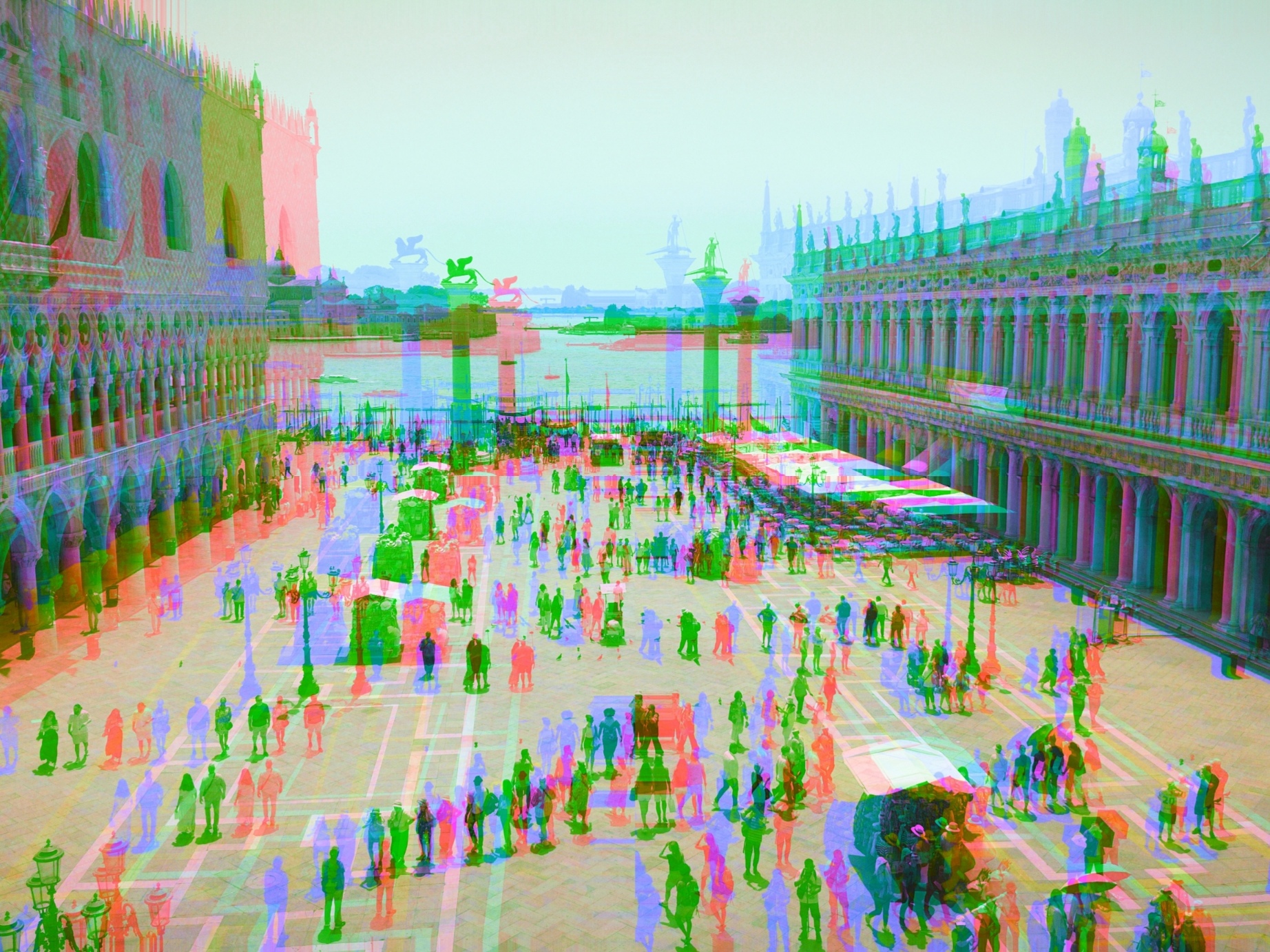


Devi fare login per commentare
Accedi