
La Posta del Cigno Nero
Il lato B di certe cose
Caro Cigno Nero,
tempo fa mi sono entrati i ladri in casa. Chiaramente è stato uno shock vedere la casa messa in subbuglio, e poi c’è la sensazione davvero spiacevole che ti assale al pensiero che degli estranei abbiamo messo le mani tra le tue cose, che abbiano violato lo spazio domestico che tutti vediamo e sentiamo come un rifugio, un luogo di storie, emozioni, dove la vita sembra in qualche modo protetta. Ma quello che mi ha portata ad una riflessione più profonda è stato quanto ho vissuto un paio di giorni dopo, raccontando dell’accaduto ai miei amici. Non mi ha colpito il fatto che il mio racconto sull’accaduto abbia suscitato, come credo sia normale, la domanda: “Ti hanno portato via qualcosa di valore?”, cui seguiva un elenco di oggetti come gioielli, televisore, computer e simili. Quello di cui mi sono stupita è stata l’improvvisa urgenza di nascondere ciò che ho fatto entrando in casa dopo il furto. A nessuno ho detto che dopo lo smarrimento iniziale e comprensibile sono corsa in camera da letto, mi sono fatta largo tra vestiti e oggetti sparsi ovunque e con il cuore in gola ho cercato la coperta, ormai consumata e scolorita dall’uso e dal tempo, che la mia nonna aveva confezionato per me, intrecciando fili attraverso un lavoro paziente, lento e pieno di significati. Un oggetto privo di valore commerciale per molti, ma ricco di nostalgia e radici per me era l’unica cosa di “valore” a cui riuscivo a pensare lì, nella mia casa messa sottosopra dai ladri, e di nuovo, parlando con i miei amici che continuavano a chiedermi quali cose di valore mi avessero portato via. Perché ho provato quasi vergogna a mostrare il mio attaccamento ad un oggetto che di valore ha “solo” l’affetto che lo attraversa fino a me? Forse perché un eccessivo attaccamento alle cose sembra renderci, agli occhi degli altri, materialisti e poco inclini ai veri valori della vita? È possibile che le cose nascondano invece qualcosa che le rende meno “cose”?
Flavia
Cara Flavia,
Nel 1947 la polizia di New York estrasse i cadaveri dei fratelli Collyer, dalla loro abitazione a tre piani di Harlem, sepolti sotto 120 tonnellate di oggetti accatastati uno sull’altro e accumulati in poco più di venti anni. Si tratta del primo e più famoso caso di disturbo da accumulo, detto anche “sillogomania” ( dal greco “raccogliere insieme”) o “disposofobia” (dall’inglese to dispose, cioè “buttare via”).
La tendenza patologica ad accumulare oggetti fino ad esserne quasi totalmente sommersi interessa più del due per cento della popolazione mondiale adulta, Italia compresa. Tra il 2010 e il 2014 la Asl di Milano ha eseguito più di trecento interventi di sgombero di case diventate inagibili a causa dell’accumulo di oggetti al loro interno, affidando gli inquilini (prevalentemente persone sole) ai servizi di assistenza.
A conferma e in anticipo di oltre un secolo sulla classificazione diagnostica del disturbo da accumulo, c’è la storia di uno dei personaggi de “Le anime morte” di Gogol’, Stepan Pljuškin, che non riesce a buttar via cumuli di oggetti che non sarebbe riuscito ad usare nemmeno se avesse vissuto più di cento anni.
Tipica del disturbo da accumulo è infatti l’incapacità di separarsi dalle cose, derivante dal bisogno di salvarle unito ad un senso di angoscia al pensiero di disfarsene. Pur trattandosi di una patologia, che resta sempre e comunque una lente di ingrandimento sulle nostre esistenze, il disturbo da accumulo ci racconta che esiste, nel rapporto tra noi e le cose, una componente affettiva. O forse dovremmo dire “esisteva”. Non c’è infatti traccia oggi di un nostro qualsivoglia legame con le cose: ce ne disfiamo senza pensarci due volte, le sostituiamo appena ne abbiamo l’occasione o anche perché semplicemente ci hanno stancato. Le cose stesse vengono prodotte in modo da non durare e il nuovo prende il posto di quello che non ha nemmeno avuto il tempo di diventare vecchio. Ma lo stesso vale per i rapporti umani: siamo diventati incapaci di creare e mantenere legami, di affezionarci giorno dopo giorno, di crescere insieme anche nell’abitudine.
Quando la nostra vita era intrecciata sentimentalmente agli oggetti che ne facevano parte, alle cose davamo un nome proprio. La nostra prima auto ne ha sicuramente avuto uno. E i pattini a rotelle erano qualcosa che cresceva con noi. Per quanto fossero poco belli esteticamente, con loro, chiunque li abbia avuti nella sua infanzia, ha stipulato un tacito accordo: quello di crescere insieme, allungandosi con l’allungarsi del nostro piede e permettendoci così di pattinare un po’ più a lungo.
Che sono dunque quelle che chiamiamo “cose”? Le collezioniamo ormai senza passione e per un tempo troppo breve, ne possiamo conoscere il valore commerciale e farle così diventare specchio di uno status. A volte le esibiamo,altre ce ne serviamo per colmare un vuoto creato dall’assenza di legami autentici. Spesso a loro deleghiamo il compito di raccontarci, descriverci, plasmando l’immagine di noi che vogliamo dare agli altri. Quasi sempre, in loro ci rispecchiamo anche se non ci rispecchiano poi così tanto, perché la nostra immagine, “sepolta” dalle cose, ci rimane estranea. Le cose che accumuliamo ci dicono, forse, che non sappiamo chi siamo.
Le “piccole cose” raccontano però una storia diversa. Spesso povere di valore commerciale ma ricche di valore affettivo, sono memoria del nostro legame, con gli altri e col mondo. Lontane dal concetto di merce, sono nostalgia e rifugio insieme, casa, amuleti per i giorni sbagliati, radici nomadi. Le piccole cose non sono “solo cose”. A volte riusciamo a scorgerle per un breve istante negli spazi affollati, negli angoli del mondo, nei gesti catturati a distanza. Perché non appartengono davvero a noi ma ad una storia che ci include e trascende al tempo stesso. Soprattutto, non sono frutto di un desiderio da soddisfare, ma piuttosto rappresentano un dono inaspettato. Vettori di significati, le piccole cose ci parlano, con discrezione, nel nostro privato. Ecco perché non le mostriamo in pubblico e le custodiamo gelosamente, dal momento che il loro senso ha senso per noi e soltanto per noi, e la loro essenza non è in vendita, non è replicabile in serie, non subisce le scadenze della moda. Sulle piccole cose magari ci è capitato di fare manutenzione, non per attaccamento all’oggetto, ma per predisposizione alla cura di cui da piccoli abbiamo fatto esperienza: un pupazzo con cui confidarci, un coniglio di pezza un po’ logoro e malandato da guarire, una coperta, come quella della tua nonna, in cui avvolgerci per sentirci al sicuro. I nostri oggetti transizionali, direbbe Winnicott. Ma oggi i bambini sono in una relazione aperta con il loro oggetto transizionale. È diventato difficile per loro affezionarsi alle cose perché di cose sono circondati se non addirittura sommersi, così che il nuovo è diventato più importante della ritualità, del tempo che costruisce significato.
Le piccole cose sono inutili, non ci servono nel senso che non sono al nostro servizio.. Sono libere da obblighi, vincoli e trend di mercato. È così che una coperta, creata per scaldare, ad un certo punto, entrando nella tua storia, ha in qualche modo perso quella funzione, acquisendone un’altra, e cioè quella di “piccola cosa”. Non più un oggetto da usare ma un nuovo modo di guardare e vedersi. Quel senso di vergogna nel mostrarti preoccupata per la coperta della tua nonna forse non era altro che pudore nei confronti di qualcosa di molto simile alla tua intimità.
Quando non abbiamo sviluppato quello che potremmo chiamare il settimo senso per le piccole cose anche i legami con le persone ne risentono. Questo non ha nulla a che fare col materialismo. Ha invece a che fare con la capacità di andare oltre il proprio, personale punto di vista, oltre la propria visione e percezione del mondo. E ciò significa saper leggere tra le righe, cogliere le sfumature, praticare la delicatezza, affinare la sensibilità. Fare manutenzione, in altre parole, sui rapporti umani, invece di mettere una distanza tra noi e quegli altri in cui non ci rispecchiamo, o, che poi è lo stesso, che non riflettono la nostra di immagine, ovvero quella che piace a noi.
Ti chiedi se sia possibile rendere “meno cose” le cose. Byung Chul Han sostiene che oggi siamo circondati da “non cose”, ovvero da informazioni, che lui chiama “infomi”, che ci hanno fatto perdere quel rapporto d’amore che avevamo con gli oggetti. Non si può instaurare una relazione con le informazioni, dal momento che per entrare in relazione è necessario che le cose del mondo, che ci aprono al mondo, siano “presenti”. E se è vero, come scrive, che “oggi percepiamo la realtà soprattutto in termini di informazioni”, quelle stesse informazioni hanno di fatto ridotto il contatto fisico, tra noi e con le cose. Gli schermi degli smartphone, dei pc o dei tablet, per dirne una, non sono cose che possiamo toccare con le mani. Possiamo sfiorarle con le dita, ma come dice Heidegger, se le dita attengono al “digitale”, sono numeriche, perché ci servono a contare e calcolare, la mano ci permette di accedere all’ambito originario dell’essere, è la via diretta del pensiero, un pensiero chiaramente analogico se coincide col lavoro manuale, tanto che, scrive Heidegger, “Forse pensare è semplicemente la stessa cosa che costruire un armadio”. Ed è così che le cose diventano “affidabili”, perché nella nostra relazione col mondo ci danno un appiglio sicuro. Gli oggetti disponibili e consumabili, al contrario, sono merce, scambiabile e perciò priva di appartenenza reale. Seppure abituati alla velocità che consuma, abbiamo ancora la possibilità di fermarci un po’, e soffermarci, lì dove le cose abitano, accadono, stanno, piccole eppure così vere. È solo osservandole da vicino, senza fretta, che scorgiamo i tanti mondi che riescono a contenere al loro interno, e precisamente in quello che potremmo chiamare il lato b di certe cose.
Questa rubrica, nata più di quattro anni fa, si chiama La Posta del Cigno Nero perché il cigno nero per il filosofo Karl Popper è simbolo dell’errore che insegna, della capacità di spostare il fuoco da ciò che già sappiamo per orientarlo verso quello che ancora non conosciamo. L’errore da cui impariamo molto più che dalle vite perfette che mostriamo nell’ impalpabile mondo delle informazioni. E se provassimo a trasformare l’errore in una cosa, una piccola cosa a cui affezionarci, su cui fare manutenzione, che rimane preziosa anche quando il tempo l’ha sbiadita, rimpicciolita nella lontananza, ecco, forse potremmo imparare di nuovo a voler bene e volerci bene in modo autentico e spontaneo, come quando da bambini abbiamo voluto bene a cose insignificanti per il resto del mondo, ma che in quel pezzetto della nostra vita sono stati per noi il mondo.
Scrive Francesca Rigotti in Nuova filosofia delle piccole cose : “Siamo tutti condizionati […] da quella analogia tra sapere e vedere che dai tempi degli antichi greci attribuisce al vedere con gli occhi il privilegio di cogliere l’evidenza del vero. Invece le piccole cose non sono solo lì per essere guardate, ma anche per essere ascoltate, palpate, annusate e, perché no, mangiate”. E se fosse proprio nei sensi, nel corpo, il motivo per cui ci siamo disabituati alle piccole cose, così come ci siamo disabituati ad un contatto più vero e carnale con gli altri e col mondo?
Maria Luisa Petruccelli
Per scrivere al Cigno Nero: lapostadelcignonero@gmail.com
Chi scrive accetta di vedere pubblicato quanto invia.


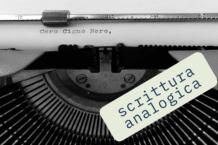


Devi fare login per commentare
Accedi