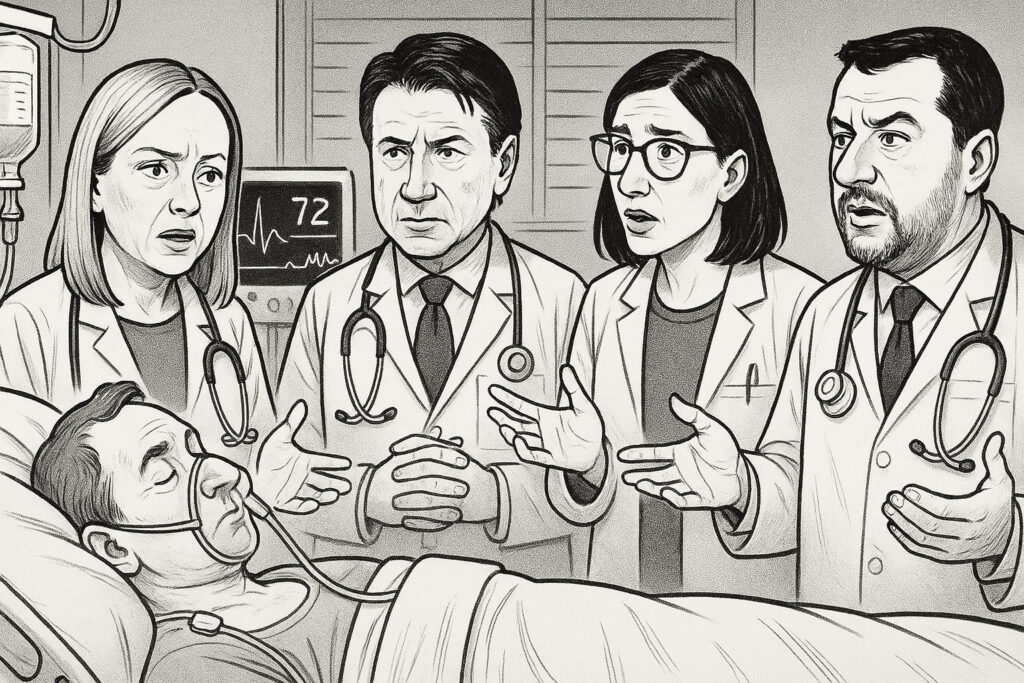
Memoria e Futuro
Il Parlamento alla prova del Bardo
Noi non siamo mai morti.
E non siamo mai nati.
Franco Battiato
Erano i primi mesi del 2009 e sui giornali e televisioni infuriava la polemica sul caso Englaro. Mi ritrovai di passaggio a casa da mia madre e, durante la cena, mentre il telegiornale raccontava di devoti raccolti in preghiera davanti alla clinica dove era la Englaro a patire (in attesa di una soluzione definitiva alla sua drammatica situazione), mia madre mi disse: “Se dovesse succedermi qualcosa del genere, impedisci questo strazio, per favore.” Classici discorsi da cena, spinti dall’urgenza delle notizie in primo piano e puntellati dai miei “Ma che stai a dire?”.
Fatto sta che, qualche mese dopo, mi trovai purtroppo nella situazione preannunciata in quella scena. Era luglio, più o meno la metà. Erano le quattro e mezza del mattino, mia madre aveva subito un incidente stradale, e stava tra la morte e la vita. E io ero a litigare con una “devota” dottoressa che voleva convincermi a firmare per un eventuale tracheotomia. “Non si preoccupi, è una formalità “. E io , dopo quasi 10 ore di attesa durante l’intervento di mia madre, dovevo disquisire sui miei diritti e i diritti di mia madre a non subire accanimento terapeutico. Battaglia che per fortuna vinsi, alzando la voce e rifiutandomi di firmare, consentendole di spirare dopo qualche giorno, spero serenamente, di certo non attaccata a delle macchine che ne avrebbero prolungato inutilmente l’agonia. Ecco qual’era lo stato della sanità italiana all’incirca sedici anni fa.
Da allora ad oggi, sono passate sentenze della Corte costituzionale, richieste di referendum (respinte dalla stessa Corte costituzionale), sondaggi che per la maggioranza dei cittadini di ogni colore politico promuovono una rapida legge sul fine vita. E dove siamo per il nostro sistema politico sul tema (perché questo, purtroppo, è un argomento che non differenzia destra e sinistra al momento della decisione)? All’ennesimo rinvio a dopo l’estate, di una legge già sbagliata in partenza e che porterà nuovo dolore e nuova sofferenza per chi si troverà costretto a dover combattere per il diritto di decidere come morire. A quanto pare il parlamento italiano vive nella fobia di Attraversare il Bardo (come avrebbe detto Franco Battiato).
Perché in questo paese da più di 50 anni a questa parte la battaglia su diversi temi e i diritti civili è, in fondo, sempre la stessa. Da una parte c’è chi vuole dare la possibilità a chi ne abbia bisogno, voglia e desiderio di regolarizzare la sua situazione (che si tratti divorzio, aborto, consumo di stupefacenti leggeri, rispetto della costituzione sull’autodeterminazione delle cure).
Dall’altra ci sono i cultori dello Stato “mamma e papà” (e prete di supporto), che ti sta addosso e decide per te quali sono le cose giuste e le cose sbagliate, che ti impone quando e come morire, chi e come amare, quando e come nascere.
Il dibattito italiano sul fine vita rivela anche un altro aspetto tipico della nostra cultura politica: l’incapacità di affrontare i temi eticamente sensibili con pragmatismo. Mentre altri Paesi europei hanno risolto la questione con leggi chiare e applicabili, noi continuiamo a girare intorno al problema cercando soluzioni che accontentino tutti e che finiscono per non accontentare nessuno. È l’arte italiana del compromesso portata all’estremo, dove la mediazione diventa fine a se stessa e perde di vista l’obiettivo originario.
C’è poi la questione del Comitato di valutazione, l’organo che dovrebbe decidere caso per caso se sussistono le condizioni per il suicidio assistito. L’idea di burocratizzare la morte ha qualcosa di grottesco: immaginiamo commissioni di medici, psicologi e giuristi che si riuniscono per decidere se una persona ha diritto a morire. È l’ennesima manifestazione della tendenza italiana a complicare ciò che potrebbe essere semplice, a creare nuovi organismi quando basterebbero procedure chiare.
Ma forse il vero problema è culturale. L’Italia è un Paese che ha sempre avuto un rapporto complicato con la morte. Da una parte c’è la tradizione cattolica che vede nella sofferenza un valore redemptivo, dall’altra c’è la cultura mediterranea che tende a rimuovere il pensiero della morte. Il risultato è una società che fa fatica a parlare apertamente di fine vita, che delega alle famiglie decisioni che dovrebbero essere individuali, che preferisce l’ipocrisia del “non detto” alla chiarezza delle regole esplicite.
Questa difficoltà si riflette anche nel linguaggio utilizzato nel dibattito pubblico. Si parla di “morte dolce”, di “fine vita”, di “buona morte”, come se usare il termine “suicidio” fosse un tabù (e, in fondo, per molti lo è). È comprensibile dal punto di vista della comunicazione politica, ma rivela anche una certa immaturità culturale nel confrontarsi con temi che altri Paesi discutono con maggiore serenità.
La lentezza con cui si procede sulla questione del fine vita contrasta drammaticamente con la velocità con cui si affrontano altri temi. Il Parlamento riesce a approvare decreti omnibus di centinaia di articoli in poche settimane, ma per una legge sul suicidio assistito servono anni di discussioni. È come se la morte fosse più complicata della vita, come se regolamentare come si muore fosse più difficile che regolamentare come si vive.
Ma forse è proprio questo il punto. La morte è l’ultimo tabù della società contemporanea, l’argomento di cui non si vuole parlare, la realtà che si preferisce ignorare. E l’Italia, Paese che ha fatto dell’arte di vivere una filosofia, fatica a confrontarsi con l’arte di morire. Preferiamo lasciare tutto nell’ambiguità, nella zona grigia, nel “si vedrà”, piuttosto che prendere decisioni nette e assumercene la responsabilità.
Il risultato è una legge che non è una legge, un diritto che non è un diritto, una libertà che non è una libertà. È il trionfo dell’ambiguità italiana, della capacità di dire tutto e il contrario di tutto, di accontentare tutti senza soddisfare nessuno. Una soluzione tipicamente italiana a un problema universale.





Inutile asciugare continuamente per terra, se non si ripara il tubo che perde:
la causa della mancanza di una legge sull’eutanasia è la chiesa cattolica (e di molte altre schifezze).
Per progredire tutti, e vivere meglio, occorrerebbe trattare la superstizione religiosa come il fumo di sigaretta:
NO ai minorenni;
NO nelle scuole;
NO pubblicità pubbliche;
si pratica in privato e con soldi propri.
La chiesa calpesta costantemente i diritti di molte categorie, inclusa quella dei non credenti, mai menzionata ma ben presente e costretta a vedersi imporre simboli, propaganda, festività e spese senza che lo stato la difenda (caso emblematico tra i molti: col fondo INPS CLERO lo stato italiano manda in pensione tutti i preti senza le regole italiane, mentre gli italiani vanno in pensione vecchi e con spicci).
Occorrerebbe ribellarsi di malo modo, tanto nella vita reale, quanto sui social, innanzitutto a questo papa che come primo discorso, tra tutti quelli possibili, ne ha scelto uno nel quale parla male dei non credenti