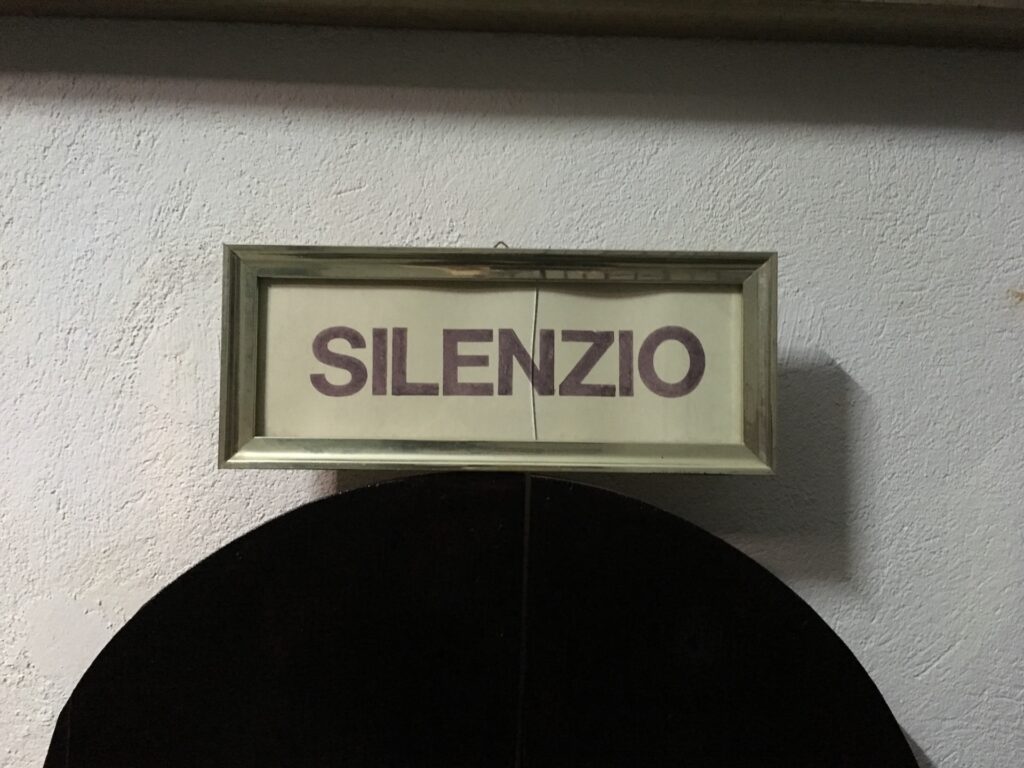
Enti locali
Il borgo che si spegne: tra oratori chiusi e comuni da fondere
A Zeme, piccolo centro della Lomellina da appena mille abitanti, la porta del campo da calcetto del centro ricreativo “Padre Francesco Pianzola” è chiusa da tempo. Nessun gol, nessun fischio d’arbitro improvvisato, nessuna partita al tramonto. Solo erba alta e silenzio. È il segno di una lenta agonia che non riguarda solo un edificio, ma l’intero tessuto sociale di molte aree rurali italiane.
Il complesso, dedicato a Padre Pianzola — il “prete delle mondine”, beatificato nel 2008 e ricordato per la sua vita tra i campi e le risaie, in povertà volontaria — è oggi in vendita. Dopo la pandemia di Covid-19, l’oratorio maschile è stato chiuso e non ha più riaperto. Restano in piedi le mura, grandi e vuote, con il bar sbarrato, le vetrine impolverate, il campo inutilizzato. A tener viva la fiammella dell’aggregazione giovanile c’è solo l’altro oratorio del paese, il “San Luigi”, che in passato era femminile e ora accoglie tutti, grazie a un manipolo di volontari.
Don Giancarlo Vergano, parroco dal 2021, ha deciso di affrontare la realtà senza sentimentalismi: «L’edificio non è utilizzato ed è disponibile per la vendita. Ha bisogno di lavori, ma offre possibilità di trasformazione: bar, tabaccheria, edicola, pizzeria… e naturalmente calcio. Ma due oratori, in un paese così piccolo, erano troppi. Ora la priorità è non restare schiacciati dai costi». Il parroco è pragmatico: meglio cedere il bene che vederlo marcire, soprattutto in tempi in cui le parrocchie, con finanze al limite, faticano persino a mantenere ciò che già possiedono.
Il centro ricreativo non è stato vittima di una crisi improvvisa: il declino era in corso da tempo. Anche il bar, ultimo baluardo di socialità, non ha retto. Diversi gestori si sono avvicendati senza successo. La pandemia ha solo accelerato l’inevitabile, e oggi, oltre al disuso, grava la pressione di spese fisse come l’Imu e la manutenzione. Le agenzie immobiliari incaricate parlano di un prezzo “basso e trattabile”, ma la vera sfida non è comprarlo: è investirci per dargli nuova vita.
Dietro questa storia concreta si nasconde un problema più ampio: lo spopolamento delle “aree interne”, come le definisce la Regione Lombardia. Piccoli paesi rurali, lontani dai poli industriali, vedono diminuire la popolazione anno dopo anno. I giovani si trasferiscono altrove per studiare e lavorare, e raramente tornano. Chi resta è spesso anziano. I servizi si riducono, l’offerta commerciale si assottiglia, e anche i luoghi simbolo dell’aggregazione si spengono. È un circolo vizioso che porta a paesi sempre più vuoti e immobili.
In questo contesto, diventa legittimo porsi domande sulla sostenibilità amministrativa di mantenere un comune autonomo con tanto di sindaco, giunta e consiglio. Non si tratta di negare il valore dell’identità locale, ma di affrontare un dato di fatto: in molti casi, le risorse economiche e umane non bastano più per garantire servizi efficienti. L’Italia ha oltre 7.900 comuni, e più di 1.900 di questi hanno meno di 1.000 abitanti. Gestire strutture, uffici, anagrafe, bilanci e interventi pubblici in entità così piccole significa spesso moltiplicare costi e burocrazia.
Nessuno chiede di licenziare i dipendenti dei comuni sopressi essi potrebbero continuare a lavorare nelle vecchie sedi comunali , ma con un unica gestione politica.
L’indennità di funzione per il sindaco di un comune con meno di 1000 abitanti nel 2025, secondo la normativa vigente, ammonta a 1.162,03 euro lordi mensili, come indicato dalla normativa previgente. Questo importo è il risultato di una riduzione del 10% rispetto all’indennità base stabilita dal Decreto Ministeriale 119/2000 per i comuni con un numero di abitanti compreso tra 0 e 1.000. Vale a dire quasi 70.000 euro lordi in cinque anni che potrebbe essere spesi per altro.
Una fusione amministrativa tra comuni vicini potrebbe liberare fondi, razionalizzare i servizi e permettere investimenti mirati. Non si tratterebbe di cancellare la storia o la cultura di un luogo, ma di creare un’entità più robusta dal punto di vista finanziario e operativo. In altri Paesi europei, processi simili hanno portato benefici concreti: in Francia, le “communes nouvelles” hanno ridotto la frammentazione amministrativa; in Germania, la riorganizzazione municipale ha permesso di mantenere scuole e servizi in zone rurali altrimenti destinate al declino.
Ma la fusione da sola non basta. Serve una politica attiva di ripopolamento, e qui entra in gioco una questione spesso divisiva: l’arrivo di nuovi abitanti stranieri, stando ad esempio a Zeme gli stranieri sono il 10.6 % della popolazione .
In molte zone agricole italiane, la manodopera straniera è già parte integrante del tessuto economico. Il passo successivo potrebbe essere incentivare famiglie immigrate a stabilirsi nei borghi spopolati, offrendo case a prezzi calmierati, sgravi fiscali e accesso a servizi scolastici. Alcuni comuni lo stanno già facendo con iniziative “Case a 1 euro” o con progetti di agricoltura sociale. Il punto è passare da un’accoglienza temporanea a un’integrazione stabile.
Una comunità viva non si costruisce solo con muri restaurati, ma con persone che li abitano, li usano e li trasformano. Ma perché questo accada, occorre un quadro amministrativo e sociale che renda tali iniziative sostenibili, occorre sacrificare l’appartato politico ed unificare in comuni di almeno 6000 abitanti avendo anche il coraggio di fare queste fusioni senza referendum tra la popolazione, ma come decisione imperativa .
Il rischio, altrimenti, è quello di vedere aumentare il numero di edifici chiusi e strade silenziose, mentre i costi di gestione restano sulle spalle di comunità sempre più ridotte. È il paradosso di una società che, pur vivendo nell’epoca della connessione globale, lascia morire i propri punti di connessione locale. Se un tempo l’oratorio era il cuore pulsante di un paese, oggi senza un progetto di rinascita rischia di diventare solo un monumento alla memoria.
Il sole di agosto che scalda l’asfalto vuoto di via Amendola è una fotografia perfetta: calore e luce su un luogo che non restituisce più energia. La scelta di don Giancarlo è un atto di realismo: meno proprietà, meno spese, più risorse per ciò che funziona. Ma è anche un campanello d’allarme: quando un paese chiude i suoi spazi di incontro, perde un pezzo della propria anima.
Per invertire la rotta servono decisioni coraggiose. Fondendo comuni, riducendo i costi della politica locale, investendo in infrastrutture digitali e incentivi per chi vuole vivere fuori città, si può dare un futuro a borghi come Zeme. Magari anche accettando che la nuova vitalità arriverà da persone che oggi non hanno radici qui, ma che potrebbero piantarle domani.
Perché, alla fine, non è importante da dove vengono gli abitanti di un paese, ma se scelgono di viverci, crescere figli, aprire attività e animare le strade. Se Zeme e tanti altri piccoli centri riusciranno a compiere questo passaggio, allora i campi da calcio torneranno a vedere gol, i bar a servire caffè, e le vecchie mura non racconteranno più soltanto storie passate, ma anche speranze future





Devi fare login per commentare
Accedi