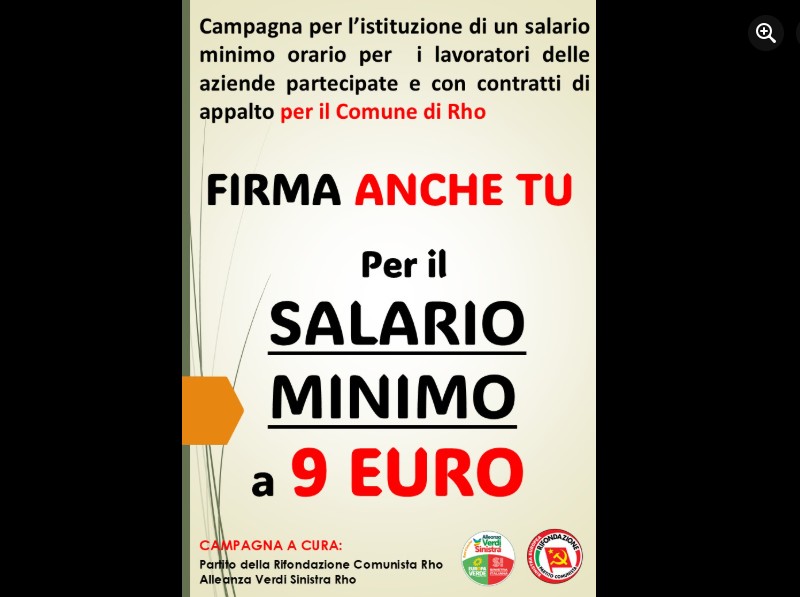
Lavoro
Il salario minimo locale? ‘Effetti simbolici’
Che impatto stanno avendo i ‘salari minimi locali’ approvati da alcune amministrazioni di centrosinistra l’anno scorso e a luglio anche dalla nuova giunta genovese di Silvia Salis? A giudicare dalle testimonianze raccolte dove sono già in vigore, più d’immagine che di sostanza.
Dopo essere stato agitato per qualche tempo nel dibattito politico nazionale all’epoca del Conte 1 (M5S+Lega) ed essere improvvisamente sparito dagli schermi al sopraggiungere del Conte 2 (M5S+PD), a causa delle controversie e dei dubbi prevalenti nel PD e nello stesso sindacato, il tema del salario minimo è tornato alla ribalta con l’avvento di Giorgia Meloni. Il centrosinistra si è improvvisamente compattato e ha presentato una proposta di legge che provava a trovare un compromesso tra le diverse proposte (nella legislatura precedente il solo PD ne aveva depositate tre, una il M5S e una Sinistra Italiana). FdI, che nella legislatura precedente aveva presentato una sua proposta di legge favorevole all’introduzione, una volta al governo si è convinto che “il salario minimo danneggia i lavoratori”. Mentre il gruppo dirigente della CGIL, inizialmente perplesso, ha formalmente sdoganato l’idea di un minimo orario fissato per legge, pur con qualche condizione, come l’approvazione di una legge sulla rappresentanza sindacale, e tuttavia non l’ha incluso tra i quesiti della sua campagna referendaria. Nel frattempo il termine per il recepimento della direttiva europea approvata tre anni fa, il 14 settembre 2022 è scaduto a novembre, ma nessuno ha dato alla questione lo stesso risalto tributato ad altre richieste di Bruxelles negli anni passati. E i dati diffusi ieri dall’Osservatorio Job Pricing attestano che negli ultimi 10 anni gli stipendi in Italia sono aumentati complessivamente del 9,5% a fronte di un’inflazione del 20,8%.
Di recente la discussione si è spostata a livello locale ancora su iniziativa dei partiti di opposizione. Prima il Comune di Firenze, poi quello di Napoli e a seguire alcuni centri più piccoli e due regioni, Toscana e Puglia, hanno approvato dei provvedimenti che fissano i 9 euro lordi come paga minima oraria negli appalti dei propri enti e delle aziende partecipate. Il Governo ha reagito impugnando prima la legge regionale pugliese (per inciso l’unica a specificare che i 9 euro devono esser intesi come retribuzione minima tabellare) davanti alla Corte Costituzionale perché lederebbero gli articoli che tutelano la libertà d’impresa e fissano le prerogative esclusive dello Stato. Altrettanto ha fatto ad agosto con la legge toscana.
A luglio anche l’amministrazione della neoeletta sindaca di Genova, Silvia Salis, ha approvato le “Linee guida per la tutela della retribuzione minima salariale nei contratti del Comune”, mentre l’assessore milanese Pierfrancesco Majorino (PD), dopo l’inchiesta sulle concessioni edilizie che ha travolto la sua giunta, è tornato ad agitare il “salario minimo per Milano”. Infine anche il candidato del “Campo largo” in Calabria, l’ex presidente INPS Pasquale Tridico, ha inserito nel programma elettorale il salario minimo regionale.
Ma un ente locale o una regione possono, in assenza di una legge nazionale, interferire in una materia che è demandata alla contrattazione collettiva tra sindacati e associazioni datoriali? Leggendo le delibere adottate da alcuni degli enti citati si ha l’impressione che anche chi li ha scritti sia consapevole che si tratta di una “mission impossible”. Le delibere adottate di fatto si limitano a invocare l’applicazione dei contratti nazionali firmati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed evocano un’attività di “verifica” che i contratti applicati non prevedano paghe orarie al di sotto dei 9 euro. Ma se sono inferiori le amministrazioni cosa possono fare? Di fatto nulla, ci spiega Dmitrij Palagi, consigliere comunale fiorentino per Sinistra Progetto Comune, commentando un provvedimento che lui stesso aveva richiesto nella precedente consiliatura, ma che, ci spiega, è stato apprezzabilmente approvato l’anno scorso dalla nuova amministrazione a cui lui oggi fa opposizione. “Siamo consapevoli che in assenza di un normativa nazionale l’impatto della delibera è soprattutto simbolico e di indirizzo politico. Concretamente il Comune può solo aspettare che un appalto scada e introdurre nel successivo bando di gara la richiesta di applicare un contratto collettivo in cui le paghe siano superiori al minimo indicato nell’atto”. Finora è successo una sola volta, con l’appalto dei musei civici. Nel nuovo bando l’amministrazione ha previsto che i lavoratori siano assunti col contratto Federculture invece che col Multiservizi, uno dei più gettonati, insieme a Vigilanza Privata – Servizi Fiduciari, perché molto meno costoso per le imprese. “Ora siamo orientati a fare altrettanto coi lavoratori dei bagni pubblici del settore turismo, che al momento dipendono dalla Città Metropolitana. Nel prossimo bando contiamo di far adottare un contratto in cui i minimi tabellari siano superiori, ma il Comune dovrà farsi carico di fornire le risorse aggiuntive”, spiega.
A Napoli il tema del salario è ancor più pressante, non foss’altro che per la forte concentrazione di giovani: gli under 18 sono circa il 20%, ma il capoluogo campano è anche una delle città italiane col più elevato esodo giovanile degli ultimi decenni e in alcuni quartieri la percentuale di NEET sfiora il 60%). Nel 2024 il sindaco Manfredi, sostenuto dal “Campo largo”, ha introdotto il salario minimo comunale. Ma i benefici finora non si vedono, ci spiega Adolfo Vallini, autista ANM, l’azienda di trasporto pubblico locale del Comune, e sindacalista USB: “Come sindacato pensiamo che per compensare il caro vita la paga oraria dovrebbe essere almeno 12 euro lordi, ma qui non si arriva neanche ai 9. La delibera è stata approvata, ma non viene applicata. In ANM i lavoratori inquadrati col contratto della Vigilanza Privata e quelli che fanno il servizio di portierato stanno sotto, così come chi fa le stesse cose in Regione Campania”. Per Paolo Angelone, dello Sportello Lavoro dell’ex OPG, il paradosso è che “La delibera, che riguarda gli appalti del Comune e delle aziende partecipate, non si applica a queste ultime, per cui ci sono dipendenti di Asia Napoli, l’azienda comunale di igiene ambientale, che guadagnano meno di 8 euro l’ora”. Senza contare che “in una città come Napoli bisognerebbe intervenire in tutte quelle attività – bar, ristoranti, alberghi e concessioni comunali – in cui il problema è ancor più drammatico”. Per Giuliano Granato, napoletano, coordinatore nazionale di Potere al Popolo, che nel 2023 ha raccolto oltre 70.000 firme a sostegno di una legge d’iniziativa popolare per il salario mino a 10 euro, “Al momento l’impatto della delibera è zero, cioè solo ed esclusivamente propagandistico. E siccome nel perimetro del Comune di Napoli ci sono lavoratori che, pur essendo stati assunti coi contratti collettivi dei sindacati maggiormente rappresentativi, guadagno meno di 10 euro, qui e in altri comuni abbiamo scelto di presentare delle mozioni che chiedono di reinternalizzare i servizi dati in appalto”. Del resto anche il segretario generale della CGIL di Napoli e Campania, Nicola Ricci, quando il salario minimo comunale era entrato in vigore aveva invitato alla cautela: “I 9 euro l’ora sono lordi o netti? Perché nel primo caso si riducono a 6,5 euro. E poi: per quante mensilità e su quali istituti impatta? Per noi il salario minimo, se ben coordinato coi contratti nazionali, è una risposta al lavoro povero e alla precarietà. Quindi bisogna capire meglio come sarà applicato e speriamo che ci sia un confronto col sindacato” aveva dichiarato a Collettiva.
A Genova, più prudentemente, la giunta sostenuta da una maggioranza M5S-PD-AVS fino a Italia Viva ha previsto di inserire nei nuovi capitolati d’appalto degli incentivi per le aziende che partecipano alle gare e si impegnano ad applicare contratti al di sopra dei 9 euro, ma non è chiaro quanto peserà la richiesta in termini di punteggio e soprattutto che politica attuerà il comune sui ribassi richiesti alle imprese, perché è chiaro che i due aspetti sono strettamente connessi ed è un tema che si pone in tutte le amministrazioni. In altre città, dove gli incentivi in termini di punteggio sono stati già inseriti, le aziende hanno preferito rinunciarvi pur di applicare contratti meno costosi.
Emiliano Gentili e Federico Giusti in uno studio pubblicato a luglio sono andati a scavare negli affidamenti del Comune di Genova e hanno scoperto, ad esempio, che in un’azienda di pulimento “71 dipendenti hanno il livello 2 del CCNL Multiservizi, che con gli importi aggiornati all’anno corrente corrisponde a una paga oraria di 7,77 euro, incluse le indennità; 14 hanno il livello 3 del CCNL, con paga oraria di 7,91 euro; 2 dipendenti hanno il livello 4 e 8,21 euro” e secondo la CGIL, scrivono, sono 5.000 i lavoratori degli appalti del Comune di Genova che percepiscono meno di 9 euro lordi l’ora. Insomma, sottolineano, applicare i contratti collettivi firmati dai sindacati più rappresentativi non garantisce il rispetto dei 9 euro lordi. Il che ci riporta al vero nodo della questione: che valore hanno concretamente le clausole che impegnano l’ente pubblico, citiamo la delibera fiorentina, a “verificare che i contratti indicati nelle procedura di gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a 9 euro l’ora”? (corsivo nostro).
Stavolta lo chiediamo a Orsola Razzolini, docente di diritto del Lavoro alla Statale di Milano, di cui sta per uscire un lavoro sull’argomento, chiedendole innanzitutto di chiarirci quali siano, più in generale, gli spazi di manovra di un ente pubblico per influenzare le retribuzioni nei propri appalti. “Fino a un paio di anni fa l’ente pubblico non poteva indicare nel capitolato d’appalto il contratto collettivo da applicare. Con l’approvazione prima del ‘Codice degli Appalti’ nel 2023 e poi del Decreto Legislativo 209/2024 le amministrazioni sono state autorizzate a farlo e questo è un fatto positivo, ma l’impresa può comunque optare per un altro contratto, purché ne dimostri l’equivalenza in base ai criteri fissati dalla legge e da alcune linee-guida dell’ANAC: una procedura tortuosa, potenzialmente controversa e aggirabile”.
Quanto alla fissazione dei 9 euro come “trattamento minimo inderogabile” la giurista è scettica: “In termini giuridici, in assenza di una norma nazionale è una scelta impugnabile. Il caso pugliese è solo il più eclatante”. L’alternativa potrebbe essere ispirarsi alla recente giurisprudenza. Negli ultimi due anni, infatti, la Cassazione, esaminando alcune sentenze dei tribunali di Milano e di Torino, secondo cui i minimi tabellari del CCNL Vigilanza Privata/Servizi Fiduciari, ben al di sotto dei 9 euro, violavano l’articolo 36 della Costituzione (retribuzione proporzionata al lavoro e sufficiente a garantire al lavoratore e ai familiari un tenore di vita dignitoso) ha confermato la necessità che i minimi dei contratti collettivi rispettino la norma costituzionale e hanno affermato che ciò non avviene se la retribuzione si colloca al di sotto della soglia di povertà ISTAT. “La cosa che si potrebbe fare e che nessuno fa è scrivere nel capitolato che l’appaltatore e i subappaltatori in ogni caso devono corrispondere una retribuzione che rispetti l’articolo 36 della Costituzione. Non che anche questa via non sia anch’essa problematica, ma significherebbe che la stazione appaltante si riconosce ‘corresponsabile’ della corretta attuazione della regola costituzionale e quindi autorizzata a sindacare le scelte imprenditoriali in tema di retribuzione, anche escludendo dalle gare chi non la rispetta” spiega Razzolini. Un approccio fondato su una giurisprudenza che darebbe agli enti locali qualche chance in più, a cui, però, nessuno fa ricorso.
È il paradosso di una politica che quando ha avuto la possibilità di far approvare il salario minimo, col vento in poppa della direttiva europea, non lo ha fatto e, anzi, ha dimenticato la pratica in un cassetto; che ha riscoperto la questione salariale quando si è ritrovata all’opposizione e che oggi utilizza il salario minimo come tema di propaganda a livello locale, pur sapendo che gli effetti concreti di una delibera comunale o regionale sono al più “simbolici”.
Laura Guidetti, a Genova nota femminista e attivista per i diritti LGBT+, dopo l’approvazione delle linee-guida sul salario minimo della giunta Salis ha scritto: “L’obiettivo del salario minimo per legge dovrebbe essere centrato sulla paga base, in modo da ottenere ulteriori vantaggi su aspetti rilevanti quali il calcolo della pensione, dello straordinario, degli scatti di anzianità. È un intervento sui contratti collettivi nazionali che ovviamente i singoli comuni non possono esercitare. Ma allora perché chiamarlo salario minimo? Perché usare un’espressione che andrebbe riservata ad un’istanza precisa, per la quale sarà necessario lottare duramente perché datori di lavoro e governo faranno di tutto per annacquare e tenere al ribasso ogni possibile aumento reale”. ‘Chiamalo col suo nome’ si intitola l’intervento. Una regola aurea che politici di governo e opposizione non sono abituati ad applicare. E non solo sul salario minimo.
Articolo apparso sulla newsletter di PuntoCritico.info del 16 settembre.





Devi fare login per commentare
Accedi