Consumi
La kefiah: tra uso e consumo
Caro Cigno Nero,
poco tempo fa Vuitton metteva in commercio un foulard simil-kefiah. Dopo le numerose polemiche suscitate dal prodotto, non so se legate a questo particolare periodo, è stata ritirata, come ritengo giusto che sia. Non sono religioso, ma quello della casa di moda mi è sembrato un sacrilegio, la profanazione di un simbolo. Mi chiedo su cosa si basi questo mio pensiero, questa mia sensazione. Dopotutto possono rubare la kefiah, che è solo una cosa, e il capitalismo è fatto di cose, non la storia.
Lele
Caro Lele,
ci sono questioni che suscitano il nostro consenso o, viceversa, la nostra contrarietà, talmente intuitivamente da non richiederci spiegazione. Questo avviene quasi sempre quando sono in gioco dei simboli, ed è interessante, invece, assumere la tua postura interrogativa per tentare di ricercare su cosa poggino le nostre risposte emotive e cognitive. È questo il caso della domanda che sollevi in merito alla tua presa di posizione sulla vicenda Louis Vuitton, casa di moda accusata di “appropriazione culturale” ai danni del popolo palestinese. Sicuramente lo sdegno generale è stato acuito dalla concomitanza cronologica con l’ennesimo e deplorevole giro di vite da parte di Israele, nonché dai colori del “foulard” che ne richiamano la bandiera.
A disturbare si aggiunge il prezzo da capogiro, che sarebbe andato a riempire le tasche già colme di una casa di moda tra le più blasonate al mondo e che, come tale, è l’opposto ideologico di quanto la kefiah rappresenta.
Il problema, allora, sta forse proprio in ciò che la kefiah rappresenta, intrecciando il piano delle cose, dei valori e dei simboli.
È vero che la kefiah è una “cosa” come scrivi, tangibile e concreta, ma non è corretto pensare che le cose siano di poco conto, che le cose siano nulla, perché le cose, in qualche modo, fanno mondo.
In Vita Activa, Hannah Arendt spiega molto bene l’enorme capacità di resistenza delle cose, peculiarità che incide in modo decisivo sulla nostra condizione umana. Nel turbinio di contingenza e mutamenti in cui siamo immersi, sono proprio le cose, con la loro “medesimezza” ‒ per riprendere le parole del filosofo tedesco-coreano Han ‒, a renderci familiare la vita. Se da un lato, quindi, le cose sanno durare e resistere alla vita, dall’altro, restando uguali mentre il mondo intorno cambia, viene speso e consumato, riescono a rendere più resistente la vita stessa e a stabilizzarla. Ed è così che il tavolo o la sedia hanno il potere di rafforzarci, rassicurandoci sulla nostra identità, perché, pur venendo usati, sono duri e sanno perdurare, a differenza di un bene di consumo che viene, appunto, immediatamente consumato, sbriciolando anche un pezzetto di noi.
E la kefiah? Sebbene nel tempo abbia subito derive più o meno modaiole, indossarla ha sempre significato parteggiare, anche solo vagamente, per una idea di giustizia politica e sociale. Se è vero, infatti, che si può portarla inconsapevolmente, sarebbe irrealistico pensare che ad indossarla possa essere il manager rampante e senza scrupoli di turno.
Il fatto di appartenere ‒ e non nel senso della proprietà ‒ a un popolo e alla sua storia, le ha permesso di resistere al tentativo, o magari alla tentazione, di essere tradita e trasformata in bene di consumo, ed è accaduto perché, oltre che “cosa”, la kefiah è un simbolo, un simbolo pubblico, non uno status-symbol “privato”, in quanto privatizzato, come il logo di una qualsiasi marca di scarpe da ginnastica.
Nel mondo fluttuante sono davvero pochi i simboli che resistono, ma quelli che ci riescono hanno il potere di determinare un confine nel senso dell’appartenenza o, viceversa, dell’esclusione. Il simbolo insomma, nel nostro mondo dell’anonimato da status-symbol, ha a che vedere con l’identità, proprio come il perdurare delle cose.
Da sym-ballo, tenere assieme, il simbolo è ciò che sta per un’altra cosa, ma in una trascendenza che non “indica” in maniera arbitraria, seppur univoca, bensì “rimanda”. Il simbolo rimanda sì a qualcosa d’altro, per cui “la sproporzione tra forma ed essenza resta essenziale per il simbolo nella misura in cui esso […] rimanda al di là della propria apparenza sensibile” scrive Gadamer, ma è qualcosa d’altro con cui è in relazione.
“Simbolo” era la tessera hospitalis dell’antica Grecia: si trattava di spezzare in due una tavoletta, di modo che ospitante ed ospitato ne tenessero un pezzo. Questa specificità ne faceva un unicum non intercambiabile, perché il riconoscersi – pur senza necessariamente conoscersi – era garantito dal combaciare di queste due unicità. E il valore non stava tanto nel suo contenuto, ma nella possibilità, per dirla ancora con Gadamer, di essere esibito, rendendolo documento – ma anche patto, accordo – attraverso il quale i membri di una comunità si riconoscevano.
Il gesto della Vuitton è tracotante perché con frivolezza ha pensato di poter compiere una operazione micidiale: mandare in mille frantumi la tessera hospitalis. Trascinando la kefiah dalla polvere tragica della Palestina al mondo luccicante dell’alta moda, ha minato l’essenza del simbolo, e lo ha fatto senza chiedere permesso – a chi, poi, dal momento che la kefiah non ha proprietari? (Anzi, se proprio volessimo cercarne uno, potremmo forse individuarlo solo nella storia) –. Come bene di consumo, per sua natura destinato a non durare, la kefiah sarebbe diventata fragile, praticamente un ossimoro. Forse è questo che ci fa arrabbiare: se il capitalismo, come scrivi, può rubare un “cosa”, per venderla e comprarla, ma non può rubare la storia, si dimostra però senza scrupoli nel polverizzare un simbolo, un’identità, e poco gli importa di polverizzare anche la storia e renderla una nebbia in cui diventa impossibile riconoscere o riconoscersi.
Sulla questione palestinese Louis Vuitton si è dichiarata neutrale. Oltre a chiederci come questo sia umanamente (im)possibile, potremmo domandarci: che relazione c’è tra la fugacità della moda e la forza di una idea? Che differenza c’è tra un simbolo e uno status symbol?
Irene Merlini



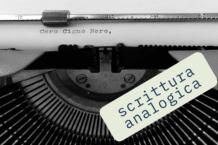

Devi fare login per commentare
Accedi