Economia
Il lavoro del futuro: luci e ombre dell’economia on demand
«Diventa il capo di te stesso» è lo slogan con cui molte delle società che operano in quella che viene chiamata sharing economy cercano di attrarre le forze migliori tra chi si trova disoccupato, sottoccupato o comunque ha voglia di cambiare vita e gestirsi in autonomia le ore di lavoro. Ultima a utilizzare questo slogan (“Be your own boss”) è Amazon, che a ottobre 2015 ha lanciato Flex, servizio attraverso il quale chiunque può diventare corriere per Amazon, utilizzando la propria macchina e il proprio smartphone e guadagnando dai 18 ai 25 dollari l’ora.
Fermandosi agli slogan, è facile immaginare i lavoratori del futuro finalmente liberi dalle catene degli uffici e pronti a scattare (ma solo se vogliono) alla prima notifica che si accende sullo smartphone – un po’ come Batman quando si accende il bat-segnale – per indicare che, da qualche parte, qualcuno ha bisogno di loro: per consegnare un prodotto, per portare fuori il cane, per pulire un appartamento, per dare una mano a montare delle mensole (per fermarci solo ai lavori che richiedono competenze meno specifiche).
È curioso che proprio Amazon utilizzi quello slogan così attraente. La stessa Amazon che ha ridato vita a un termine appartenente al passato: “turco meccanico”. Che oggi sta a indicare persone che compiono lavori semplicissimi e ripetitivi: lavori che nemmeno i computer vogliono fare. Micromansioni, chiamate in codice “hits” (human intelligence tasks), che vanno dall’inserire le giuste tag su pagine web, a fare veloci correzioni di articoli a caccia di refusi, moderare commenti e altro.
Tutti compiti molto semplici, molto veloci e molto ripetitivi. Per i quali la piattaforma Mechanical Turks creata da Amazon nel 2005 – e che mette in contatto circa 500mila lavoratori (secondo le stime) con migliaia di società – paga tra i due e i cinque dollari all’ora. Ed ecco che il sogno del freelance con lo smartphone in mano si trasforma nell’incubo del lavoratore perennemente davanti al pc di casa per svolgere compiti alienanti e sottopagati e senza avere alcun diritto a ferie e malattie. Con uno stipendio che, nel migliore dei casi, arriva a 1.000 dollari al mese.
Il freelance e il turco meccanico, quindi. Si tratta dei due estremi di un sistema che, oggi come oggi, sembra inarrestabile. Tanto che secondo Robin Chase (autore di Peers, inc.) «tutto ciò che può diventare una piattaforma diventerà una piattaforma»”. Vale a dire che tutte le società che avranno vantaggio a (o necessità di) trasformarsi in una semplice piattaforma che mette in contatto domanda e offerta lo faranno.
Un futuro di soli freelance?
La conseguenza è ovvia: nel futuro potremmo essere tutti freelance. Già oggi i dati parlano di una crescita continua: negli Stati Uniti un terzo della forza lavoro è costituita da liberi professionisti; percentuale che sale fino al 50% se si considerano i soli millennials (dati Freelancers Union).
E in Italia? Secondo i dati di AddLance, le partite Iva attive nel nostro paese sono 5 milioni. Se si escludono le società di capitali o non commerciali, si scende a 3,8 milioni. A svolgere però “attività creative e intellettuali” (aspetto che da sempre contraddistingue questa tipologia di lavoro) sono solo 1,2 milioni. Ma poco importa, perché la “uberizzazione” della società rende sempre meno importante distinguere tra chi fa lavori intellettuali e chi no.
È importante, invece, capire quale sia il livello di reddito dei lavoratori autonomi: secondo i dati di Adapt, le partite Iva nel 2013 avevano un compenso lordo medio di 18.640 euro, che in termini netti significa un reddito da 8.670 euro annui, 723 euro mensili.
Bisognerebbe anche capire per quanti lavoratori la scelta di diventare indipendenti è stata libera e quanti invece sono stati in qualche modo costretti: per uscire dalla totale disoccupazione o per arrotondare uno stipendio non sufficiente. Ci sono poi i lavoratori dipendenti che approfittano di queste possibilità per occupare i tempi morti in ufficio. Ovviamente, nessuno può fare il corriere durante gli orari di ufficio; ma si può invece certamente lavorare come “turco meccanico” e arrotondare lo stipendio (se poi questo sia legale, legittimo o anche solo opportuno è un altro discorso).
Una app per ogni lavoro
E così, quella che una volta era una modalità di lavoro riservata ai liberi professionisti dell’immaginario collettivo (avvocati, architetti, giornalisti) è diventata una possibilità per tutti. Chi vuole lavorare come autista e gestirsi liberamente il tempo di lavoro può iscriversi a Uber o UberPop; chi vuole fare il traduttore-editor-writer può iscriversi a UpWork; chi è pratico di trapani, martelli e chiavi inglesi può puntare su Mario; chi vuole fare il dogsitter si iscriverà a Wag! e chi vuole fare un po’ di tutto senza allontanarsi troppo da casa proverà con TaskRabbit.
Ovviamente, è difficile immaginare che qualcuno faccia solo il corriere per Amazon Flex o solo il turco meccanico. È molto più probabile che, nel futuro, sempre più persone si guadagneranno lo stipendio con una somma di micro-lavori. Una modalità che ha già un nome: gig economy, da “gig”, che stava a indicare le performance musicali o artistiche e adesso anche i lavori di brevissima durata.
La gig economy, però, vale solo per i “lavoretti”; mentre ormai il lavoro tramite applicazioni ha investito anche le grandi professioni: AxiomLaw provvede agli avvocati; TalentGroup ai top manager; MediCast addirittura ai medici. Quest’ultima permette negli Stati Uniti di avere un medico specializzato alla nostra porta nel giro di due ore, per circa 200 dollari (inclusa un’assicurazione contro eventuali negligenze), ed è particolarmente attraente per giovani medici senza i soldi necessari per avviare il proprio studio o per medici non più così giovani che hanno voglia di gestire liberamente il proprio tempo.
La domanda che spesso sorge è: ma come faccio a fidarmi di un medico mai visto prima? In verità, il rischio è molto limitato, perché il sistema dei feedback, che ha reso così affidabile acquistare prodotti su eBay, si può applicare anche agli autisti di Uber e ai medici di Medicast. La vera difficoltà, l’unica barriera d’ingresso per i lavoratori del futuro, è quella di ottenere le prime 5/10 recensioni positive e iniziare a costruirsi una reputazione online.
Altro che sharing economy
Ma è corretto utilizzare per tutte queste esperienze il termine sharing economy? Con questa definizione, si fa riferimento a un’economia in cui i beni sottoutilizzati vengono messi in condivisione. Per esempio, se ogni giorno mi muovo in macchina da Torino a Milano e ho altri quattro posti a sedere vuoti, perché non condividere questo bene sottoutilizzato (la mia macchina) risparmiando così anche su casello e benzina (BlaBlaCar)? Se ho a disposizione una branda sulla quale nessuno dorme mai, perché non dare la possibilità a qualche viaggiatore di dormire lì, gratis, ricevendo in cambio la possibilità di dormire, a mia volta, a casa sua quando ne avrò bisogno (CouchSurfing)?
Questi sono veri esempi di sharing economy, che infatti non si basano sul guadagno personale (lasciando da parte qualche possibile “cresta”) ma solo sulla condivisione di beni sottoutilizzati. Molto più difficile trovare lo “sharing” per quanto riguarda le app per dogsitter o per i medici di Medicast, ma anche negli esempi stranoti di Uber e AirBnb, che andrebbero invece considerate come delle semplici piattaforme per il noleggio di auto con conducente e per l’affitto a breve termine di stanze private. Il senso dello sharing si perde poi completamente se si pensa che spesso sotto questo ombrello si trovano catalogate anche realtà come Spotify o Netflix, in cui nulla viene messo in condivisione.
La verità è che il termine sharing economy molto spesso viene usato impropriamente, e che sarebbe quasi sempre il caso di parlare di “rental economy” o di “on-demand economy”. Quest’ultima definizione, in effetti, è quella che sembra spiegare con maggiore precisione la rivoluzione a cui il mondo del lavoro sta andando incontro: lavoratori su richiesta, pagati solo ed esclusivamente a prestazione, liberi di lavorare quando e se ne hanno voglia e tempo, che trovano le offerte di lavoro collegandosi a un sito o a un’applicazione.
Una rivoluzione che, nonostante le resistenze a volte quasi luddiste, sembra impossibile da fermare e che, comunque, presenta molti aspetti positivi, soprattutto se si prende in considerazione una realtà bloccata come quella italiana, in cui moltissime professioni tipicamente “da freelance” (giornalisti, traduttori, editor, fotografi, ecc.) sono (erano?) avvicinabili solo a chi avesse le conoscenze giuste. La “on-demand economy” garantisce invece che ci sia una vera meritocrazia e che un traduttore possa riuscire a trovare i primi lavori grazie a una piattaforma come UpWork e poi, da lì, moltiplicare le commissioni e iniziare a crearsi i contatti necessari.
La lama a doppio taglio della meritocrazia
L’accento posto sulla meritocrazia, probabilmente, è uno dei valori aggiunti più importanti della on-demand economy, soprattutto per chi cerca di entrare nel mondo dei “lavori creativi” senza poter contare su una rete di conoscenze già costituita.
Ci sono però evidenti aspetti negativi. Non solo l’abbondanza di persone che cercano lavoro su queste piattaforme rischia di spingere eccessivamente al ribasso i compensi, ma su alcune di queste (per esempio, il Mechanical Turk di Amazon) il committente può decidere di non pagare chi ha svolto il lavoro se non lo considera all’altezza delle aspettative. A quel punto, non conta quanto abbiate lavorato o quanto impegno ci abbiate messo: non vedrete un euro e avrete la sola possibilità di vendicarvi dando un basso punteggio alla società committente (che, però, a furia di ricevere bassi punteggi rischia di compromettere la sua credibilità e non trovare più persone a cui commissionare i lavori).
La spietata meritocrazia della on-demand economy arriva fino ad altri eccessi, quella in cui si viene pagati solo ed esclusivamente in base al successo che il vostro lavoro ottiene. Ovviamente, questo vale solo per alcune tipologie di lavoro, la cui efficacia può essere misurata al millesimo. È il caso, per esempio, degli “articoli” scritti su Blasting News, piattaforma giornalistica a cui chiunque si può registrare per poi scrivere pezzi sugli argomenti che preferisce; pezzi che devono solo passare al vaglio molto benevolo della redazione. L’autore di questi articoli, però, non sarà pagato a pezzo, ma a click: fino alle 150 visualizzazioni non ottiene nulla, dalle 150 in su inizia a essere pagato, ricevendo in media circa 4 euro per mille visualizzazioni e arrivando a guadagnare un massimo di 150 euro per articolo se dovesse arrivare attorno alle 30/40mila visualizzazioni (missione quasi impossibile). Se Blasting News non può finire sotto il cappello della on-demand economy è solo perché è un tipo di lavoro ancora più libero: si scrive quando si vuole, quanto si vuole, senza neanche bisogno di aspettare una commissione.
Il ribaltamento del rischio d’impresa
Questo esempio, però, è molto utile per sottolineare un altro comune denominatore della rivoluzione in corso nel mondo del lavoro: il ribaltamento del rischio d’impresa. Chi fonda una società di corrieri espresso è responsabile della soddisfazione del cliente e deve pagare i suoi lavoratori indipendentemente da quante spedizioni compie, almeno finché non si arriva all’estremo del fallimento della società. Chi invece decide di fondare una piattaforma come Amazon Flex, che mette in contatto persone che hanno una macchina e tempo a disposizione con persone che stanno aspettando una merce, non solo scarica integralmente sul lavoratore il compito di soddisfare il cliente, ma in più paga i lavoratori solo in base al numero di commissioni che svolgono, mentre il suo unico compito è quello di aggiornamento e manutenzione della piattaforma. Fatta eccezione per i costi fissi, quindi, le uscite sono direttamente proporzionali all’andamento della propria impresa, mentre ad assumersi tutti i rischi è il lavoratore.
A questo svantaggio enorme vanno aggiunti tutti i “contro” storici dei lavoratori autonomi: niente ferie pagate, niente malattie pagate, niente sussidi di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali, niente contributi pagati (in parte) dall’azienda. Il che non significa che bisogna passare dai facili entusiasmi alle profezie funeste, ma solo che è il caso di valutare bene quale sia lo scenario a cui si sta andando incontro.
La realtà, infatti, è molto sfumata. Questa rivoluzione potrà piacere molto a chi dà più valore alla flessibilità che alla sicurezza, a chi vuole avere la possibilità di lavorare da “nomade”, a chi preferisce “possedere il proprio tempo” invece che “possedere cose” (visto il legame strettissimo tra consumi e sicurezza economica). Ma come la mettiamo con chi invece desidera la sicurezza? Con chi non vuole andare a letto ogni notte senza sapere quanto guadagnerà il giorno dopo? Senza fare della facile retorica, è ovvio che non si può pensare a un mondo in cui le aziende si sottraggano a ogni responsabilità.
Qual è quindi il mondo che si sta creando? Come è stato ben scritto su The Economist, “i pessimisti temono che ci si ritroverà tutti nelle condizioni dei lavoratori del XVIII secolo, che affollavano i docks in attesa di essere assunti da qualcuno per la giornata. Gli ottimisti invece dipingono un mondo in cui ognuno avrà il pieno controllo delle proprie vite, facendo il lavoro che vuole quando vuole. Entrambi i campi devono tenere a mente che la on-demand economy non sta introducendo il serpente del lavoro occasionale nel giardino della piena occupazione: si sta invece sfruttando una forza lavoro in parte già abituata al lavoro occasionale in modi che possono migliorare alcuni problemi mentre, invece, ne aggravano altri”.
Gli ottimisti della on-demand economy hanno ragione se si pone il focus su professionisti molto qualificati, che troveranno con maggiore facilità un committente interessato al loro lavoro e che potranno gestire sempre meglio i loro tempi; i pessimisti hanno ragione se invece si pensa a chi mette insieme uno stipendio attraverso diversi microlavori, alcuni dei quali richiedono anche un certo sforzo fisico. Se chi passa le sue giornate a portare fuori cani, consegnare pacchi per Amazon e fare piccole sostituzioni nelle case altrui si rompe una gamba, come farà a portare a casa lo stipendio? Se la on-demand economy riguarda ormai tutte le tipologie di lavoro, bisogna iniziare a riflettere anche su questi aspetti.
La necessità del reddito minimo garantito
Ed è proprio per questo che deve tornare d’attualità la questione del reddito minimo garantito, che consentirebbe di poter vivere in una nuova economia lavorativa on-demand senza per questo dover rinunciare a ogni forma di sicurezza. Attenzione, il reddito minimo garantito è cosa diversa dal reddito di cittadinanza (spesso tra le due si fa un po’ di confusione): mentre quest’ultimo consentirebbe a tutti di avere un reddito indipendentemente dal lavoro e dallo stipendio (vale a dire che lo riceverebbe anche Luca Cordero di Montezemolo, per fare solo un esempio), il reddito minimo garantito permetterebbe a tutti i cittadini di ricevere una somma (poniamo, 800 euro al mese) nei periodi di inattività, mentre chi ha uno stipendio che non raggiunge una soglia minima riceverebbe un’integrazione. Una modalità, quindi, che permetterebbe al lavoratore freelance che non ha potuto lavorare per tot tempo di ricevere comunque, appunto, un minimo garantito. Si tratta di una soluzione che potrebbe convenire anche all’economia nel suo complesso, visto che dei lavoratori insicuri non saranno mai dei grandi consumatori.
Ma chi lo paga questo reddito minimo? Dal momento che le aziende sono le vere vincitrici di questa rivoluzione e godono di grandissimi vantaggi (una forza lavoro dipendente molto inferiore, collaboratori pagati a prestazione e, in alcuni casi, in base all’efficacia del loro lavoro, niente contributi, niente ferie da pagare, niente malattie, niente assicurazione sul lavoro e anche costi di gestione molto inferiori), si può pensare che siano proprio queste aziende a contribuire, attraverso nuove forme di tassazione, alle risorse necessarie a dare vita al reddito minimo garantito.
In ogni caso, se lo scenario del futuro è quello della on-demand economy, un modo per introdurre il reddito minimo garantito andrà trovato. Per permettere a internet di contribuire alla creazione di un mondo del lavoro che fino a pochi anni fa sembrava solo un’utopia immaginata da fanatici tecno-entusiasti: un mondo in cui libertà e sicurezza economica possano coesistere.


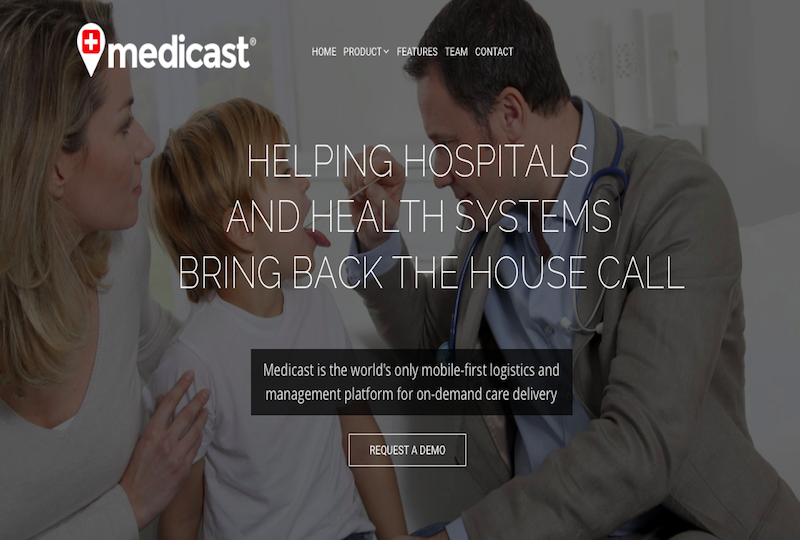
Devi fare login per commentare
Accedi