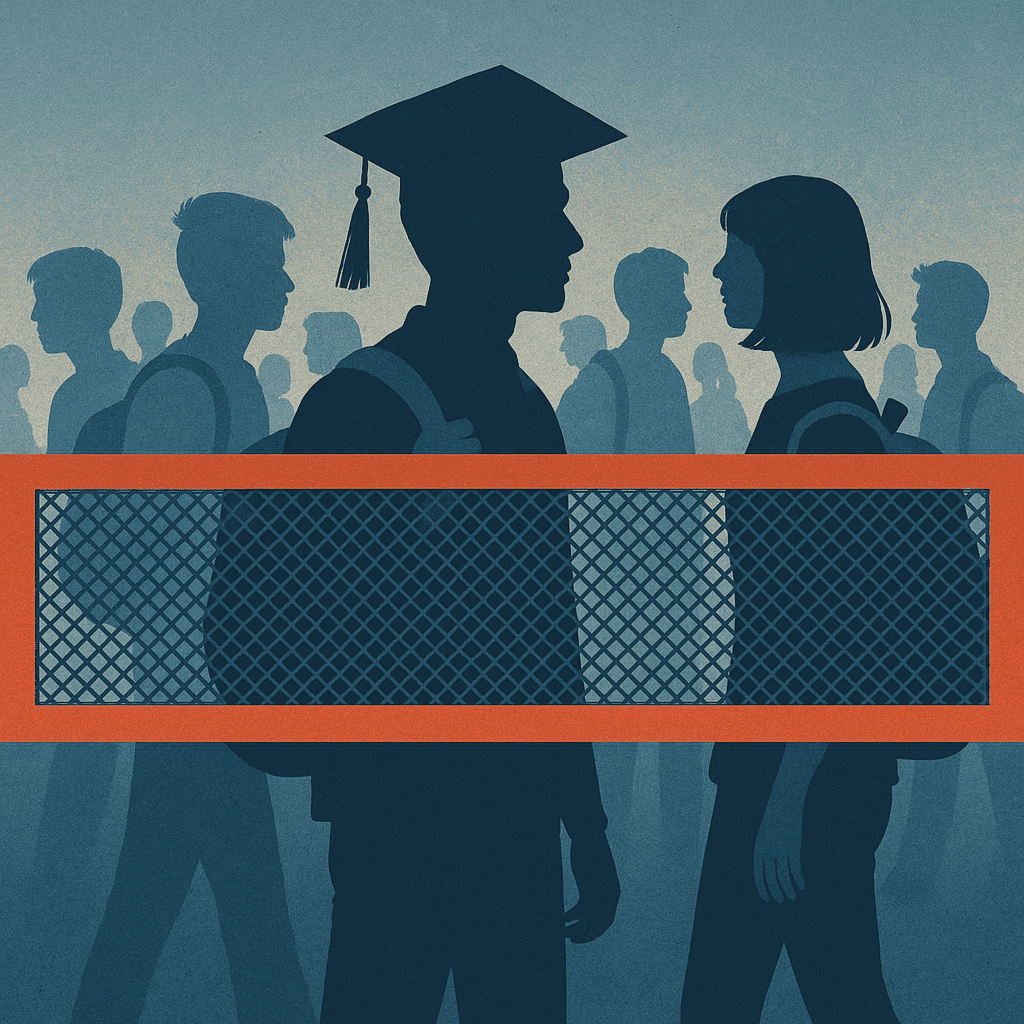
Università
Il semestre filtro non misura il merito: misura la sopportazione
Il semestre filtro promette di superare il test d’ingresso, ma riproduce una selezione a tempo che misura velocità e resistenza più della preparazione. Un modello concorsuale mascherato da didattica, che amplifica disuguaglianze e obbliga alla gestione della scarsità di mezzi
La selezione attraverso il cosiddetto semestre filtro sta suscitando grandi malumori tra chi si sottopone alle prove. Nello stesso tempo sta dando occasione di analizzare il dato, innegabilmente spaventoso, dei risultati nelle materie scientifiche. La conseguente polarizzazione del dibattito, cui partecipano personaggi che hanno necessità di confermare le proprie posizioni presso platee di riferimento, ha espresso da un lato la compassione vagamente pietistica, dall’altro il bullismo del privilegio. In un caso e nell’altro, i giovani che cercano la propria strada in questo paese, risultano pacchi da spostare.
Sgombero da subito il campo: nessun sistema universitario al mondo può selezionare qualità caratteriali quali empatia, capacità relazionale, etica della cura, intelligenza emotiva ex ante. Quindi, evitiamo facili derive sul “giudizio della persona”, impraticabile in quella fase di banale scrematura che si propone qualsiasi test in qualsiasi punto del globo. È certo, però, che le pubblicazioni più autorevoli sul tema ci dicono che nella scelta del personale medico costituiscono predittori affidabili la performance accademica continuativa, la capacità di reggere carichi cognitivi elevati, la costanza, il metodo di studio, la capacità di apprendimento in contesti stressanti. Sono invece predittori deboli i test a scelta multipla isolati, le valutazioni esclusivamente nozionistiche, le prove una tantum ad alta aleatorietà.
Ora, obiettivamente, ciò che può realisticamente fare un sistema pubblico è scegliere i migliori candidati a sostenere un percorso di formazione medica.
Il semestre filtro, così concepito, è però una specie di concorsone mascherato da didattica, con programmi iper nozionistici, carichi concentrati in tempi brevi, carenza di tutoraggio e orientamento.
Che cosa può valutare un test di 45 minuti ripetuto tre volte con 15 minuti di pausa tra l’una e l’altra? Se si tratta di un test che è ad alta densità di quesiti, inserito in una sequenza di prove ravvicinate, può misurare la velocità di elaborazione, la gestione dell’ansia acuta, l’automatismo procedurale, la rapidità decisionale sotto pressione. Certamente non permette di valutare la comprensione profonda, il ragionamento clinico o causale, l’integrazione tra i concetti, la capacità di argomentazione, la struttura del metodo di studio.
Insomma misura una performance da sprinter, quando in medicina si tratta di maratone cognitive e decisionali. Riviste scientifiche illustri parlano di variabilità nei risultati dovute a fattori non rilevanti rispetto alle competenze.
Inoltre, c’è un problema cognitivo: dopo aver effettuato una prova a stress acuto di 45 minuti, nella nuova prova si ha giocoforza un calo dell’attenzione, della ritenzione mnemonica e della capacità di controllo degli errori. Nella seconda prova si può al massimo valutare la resilienza allo stress intenso e immediato.
Parliamo dunque di test concepiti come prove militari, selezioni competitive ad alta pressione in una sorta di contesto emergenziale.
Il semestre filtro dovrebbe dunque valutare l’apprendimento nel tempo, la costanza, l’assimilazione reale dei contenuti ma – così strutturato – riproduce la logica del vecchio test d’ingresso, amplifica la componente aleatoria e basa la selezione sulla velocità e il sangue freddo. Questo, indipendentemente dalla difficoltà delle singole domande.
Si potrebbero scegliere tempi più dilatati, per esempio prove da due ore in tre giorni. Non si fa per ragioni esclusivamente logistiche – visto il numero dei partecipanti – amministrative, di controllo; non si dica, però, che lo si fa per dare ai ragazzi l’opportunità di esprimere quello che hanno assimilato. È un modello pensato esclusivamente avendo in mente la gestione della situazione.
In Francia il filtro è di un anno, gli esami sono distribuiti nel tempo, le prove durano da 1,5 a 3 ore, sono previsti colloqui integrativi. I test sono criticati per la durezza ma non per il tempo o lo stress della prova.
In Germania danno molto peso al voto di maturità, la selezione è più progressiva nell’arco di un anno, le prove scritte sono lunghissime e spesso integrate da prove orali.
In Spagna conta il voto di maturità e poi un esame nazionale. Una volta entrati, non ci sono prove lampo come filtro.
L’Italia è l’unico paese europeo che dichiara di voler superare il test a crocette ma mantiene la selezione su tempistiche da sprint e soprattutto concentrando la decisione in poche ore.
Ma tutto questo non basta a chiarire un punto ancora più centrale.
Il sistema così costruito mantiene e riproduce un classismo strutturale.
Chi supera la prova ha pochi giorni per decidere in quale università andare. Esiste una graduatoria nazionale: chi ottiene un punteggio più alto ha maggiori probabilità di accedere alla sede desiderata, mentre chi si colloca più in basso deve accettare sedi meno ambite o rinunciare del tutto, se i posti disponibili sono esauriti. Ma la sede “desiderata”, nella maggior parte dei casi, non è l’università migliore, bensì quella che la famiglia può permettersi.
Uno studente di Altamura può preferire Bari non per ragioni accademiche, ma per evitare di gravare sulla propria famiglia con i costi di un trasferimento a Udine o a Trieste. La libertà di scelta formale si traduce così in una selezione economica indiretta, che il sistema finge di non vedere.
Meccanismi di attenzione sociale di questo tipo non sono minimamente contemplati dall’attuale assetto politico-universitario. Non perché siano ignoti, ma perché riconoscerli imporrebbe di ammettere una verità scomoda: l’Italia è un paese rassegnato che filtra gli studenti non per scegliere i migliori, ma perché non dispone delle strutture, del personale e delle risorse necessarie a formarne un numero adeguato.
Questo modo di procedere non è un’eccezione. È coerente con una più ampia cultura istituzionale in cui le carriere accademiche vengono spesso costruite attraverso concorsi opachi, nei quali l’esito è noto prima ancora che la procedura abbia inizio. Si dice gli fanno il concorso. È un lessico rivelatore.
La conseguenza culturale è devastante. Chi riesce a passare i filtri tende a percepirsi come legittimato in modo assoluto, anche quando le sue capacità professionali sono nella media. Chi resta escluso, senza poter distinguere tra demerito reale e distorsione sistemica, sviluppa una percezione di persecuzione, di ingiustizia permanente, che alimenta sfiducia, risentimento e talvolta rinuncia.
In questo Paese si è consolidato, nel tempo, un sistema di limitazione della libertà intellettuale e professionale che colpisce in modo particolare chi studia, chi fa ricerca, chi investe sul merito come processo e non come etichetta. Troppo spesso le aspirazioni si trasformano in illusioni, e il messaggio implicito diventa chiaro: per avanzare non basta essere competenti, occorre consegnare una parte della propria autonomia a un protettore, evitare di disturbare equilibri già definiti, non pestare i piedi sbagliati.
Questa cultura è ormai così interiorizzata da aver modificato il senso stesso dell’impegno. Invece di credere in sé stessi o di costruire, con il lavoro, le condizioni perché qualcuno possa credere nel proprio valore, si finisce per cercare il favore giusto, l’intermediazione opportuna, la protezione necessaria. Oppure ci si arrende.
Anche il superamento del semestre filtro, in questo contesto, non rappresenta una conquista di libertà, ma soltanto l’ingresso in un sistema che continua a confondere selezione con gestione della scarsità, merito con adattamento, formazione con controllo.



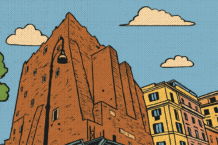

Devi fare login per commentare
Accedi