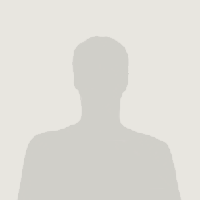E’ TROPPO TARDI PER CAMBIARE L’ITALIA?
Mentre avanzavamo lenti nel traffico di Torino, il taxista che tentavo di pungolare con insistenza sulle cosiddette “lenzuolate” di Bersani – essendo a livello mondiale uno dei settori protetti dimostratisi più impervi alla liberalizzazione, non si sale mai su un taxi solamente per andare da un punto A ad uno B (e poi per quello ormai c’è Uber), ma anche e soprattutto per studiare “l’avversario”, cercare di capire come ragiona, trovarne i punti deboli… – il taxista, dicevo, fece una considerazione piuttosto illuminante, si parlava di portabilità dei mutui e relativa surroga,
“a me sta anche bene portare il mio mutuo altrove e rifinanziarlo senza costi aggiuntivi – disse -, ma ho paura che, se incominciano a prendersela con le “categorie”, ora sono le banche, poi saranno i farmacisti e poi i notai… prima o dopo – più prima che dopo -, verranno a rompere i coglioni anche a me, ci hanno già provato; e se gli dai l’impressione che è facile poi è finita e ci fregano tutti”.
Di fatto, egli stava tratteggiando una sorta di solidarietà preventiva tra protetti (e/o sussidiati, sui quali è facilmente trasferibile il medesimo ragionamento), il timore che se tocca in qualche modo al tuo vicino, prima o dopo, toccherà anche a te, tanto da finire a battersi per un sostanziale immobilismo sistemico.
Questo episodio mi è tornato alla mente da poco, quando ho scoperto una storia di mancate riforme che viene dall’Olanda (paese in cui trascorro molta parte del mio tempo), ma è forse utile anche per capire un po’ meglio l’entità dell’ostacolo che ha davanti chiunque voglia seriamente provare a cambiare l’Italia.
Nella città di Amsterdam, caso unico al mondo in tali dimensioni, circa il 56% dello stock immobiliare residenziale appartiene direttamente od indirettamente (attraverso cooperative sussidiate) al settore pubblico. Accanto ad esso, convivono, poi, circa un 25% di immobili owner-occupied (cioè di proprietà di chi vi risiede) ed una restante parte in teoria disponibile per l’affitto “libero”, e tuttavia regolata attraverso un intricatissimo metodo di rent control basato su punteggi stabiliti da apposite commissioni, la cui complessità e, per molti versi, arbitrarietà farebbe invidia al più fantasioso e contorto burocrate di qualche ministero romano.
In sostanza, dunque, per quasi due terzi del settore residenziale i consueti meccanismi di mercato sono bloccati, e lo stock di social housing, quel 56% che noi normalmente chiameremmo “case popolari”, di popolare ha spesso ben poco, poiché a) una grossa fetta di esso (almeno metà) si trova non già in qualche precaria periferia, ma disseminato nei migliori quartieri del centro cittadino e tende ad essere di qualità medio-alta, b) chi ci abita, ormai, spesso e volentieri si trova molto al di sopra di una ragionevole soglia di difficoltà economica (ci troviamo in una delle regioni più ricche d’Europa per reddito pro capite).
Storicamente, la giustificazione alla base di un simile impianto è stata duplice: da una parte, quella di evitare il fenomeno del ghetto cui spesso (sempre?) l’edilizia popolare finisce per ricadere, dall’altra, di mantenere nei vari quartieri una maggiore e feconda diversità sociale, contrastando, così, a monte il noto fenomeno della (più o meno spinta) gentrificazione.
Il problema, oggi, è che ciò che da tale motivazione (per certi versi nobile – non di rado accade che, nel tempo, alcune delle peggiori storture si generino a partire dalle migliori intenzioni) aveva preso le mosse, evolvendosi come per inerzia è andato ben oltre, giungendo di fatto a garantire ad ampi strati di popolazione abitazioni centrali a prezzi spesso anche del 60/70% al di sotto di quelli che il mercato richiede(rebbe) nei pochi segmenti dove è lasciato libero di operare e, soprattutto, finendo per slegare in numerosissimi casi il possesso dell’abitazione dal profilo reddituale e di bisogno reale, fino ad esporsi ai più ricercati e diffusi illeciti: appartamenti tramandanti da genitori ai figli senza alcun controllo, scarsissima mobilità (chi ha ricevuto uno di questi appartamenti se lo tiene ovviamente ben stretto), subaffitti illegali a prezzi (quasi) di mercato, e, più di recente, persino cooperative sociali che hanno preso a fare affari immobiliari spericolati ed a farli in modo non sempre trasparente, spingendo i costruttori privati a denunciare presso la Commissione Europea la presenza di aiuti di stato illegali.
In breve, un sistema fattosi ingiusto e costoso, a fronte di risorse divenute più scarse anche lungo le rive dell’Amstel ed all’assurdità di utilizzarle per garantire appartamenti con due camere da letto nel centro di Amsterdam per 400 euro al mese a famiglie con un reddito in non pochi casi ben superiore ai 40.000 euro/anno, quando si potrebbero finanziare programmi ben più vantaggiosi per la collettività (o ridurre la pressione fiscale),
Eppure, nonostante da più parti si riconosca apertamente la non desiderabilità (ed insostenibilità) dell’assetto corrente, fatta eccezione per alcuni cambiamenti al margine, esso si è rivelato impervio ad ogni tentativo vero di cambiamento.
Per cominciare, una riforma seria consisterebbe nel togliere la casa sussidiata a decine di migliaia di famiglie o, nell’attesa che trovino un’altra sistemazione (e molto difficilmente negli stessi quartieri), raddoppiare o triplicare i loro affitti al momento calmierati, e ciò è politicamente difficile. Ma il punto è anche un altro: perché, se è vero che esistono, come sempre in questi casi, degli esclusi che, prima facie, dovrebbero avere tutto l’interesse ad abbattere il sistema, per un verso, essi non riescono ad avere consistenza numerica sufficiente per incidere (giovani) oppure non votano (come la nutrita schiera di expat che vive in città e si confronta con prezzi delle locazioni esorbitanti), dall’altro, come sottolineava di recente uno sbigottito giornalista inglese, “essentially everyone has a friend, or parent or relative, living in social housing”, e ciò rende assai meno chiari e definiti gli incentivi in campo.
Senza contare che anche chi, in base a meri parametri reddituali, avrebbe diritto a conservare la propria abitazione, sa che un conto è avere magari diritto ad una casa, ben altro ad averne una a Brera o in via Condotti, e dunque percepisce, non a torto, la ridiscussione del sistema come una minaccia col potenziale di sbalzarlo dai piacevoli dintorni del Sarphati Park in qualche periferia (è circolata, ad esempio, l’ipotesi di dismettere gli immobili centrali di grande valore ed impiegare le risorse per costruirne di nuovi in aree meno centrali, così da ampliare l’offerta ed includere anche chi magari non era ancora nato quando distribuivano i biglietti alla lotteria della casa).
Il problema, insomma, non è la consapevolezza da parte dei decisori pubblici di ciò che non va né (almeno sulla carta) l’assenza di volontà, ma il fatto che il fardello della legacy è ormai tale da rendere molto improbabile, forse quasi impossibile, coagulare consenso riformatore, il problema è il modo in cui si sono strutturati e sedimentati gli interessi nel tempo, e non dipende nemmeno più dalla qualità delle istituzioni o della classe politica.
Anche nel migliore dei paesi, “riprendersi” ciò che si è distribuito senza pensare alle conseguenze future, quando il futuro infine arriva è compito improbo, aggravato dal fatto che decenni di consuetudine hanno sostanzialmente convinto la gente che ricevere certi benefici/privilegi sia una sorta di diritto acquisito e/o fondamentale.
Fortunatamente per l’Olanda, questo è un caso sì rilevante (e molto dibattuto), ma tutto sommato isolato, in una realtà economica che, complessivamente, funziona comunque bene, cresce, attrae capitale umano qualificato, ha una tassazione d’impresa favorevole, un livello di servizi di buona qualità ed un alto tasso di occupazione (in particolare femminile).
Cosa succede, invece, se un “sistema di elargizione” analogo nei suoi meccanismi di fondo diventa pratica corrente su vasta scala, snodandosi nei decenni, fino a creare coorti di protetti, sussidiati e garantiti nei contesti più disparati, se “essentially everyone has a friend, or parent or relative” con una pensione fortemente disallineata dalla contribuzione o il cui reddito dipende in buona misura dal mantenimento dei sussidi statali per il settore/l’azienda in cui opera/lavora o dalla conservazione di barriere artificiali all’ingresso del proprio ambito di attività, etc?
Succede che ci si trova in condizioni ben più serie, e si comincia a comprendere meglio la difficoltà di reperire vero supporto per le riforme attraverso il normale processo democratico; succede che l’estensione ed il peso dell’eredità accumulata sono forse tali da non trattarsi nemmeno più della “semplice” (e molto studiata) presenza di agguerriti ma numericamente minoritari gruppi organizzati pronti a difendere i propri interessi, bensì di un equilibrio complessivo, che ormai coinvolge probabilmente la maggioranza delle persone, individualmente razionale, ma collettivamente mortale, equilibrio che, anche qualora un giorno si trovasse il più preparato e meglio intenzionato dei governi, assenti eventi traumatici (esterni od interni), c’è il caso sia ormai troppo tardi per rovesciare.
Nessun commento
Devi fare per commentare, è semplice e veloce.